Cultura
Una memorabile cena con Proust e tanta joie de vivre
Paola Cerana ci conduce per mano in un viaggio nel pensiero e nell’animo di una figura straordinaria e fascinosa. L'atmosfera è da belle époque parigina, tra eccessi e fermenti artistici e scientifici mescolati a vizi personali e pubbliche virtù
14 novembre 2009 | Paola Cerana

A tutti coloro che si sentono ardenti proustiani come me, consiglio un libro che ha il dono di annullare il Tempo, anzi di riavvolgerlo magicamente all’indietro fino ad una notte di maggio del 1922 e di trasportarci, invisibili, accanto a Marcel Proust, durante una memorabile cena in uno dei più grandi hotel di Parigi. Questo libro s’intitola Una notte al Majestic e l’ha scritto, in maniera palpitante, uno storico inglese, Richard Davenport-Hines, il quale deve aver subito lo stesso incantamento che invade me ogni volta che scorro le pagine della Recherche du temps perdu.
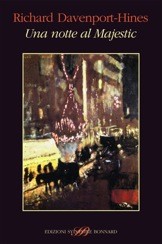
Non si tratta di una semplice biografia, né di un’arida cronistoria della vita travagliata e contraddittoria di un genio della letteratura. E’ molto di più. E’ un viaggio nel pensiero e nell’animo di un uomo, un’esplorazione emozionante che conduce chi legge a condividere con lui angosce, curiosità e speranze, insaporite da un contesto storico di straordinaria effervescenza intellettuale.
Leggendo queste pagine mi è sembrato d’essere a teatro e di assistere alla messa in scena di un mondo affascinante, quello della Belle époque parigina, di cui ho potuto respirare gli eccessi, gustare i fermenti artistici e scientifici mescolati ai vizi personali e alle pubbliche virtù, che s’intrecciavano morbosamente nel sottobosco di una società densa di joie de vivre. E mi è sembrato di vedere lui, Proust, che dal silenzio della sua stanza ovattata, in Rue Hamelin 44, osserva, annusa, annota, esplora e dipinge con le parole l’atmosfera del suo tempo, quasi senza uscire mai di casa. Quasi, però. Perché Proust, se pur malato e ossessionato dalla sua stessa malattia, era anche un uomo di mondo, bramoso, ipersensibile e ingordo di sensazioni. Così, nei rari momenti in cui si sentiva in forze e l’asma gli dava tregua, amava frequentare salotti e partecipare a ricevimenti affollati, circondandosi di ammiratori e ammiratrici, anche per studiarne più da vicino quei comportamenti, quei dettagli e quelle sfumature che animano tutta la sua opera.
La società bohémienne che Proust descrive era un tessuto preziosamente ricamato, fatto di ricchi signori, intellettuali ambiziosi e nobildonne ossequiose, ma anche di devoti valletti, lacchè, camerieri, autisti e portieri. Proust, infatti, era attratto dai lavori della servitù, dalle consuetudini apparentemente di poco conto, perché gli davano il gusto di frugare, con rispetto, nei piani bassi di una casa e di penetrarne i più intimi segreti. Da lì risaliva poi, con minuziosa attenzione, ai piani alti, gradino dopo gradino, per spiare negli anfratti dell’aristocrazia viziosa e un po’ snob, mettendone così a nudo difetti e umane debolezze.
Tutti questi ingredienti, di cui Proust si cibava per scrivere, sono concentrati in un evento storico, descritto in maniera seducente nel libro di Davenport. Il 18 maggio del 1922, lo scrittore venne infatti invitato ad una cena molto importante, organizzata da una coppia di ricchi e colti inglesi, gli Schiff, all’Hotel Majestic di Parigi.
L’evento fu memorabile, non solo perché celebrava la prima del balletto burlesco di Stravinsky, Le Renard, ma soprattutto perché riunì, in una cornice sontuosa e sfavillante, l’elite culturale modernista di quell’epoca. Fu così che una cena di gala si tramutò in un capolavoro di vita mondana e pare che Proust, nonostante la salute vacillante, non volesse assolutamente perdersi quella golosa occasione, per poter abbeverarsi di sensazioni che avrebbe poi riversato nella sua grande opera letteraria.
La cosa straordinaria fu che allo stesso tavolo dell’immenso salone si trovarono seduti cinque tra i maggiori esponenti della cultura e della creatività di quegli anni: Serge Diaghilev, il direttore dei Balletti russi; Igor Stravinsky, il rivoluzionario compositore; Pablo Picasso, il genio della pittura; James Joyce, l’ardito romanziere irlandese; e naturalmente lui, il grande, unico Marcel Proust. Quella era la prima sera in cui usciva, dopo settimane di reclusione quasi ascetica nella sua stanza da letto, dovuta ad una dose eccessiva di adrenalina che gli aveva bruciato la gola. Era all’apice della sua fama in quell’anno e fu un onore per i coniugi inglesi godere della sua presenza e sfoggiarlo come fiore all’occhiello della loro importanza sociale.
Forse, però, gli Schiff non avevano valutato bene gli effetti collaterali sortiti dal pretenzioso accostamento di due grandi romanzieri, quali Joyce e Proust, due personalità così lontane ed eccessive, sia nello stile letterario che nel temperamento. Fu come liberare due belve nello stesso recinto. Quella fu l’unica occasione in cui i due s’incontrarono e non solo per via del poco Tempo che a Proust era ancora concesso di vivere. La verità è che quei due proprio non si piacevano e fin dal primo istante la spontanea antipatia reciproca fu evidente, con divertito imbarazzo, a tutti i commensali. Queste pagine del libro sono deliziose e affascinanti. Mi è sembrato davvero d’essere lì, di percepire i profumi dei cibi serviti, di origliare i pettegolezzi e i mormorii, e di rubare gli sguardi furtivi scambiati tra baldanzosi signori e dame falsamente ritrose.
Il menu, accuratamente scelto da Mr. Schiff, richiamava i gusti e i sapori della Recherche, di cui lui era un appassionato stimatore. Cercò, quindi, di trasferire anche a tavola le nuances care a Proust, confidando nella sua amicizia e gratitudine. Gli stuzzichini erano dei magnifici crocque-monsieur, fragranti crostini al formaggio da accompagnare a uova impanate. C’erano poi gli asparagi, che lo scrittore aveva giocosamente descritto nella sua opera fino a fare trasudare da quelle righe tutto il bello e il buono di quella verdura. Anche i tagli delle carni erano proustiani, dalla coscia di montone in salsa bérnaise, al boeuf à la gelée speziato, al pollo financière al Madeira. E per dessert, le preferenze proustiane lasciavano solo l’imbarazzo della scelta: ananas con macedonia tartufata, budino di castagne insaporito al kirsch, dolce di mandorle, gelato di caffè e pistacchio e mousse di fragole. Il tutto allegramente accarezzato da abbondante champagne.
Un banchetto, insomma, che avrebbe dovuto solleticare i desideri di tutti e alleggerire gli animi. Eppure qualcosa d’imprevedibile accadde quella notte. Joyce era arrivato tardi, perché non aveva un vestito da sera e aveva alzato un po’ il gomito per vincere il nervosismo. Pare che l’idea d’incontrare il romanziere francese in piena ascesa professionale lo facesse sentire irrimediabilmente insicuro. Era alticcio, un po’ maldestro e non sempre garbato, tanto che a un certo punto durante la cena si appisolò e cominciò a russare, sopraffatto dall’opulenza del banchetto. Proust, invece, fece un ingresso spettacolare. Era impeccabile, elegantissimo dentro la sua pelliccia, gli immancabili guanti bianchi e il bastone che reggeva in mano come uno scettro. Aveva un’aria regale, tale da mettere soggezione.
“Un’abbondanza di capelli castano scuri, un viso pallidissimo, occhi come lacca giapponese. Entrò sbattendo le palpebre come un uccello notturno, guardò gli astanti con l’espressione stupita di un convalescente che riprende vita, scrutò gli angoli e i recessi della sala e, dopo qualche momento, si sedette.â€
Da subito Proust, con la sua straripante intelligenza e il suo garbo delicato, calamitò l’attenzione e condusse la conversazione come un vero direttore d’orchestra. Soprattutto con Joyce. Gli animati scambi di battute tra i due furono carichi di tensione durante tutta la cena, i dialoghi sfidanti e taglienti, i battibecchi fatti di continui ‘no’, sferrati come palle da tennis lanciate da dispettosi servizi.
“Non ho mai letto le sue opere, Mr. Joyce.â€
“Nemmeno io ho mai letto le sue, Monsieur Proust.â€
Insomma, un estenuante duello, che si protrasse persino dopo la cena, a notte inoltrata, quando Proust, offrendo un passaggio in automobile agli Schiff, fu costretto a sorbirsi anche l’invadente compagnia del suo cocciuto rivale, curioso forse di intrufolarsi nella vita privata del romanziere francese. Il tragitto dall’Hotel alla casa di Proust durò una manciata di tormentati minuti, in cui Joyce volle a tutti i costi fumare e aprire il finestrino dell’auto, offendendo così la delicata salute del suo ospite, che temeva, notoriamente, le correnti d’aria e il fumo.
Il molesto intruso, una volta giunti davanti alla soglia di Rue Hamelin, venne elegantemente liquidato e fatto accompagnare alla propria abitazione del solerte autista Odilon Albaret, mentre gli amici Schiff trascorsero l’intera notte nell’appartamento di Proust, tra chiacchiere, confidenze e champagne.
Leggere queste pagine di vita è stato per me come spiare attraverso il buco della serratura di un’immensa stanza incantata. Al di qua ci sono io, curiosa e desiderosa di stupirmi di un mondo che, purtroppo, non mi è appartenuto ma in cui sento che mi sarei destreggiata con disinvolto piacere; al di là uno spazio, o meglio un Tempo, forse perduto ma che io ritrovo sempre, tutte le volte che sfoglio l’opera di Proust. Quel ricevimento resta memorabile, scolpito nella storia, e rievoca personaggi talmente grandi che finirono inevitabilmente per escludersi a vicenda, rosi dalla gelosia, dall’invidia e dalla nostalgia. Ma quella notte al Majestic segnò anche l’inizio dell’inesorabile declino fisico di Proust.
L’occasione successiva in cui molti di quegli ospiti si ritrovarono riuniti insieme, fu esattamente sei mesi dopo. Non più accomodati attorno ad una tavola ma accodati nella lunga processione, aperta dai neri cavalli che trainavano il carro funebre color ebano, con il corpo di Proust racchiuso nel suo tetro feretro. Parigi, nel giorno del funerale di Proust, sembrava immobile, imbalsamata in un’atmosfera surreale che pareva voler evocare più che mai le associazioni e i richiami della Recherche. Il corteo sfilava muto lungo gli Champs-Elysées, ripercorrendo i luoghi di Swann, dei Guermantes, di Madame Verdurin, e dell’amante Albertine. Tutti insieme per un ultimo commosso inchino al loro creatore.
“Proust scrisse la parola ‘fin’ sull’ultima pagina di Temps retrouvé e poi morì.â€
“Da morto pareva davvero bello, come se il Tempo non avesse osato toccarlo, lui che l’aveva addomesticato e vinto.â€
Era il 18 novembre del 1922 quando Proust morì e quello stesso giorno, sbocciato con un insolito mattino solatio, le vetrine illuminate dei vivaci boulevards di Parigi esponevano già i primi volumi della Recherche, E il riflesso di quelle luci non trasmetteva solo l’immagine di un Tempo ritrovato ma la certezza di una conquistata Eternità .

Potrebbero interessarti
Cultura
Il commercio di olive da tavola nel Mediterraneo orientale durante l'antichità

Il confronto con una raccolta di riferimento moderna estesa di 57 varietà coltivate e 15 popolazioni selvatiche di oliva di varie origini ha rivelato che un morfotipo principale domina il carico del naufragio Mazotos, integrato da altri tipi in quantità minori
13 marzo 2026 | 11:00
Cultura
Olio extravergine e musica classica: quando il gusto incontra l’armonia

Un gioco affascinante: associare una grande pagina della musica classica alle principali varietà di oliva, come se ogni olio avesse la propria colonna sonora. La personalità forte della Coratina richiama l’emozione del celebre coro Va, pensiero
12 marzo 2026 | 10:00
Cultura
Ecco cosa mangiavano gli italiani 2700 anni fa

Nei campioni di tartaro dei denti ritrovati sono state trovate tracce di cereali, legumi, fibre vegetali e spore di lieviti, elementi che indicano una dieta piuttosto varia e suggeriscono anche il consumo di alimenti fermentati come pane, vino e birra
06 marzo 2026 | 10:00
Cultura
Sfruttamento e gestione dell'olivo nel Mediterraneo durante la preistoria

Grazie a campionamenti di legno in siti archeologici è stato possibile distinguere tra fasi distinte nell'utilizzo dell'olivo. La storia inzia con esclusivo sfruttamento di giovani rami e ramoscelli per legna da ardere per arrivare nell'età del bronzo alla potatura per ottenere produzione di olive
03 marzo 2026 | 11:00
Cultura
Intorno alle origini e al significato delle parole: oliva, ulivo e olio

Da elaion a oleum, una denominazione che è poi rimasta anche quando sono stati utilizzati oli proveniente da altre piante, non solo nelle lingue neolatine, olio in italiano, huile in francese, oleo in spagnolo, ma anche nelle lingue germaniche
06 febbraio 2026 | 12:00 | Giulio Scatolini
Cultura
Gli agronomi medioevali dell'ordine religioso degli agostiniani

L’ordine agostiniano ha costruito il suo potere attraverso miracoli agronomici: ripristinare la terra sterile, guarire il bestiame, far rivivere alberi da frutto. Questi atti hanno aiutato le comunità rurali a sopravvivere e hanno dato legittimità all'ordine
05 febbraio 2026 | 11:00





