Cultura
Scopriamo l'Itrana, varietà pluripremiata in tutti i concorsi oleari nazionali

E' l'anno dell'Itrana e quindi è bene scoprirne il segreto. La scoperta dei profumi e del senso dell'Itrana quando si è cominciato a lavorare le olive verdi, sottocalibri della lavorazione in oliva da tavola "bianca"
26 giugno 2025 | 16:00 | Giulio Scatolini
Ha senso oggi parlare dell’analisi sensoriale dell’Itrana?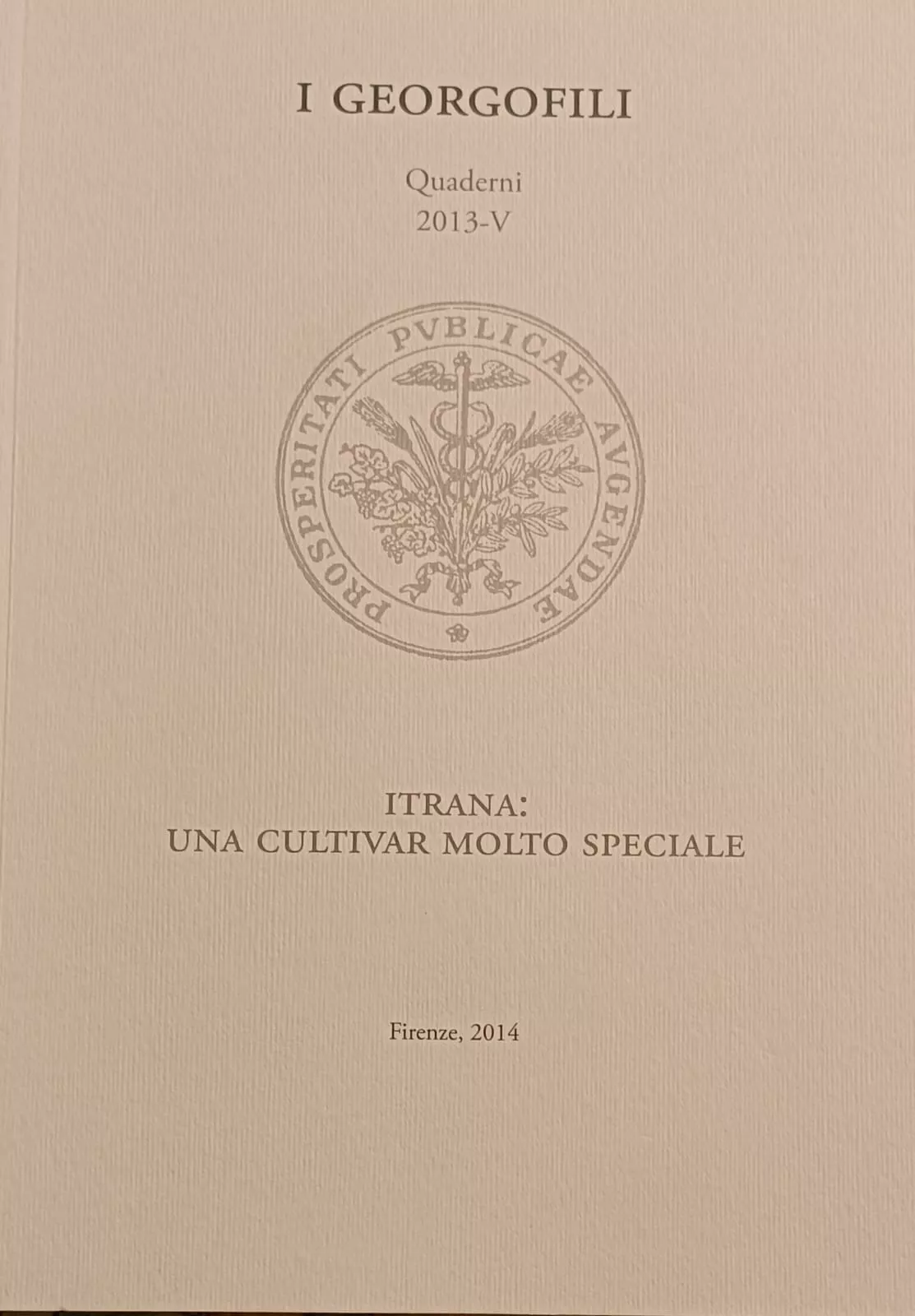 Iniziamo con il dire che un prodotto a denominazione d’origine ha un motivo di esistere solo se la sua valenza economica è superiore ad alcuni limiti, perché i processi di monitoraggio, rintracciabilità, certificazione, a esso legati, hanno dei costi che sono legati non solo alla spesa che fa l’agricoltore o l’imprenditore, ma sono dei costi che ricadono anche sulla comunità, in quanto un disciplinare Dop riconosciuto prevede tutta una serie di impegni burocratici/lavorativi del Ministero, della Comunità Europea, della Commissione; costi che ricadono quindi sulla intera comunità-collettività; e consequenziale quindi che la Dop, se non si raggiungono alcuni numeri critici nella commercializzazione, ha dei costi troppo elevati rispetto ai possibili benefici raggiungibili.
Iniziamo con il dire che un prodotto a denominazione d’origine ha un motivo di esistere solo se la sua valenza economica è superiore ad alcuni limiti, perché i processi di monitoraggio, rintracciabilità, certificazione, a esso legati, hanno dei costi che sono legati non solo alla spesa che fa l’agricoltore o l’imprenditore, ma sono dei costi che ricadono anche sulla comunità, in quanto un disciplinare Dop riconosciuto prevede tutta una serie di impegni burocratici/lavorativi del Ministero, della Comunità Europea, della Commissione; costi che ricadono quindi sulla intera comunità-collettività; e consequenziale quindi che la Dop, se non si raggiungono alcuni numeri critici nella commercializzazione, ha dei costi troppo elevati rispetto ai possibili benefici raggiungibili.
Diciamo prima di tutto quindi che “sicuramente l’Itrana ha questi numeri”, verificabili oggettivamente con i dati della filiera: il numero delle piante presenti nei comuni, circoscritti dal disciplinare dop Colline Pontine, è pari a 3 milioni; di questi il 70% è rappresentato da olivi di cultivar Itrana; questo è un fatto altamente significativo, perché spesso ci dimentichiamo che un prodotto a denominazione di origine deve avere una accertata tipicità.
Tipicità e denominazione di origine infatti non sono proprio coincidenti, perché un prodotto tipico è «un prodotto che si riesce a riconoscere, attraverso l’analisi chimica, sensoriale e visiva anche in condizioni non ideali»; potremmo allora dire che un prodotto tipico è anche la Coca Cola perché assaggiando la Coca Cola, anche al buio, riesco a riconoscerla.
Questo ci porta a dire che non tutti i prodotti tipici, in senso stretto di definizione, sono a denominazione di origine. Tutti i prodotti a denominazione di origine dovrebbero invece essere tipici; questa è, in verità, un po’ la mancanza, il punto debole del sistema nazionale della denominazione d’origine: spesso, in Italia, ci sono delle denominazioni che non hanno nulla di tipico. Allora: «Perché un consumatore dovrebbe pagare un prodotto di più, solo perché è fatto su quel territorio, ma non è riconoscibile da un punto di vista sensoriale o qualitativo?». In un momento di crisi economica questa cosa non va a buon fine.
L’Itrana, invece, oltre ad avere i numeri per la produzione ha una sua tipicità, un suo sentore-marker particolare che si è potuto evidenziare nel riconoscimento della Dop Colline Pontine che la Comunità Europea ha dato a questa denominazione, a dimostrazione che il disciplinare dell’Itrana è forse il disciplinare meglio scritto, almeno sugli oli a denominazione d’origine, tra tutti quelli attualmente pubblicati.
Infatti un olio a denominazione d’origine oltre a essere di quel territorio, deve essere di qualità superiore alla media dell’olio del territorio. Quindi oltre ad avere un numero di perossidi inferiore a 12, ad avere un’acidità inferiore di 0,6, oltre ad avere i polifenoli superiori a 100 e l’acido oleico superiore a 72, e questo è ciò che può essere definito un olio di grande qualità, l’olio Dop Colline Pontine, ha dei descrittori sensoriali ben definiti che nella maggior parte dei disciplinari degli oli a denominazione d’origine sino a oggi non sono stati evidenziati.
Questi attributi sono: fruttato d’oliva da 4 a 7, quindi in un range ben definito, l’amaro tra il 3 e il 5, il piccante da 3 a 5, ma soprattutto il sentore del pomodoro, che è la caratteristica tipica/marker dell’Itrana, deve essere contemplato tra 3 e 6.
È perciò un profilo sensoriale ben definito, che la maggior parte di tutti gli altri disciplinari blasonati dell’olivicoltura italiana attualmente non hanno e che dovrebbe essere in qualche modo di esempio per rivedere un po’ tutti questi disciplinari privi di reali marker-descrittori.
Il problema è ora tuttavia di valutare se le denominazioni sono un bambino o un nano, perché se i quantitativi di prodotto certificato, venduto e commercializzato non crescono, il rischio è che la Dop sia solo un nano e che il senso dell’itrana quindi tutte queste spese, questi sforzi di promozione, di commercio risultino inutili per la comunità nel suo insieme, perché come già riferito, dietro una certificazione Dop non c’è solo il costo che sostiene direttamente il produttore, ma anche i costi delle istituzioni nazionali e comunitarie che si trovano in un momento di forte crisi economica e di “spending review”
A dimostrazione che il tempo dell’Itrana è tuttavia quello giusto, perché come diceva Marcel Proust «niente è più forte di un’idea di cui è venuto il tempo», lo dimostra il fatto che mentre il Pil nazionale decresce dello 0,6% trimestralmente con una proiezione annua al -2,4, le vendite dell’Itrana ogni anno aumentano e di certo non è cosa di poco conto vedere, in un momento di crisi, crescere i quantitativi di prodotto certificato e commercializzato.
Sicuramente è questo il momento giusto! Sapete infatti che la parola crisi in cinese è scritta con due ideogrammi, uno che significa pericolo e l’altro che significa opportunità.
Insomma, i momenti di grande crisi economica sono anche grandi momenti di opportunità e penso che quella dell’agricoltura dei prodotti tipici sia una grande opportunità per ridimensionare questa politica ed economia della carta e dei bottoni premuti che in un istante permettono di guadagnare o di perdere miliardi di euro. Dare il valore ai veri prodotti agricoli dei territori invece significa anche ridare valore aggiunto a tutte le cose importanti reali e concrete.
Sapete che, nell’analisi sensoriale dell’olio, esistono 3 gradi di fruttato, leggero, medio e intenso.
È naturale che la collocazione dell’Itrana è più nel fruttato medio-intenso.
Fare un Itrana dal fruttato leggero è difficile perché bisognerebbe raccoglierla molto tardi, verso febbraio, perché l’altra grande forza di questo albero meraviglioso è che essa ha una maturazione molto lenta.
L’Itrana fino a 5 anni fa era conosciuta come oliva da mensa ma commercializzata con il nome “Oliva di Gaeta”, di colore nero, perché normalmente viene raccolta per fare la Gaeta nel mese di marzo. Questo significa che, come accennato sopra, questa cultivar riesce a rimanere attaccata all’albero in maniera significativa, senza essere soggetta alla cascola da parte degli agenti atmosferici, che durante la stagione invernale sono molto pesanti, fino a marzo.
Quindi, appunto, ha una maturazione molto lenta.
La raccolta ottimale dell’Itrana può essere fatta quindi in un periodo più lungo facilitando così sia l’abbassamento dei costi economici sia l’ottimizzazione delle operazioni colturali nei campi e di quelle tecnologiche all’interno del frantoio.
Ma per quale motivo fino a oggi l’olio di Itrana era sconosciuto? Perché l’oliva da mensa ha un valore superiore all’oliva da olio, quindi lo scarto che veniva preso sulla Gaeta, che veniva raccolta a marzo, era uno scarto che dava un olio che non era un grande olio e il prezzo ne risentiva. Tutto è andato cambiando quando la commercializzazione ha iniziato a riguardare anche l’Itrana bianca, che viene raccolta verso la fine dell’anno permettendo di mettere a lavorazione per l’olio il “sottocalibro” verde.
Ci si è accorti allora che questo olio dava profumi e sentori intriganti e particolari che hanno permesso perciò di farlo conoscere in tutto il mondo, perché l’Itrana è ormai una varietà conosciuta in tutto il mondo, avendo vinto un po’ tutti i premi più importanti sull’olio sia a livello nazionale che internazionale.
Ecco vorrei allora chiudere ancora con alcune provocazioni.
Il nostro olio, non solo di Itrana, ma il nostro olio italiano non potrà mai essere una commodity! Questa è la differenza sostanziale storica, culturale, agronomica, paesaggistica, che abbiamo con i nostri cugini spagnoli: per loro l’olio è una commodity, per noi non può esserlo, essendo considerato addirittura un prodotto prezioso e quasi sacro.
Per noi il ghiaccio neve è ghiaccio neve; gli eschimesi invece hanno 52 termini per indicare la neve perché per loro essa è tanto speciale. Bene penso che noi dovremo fare altrettanto sull’olio e non svalorizzarlo.
Quali sono questi concetti che dobbiamo realizzare per valorizzare questo nostro olio?
Il rispetto delle tradizioni, la qualità, l’innovazione e le nuove filosofie di mercato.
Questi concetti vanno necessariamente coniugati con verbi “di azione di futuro attuale”, ossia si devono mettere subito in atto.
Quindi nel concetto “rispetto delle tradizioni” il verbo da coniugare è “rispettare”; nel concetto di “qualità” il verbo da utilizzare è “crescere”, perché la qualità non è un concetto statico ma bensì dinamico; nel concetto di “innovazione” ii verbo da utilizzare è “investire”; nel concetto “nuove filosofie di mercato”, il verbo da coniugare è “inventare”.
Diceva qualcuno che «gli ostacoli sono quelle cose terribili che si vedono quando si distoglie lo sguardo dall’obiettivo». Ebbene essenzialmente il nostro obiettivo è di vivere con dignità il nostro lavoro, l’agricoltura e quindi di essere rimunerati, per essa, in modo adeguato, perché “la qualità resterà per molto tempo dopo che ci saremo scordati del prezzo”. Questa è l’altra ossessione.
Penso che sull’olio extravergine di qualità si possa ancora spendere qualche lira. Quindi utilizziamo l’olio extravergine d’oliva perché l’olio extravergine è essenzialmente un prodotto che fa bene alla salute e che ci piace e che fa bene ed è piacevole.
L’ultima provocazione è quella di una frase di un economista austriaco e la rivolgo con preghiera di attenzione agli agricoltori perché gli agricoltori per definizione sono conservatori e quindi per loro è più difficile metterla in atto: «Ogni impresa che continua a essere semplicemente gestita, seppur con la massima competenza, se non si trasforma continuamente e non si adatta ai nuovi compiti e situazioni, perde con il tempo qualsiasi significato e alla fine è destinata a scomparire».
Se da una parte quindi l’olivicoltura significa tradizione, storia, cultura, dall’altra dobbiamo per essa tener conto anche dell’innovazione tecnologica che ci fa guadagnare da un punto di vista salutistico e dall’altro soprattutto sulla qualità sensoriale, perché… «l’analisi sensoriale è la sintesi ideale tra il piacere della conoscenza e la conoscenza del piacere».
Potrebbero interessarti
Cultura
Intorno alle origini e al significato delle parole: oliva, ulivo e olio

Da elaion a oleum, una denominazione che è poi rimasta anche quando sono stati utilizzati oli proveniente da altre piante, non solo nelle lingue neolatine, olio in italiano, huile in francese, oleo in spagnolo, ma anche nelle lingue germaniche
06 febbraio 2026 | 12:00 | Giulio Scatolini
Cultura
Gli agronomi medioevali dell'ordine religioso degli agostiniani

L’ordine agostiniano ha costruito il suo potere attraverso miracoli agronomici: ripristinare la terra sterile, guarire il bestiame, far rivivere alberi da frutto. Questi atti hanno aiutato le comunità rurali a sopravvivere e hanno dato legittimità all'ordine
05 febbraio 2026 | 11:00
Cultura
Il paese della biodiversità. Il patrimonio naturale italiano: al Maxxi la mostra del National Geographic Italia

Il percorso espositivo multimediale rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta del lato più selvaggio e meno conosciuto della flora e della fauna del nostro paese. Lo fa attraverso lo sguardo di tre fotografi naturalistici, scienziati
25 gennaio 2026 | 15:00
Cultura
Cortina di Stelle: arte, sport e inclusione verso i Giochi Invernali 2026

A 2.732 metri, al Lagazuoi EXPO Dolomiti, l’arte multisensoriale di Fulvio Morella dialoga con le storie e i cimeli di tre grandi atleti paralimpici, in vista dei Giochi invernali Milano Cortina 2026
05 gennaio 2026 | 15:00
Cultura
Ecco perchè mangiare uva e lenticchie a Capodanno porta fortuna

Oggi le lenticchie e l’uva vengono consumate, pur se a Capodanno, senza nessun particolare cerimoniale, nel passato ciò avveniva invece attraverso rituali e regole ben precise. Usanza di buon augurio per propiziarsi ricchezza e fortuna
19 dicembre 2025 | 20:15 | Giulio Scatolini
Cultura
Per Natale a ognuno il proprio olio extravergine di oliva: è tutta questione di carattere

Ecco una rapida guida che abbina una personalità, quella di chi riceve l'olio in dono, a un olio che gli somiglia, in modo che novellini dell’assaggio, compratori dell’ultimo minuto, appassionati golosi e curiosi sappiano regalare un monovarietale
19 dicembre 2025 | 12:00 | Giosetta Ciuffa






