Editoriali
La differenza fondamentale tra ricerca scientifica e osservazione empirica
In campo agricolo può apparire molto semplice, persino banale, condurre un'esperienza che porti a un beneficio agronomico, gestionale ed anche economico. Un percorso che può portare a risultati effimeri se non validato da strumenti scientifici
20 settembre 2019 | Angelo Bo
Approcciare il mondo delle informazioni tecniche è tutt'altro che semplice, ma cerchiamo comunque di elaborare un'analisi delle necessità e criticità del settore olivicolo ed oleicolo.
E' sicuramente utile definire meglio, e ognuno di noi può portare un contributo sulla sua visione, quali elementi base deve avere l'informazione tecnica e come questa si può formare: prima di tutto l'informazione deve essere attendibile (avere quindi una possibile ripetibilità e costanza), presentare un grado di accuratezza definito (avere dei numeri che sono riferiti ad una scala o ad un ordine di grandezza precisi) e deve tenere conto del sistema in cui dovrà essere applicata.
In matematica senza il rischio di commettere errori il risultato di un'operazione è sempre lo stesso, poiché si tratta di una scienza esatta, mentre in un sistema biologico - non essendo la biologia scienza esatta - e quanto più il sistema è complesso, il risultato cambierà radicalmente in quanto i parametri che entrano in gioco nella formazione del risultato sono molteplici, variabili e oltretutto modificati a loro volta da ciò che noi stiamo introducendo.
Come può essere costruita un'informazione tecnica attendibile? Esistono vari percorsi che possono portare al risultato finale sono ben delineati e devono passare da Osservazioni, Ricerca scientifica,
Sperimentazione.
Le osservazioni in campo definiscono quali possono essere le necessità di informazioni del mondo della produzione e forniscono gli elementi base su cui lavorare per elaborare un'ipotesi o una tesi che dovrà poi essere validata con un procedimento di analisi scientifica.
Per definire una valida ipotesi o tesi serve un occhio attento, supportato da esperienza, che supporti ciò che vede con dei dati oggettivi: l'ipotesi formulata deve essere basata su una realtà più oggettiva possibile, se pur importanti siano le percezioni e la visione che chi la formula.
Basare una tecnica su una semplice ipotesi ci può portare a commettere dei grossolani errori, perchè ciò che abbiamo osservato un anno in un luogo, quindi in un ambiente e con condizioni precise, non è detto che sia ripetibile in altri ambienti o con condizioni differenti (es l'anno successivo).
Qui entra in gioco il procedimento scientifico vero e proprio (normalmente nel nostro caso si tratta di scienza applicata e non teorica); non esiste ricerca utile o inutile, le informazioni che vengono estrapolate da un processo di validazione sono sempre utili. A volte indicano una strada da percorrere dimostrando che la teoria o meglio l'ipotesi di base avevano un fondamento, altre volte indicano che quella strada in quelle condizioni non è percorribile e di conseguenza ci forniscono ulteriori informazioni su come procedere.
Quindi il procedimento di validazione scientifica di una ipotesi o teoria deve poter proporre dei test di valutazione della stessa possibilmente escludendo il maggior numero di variabili esterne che potrebbero renderne non significativo il risultato e successivamente con ulteriori test confrontare i risultati con situazioni differenti.
Chi pensa di basare le proprie considerazioni finali su semplici osservazioni, fa come l'olivicoltore che posiziona il trattamento larvicida basandosi sul rilievo di elementi visibili ad occhio nudo come i fori di uscita e di conseguenza tratta nel momento in cui la mosca è uscita dal frutto: quindi spende ed inquina del tutto inutilmente.
La corretta scelta della metodologia e la rigorosità nell'applicazione accrescono l'attendibilità di tutto il lavoro. Per fare un esempio (che potrebbe apparire quasi banale), valutare la bontà di un sistema di reti anti-insetto con la sola rilevazione degli adulti dentro e fuori (quando anche il tecnico meno preparato sa che non esiste correlazione tra numero di catture e reale infestazione nelle olive), quindi senza valutare correttamente il danno reale che queste faranno alle olive, non dimostra niente, lasciando tecnici e agricoltori nel dubbio. Lavorando in un ecosistema che è di per se iper-complesso, devono essere presi in considerazione anche gli effetti collaterali che l'applicazione ha sulla coltura. Ad esempio, sono stati presi in esame i valori di illuminamento della pianta sotto copertura e di conseguenza il confronto dell'accrescimento delle drupe e dei parametri di maturazione nonché l'andamento della stessa nella stagione (con e senza copertura)?
Operiamo in aziende e le informazioni che abbiamo a disposizione devono sottostare anche a valutazioni di tipo economico. Nella mia esperienza l'errore che rilevo spesso è la valutazione dei costi di produzione, per i suoi aspetti intrinseci tutt'altro che semplici, ma spesso per vere e proprie leggerezze; infatti le aziende dei piccoli agricoltori tralasciano di computare nei costi – seppur impliciti, quindi in molti casi non un esborso vero e proprio - valori di spesa importanti, tra i quali i più frequenti sono il costo della propria manodopera, delle macchine aziendali e dei capitali investiti, che essendo sotto stimati o non proprio considerati falsano completamente i confronti finali delle varie opportunità, portandoci talvolta a fare scelte completamente sbagliate, o a dover ammettere – mestamente - che non “è rimasto in tasca niente”. Ad esempio valutare un nuovo impianto realizzato “in economia” e non computare manodopera e macchine aziendali, fa apparire l'investimento sicuramente vantaggioso, rispetto a chi a pari condizioni le computa. Altro esempio ma non meno importante, citare le tanto osannate produzioni di olive ad ettaro, ma non quanto olio viene prodotto, esaltare la produttività ad ettaro senza prendere in esame il costo di produzione unitario, - si perchè potrei produrre di più ma con un costo di produzione per kg maggiore - e quindi meno conveniente, porta a valutazioni completamente deviate e falsate.
Validata la tesi o l'ipotesi in modo scientifico ed ottenuta una serie di informazioni attendibili è spesso necessaria una fase di sperimentazione in campo per trovare quegli adattamenti o migliorie possibili per rendere uno strumento, scientificamente valido, efficace ed efficiente nella pratica.
Questa fase è un susseguirsi di confronti stimolanti, di discussioni e di ricerca di informazioni, cambiamenti del modo di vedere le cose che abbiamo davanti, per capire se la tecnica che conosciamo può avere un'applicazione efficace in quel microclima o realtà aziendale. Ma forse l'aspetto più interessante è quello umano che si viene a creare, talvolta si trovano in azienda degli sperimentatori nati, che lavorano costantemente per migliorare, adattare, recuperare macchinari e tecniche alla loro realtà aziendale.
In qualsiasi fase della costruzione di un'informazione tecnica la rigorosità e la scrupolosità dalla rilevazione dei dati alla loro analisi deve essere massima, perchè è facile storpiare i risultati a proprio piacimento e comodo. Altrettanto imparziale deve essere chi esegue questi lavori, pena la messa in dubbio di tutto il confronto e dei risultati stessi, col risultato di vedere vanificato quanto di buono ci può essere.
La sperimentazione può partire dalle aziende, anzi bene che ci sia una spinta da parte loro, e altrettanto positivo che una parte del lavoro di messa a punto e verifica sia fatto in collaborazione con le aziende in modo da non incorrere in quelle ricerche talmente teoriche che non possono trovare nessuna applicazione pratica; ma la sperimentazione, per essere attendibile, deve essere seguita ed eseguita in modo professionale e serio. I dati devono essere pubblicati tutti e resi disponibili alle analisi, devono essere indicate chiaramente le condizioni di applicazione per meglio individuare dove quella soluzione tecnica può essere valida e ripetibile, perchè annunciare solo i risultati delle prove con tanto di “eureka, funziona!” è solo pressappochismo, pericoloso e autolesionista.
Potrebbero interessarti
Editoriali
Il cibo non è una merce: è il tempo della ribellione

L'accordo di libero scambio UE-Mercosur si dovrebbe basare su finte clausole di salvaguardia, ma con l'impossibilità di reali controlli sull'agricoltura e l'agroalimentare del sud America. La salute dei cittadini europei è a rischio, insieme con l'agricoltura del Vecchio Continente
27 gennaio 2026 | 15:35 | Giorgio Bonacini
Editoriali
I media sono nemici dell'olio extravergine di oliva italiano?
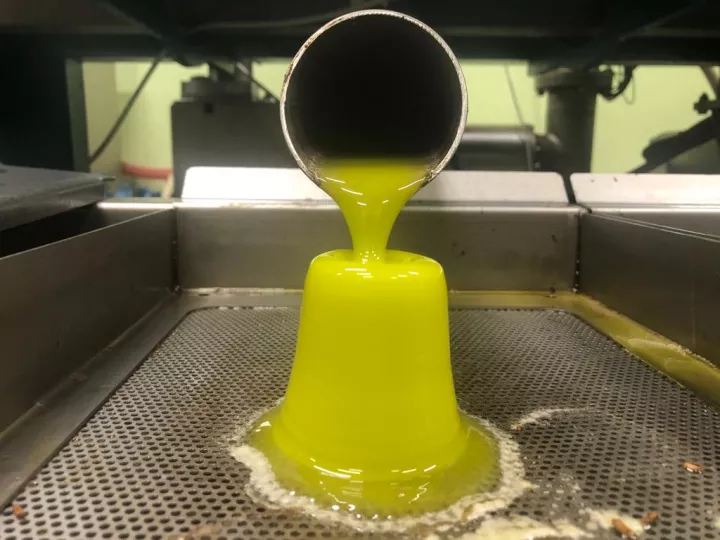
Piu passa il tempo, più non leggo di extravergine, più non vedo extravergine, più non sento extravergine, più sono assalito da un dubbio “non amletico”: esiste una lobby, voluta o involontaria, dei “nemici dell’extravergine”?
26 gennaio 2026 | 09:00 | Giulio Scatolini
Editoriali
L’intelligenza artificiale sceglierà quale olio d’oliva mettere sugli scaffali della Grande Distribuzione

Buyer e Controllo qualità della GDO sono inutili: aboliamoli! Al loro posto l’intelligenza artificiale selezionerà le offerte provenienti dalle aziende in maniera più efficiente, veloce ed economica. Con lo Stato che ha abdicato ai controlli, l’olio lampante diventerà presto il nuovo standard di qualità
21 gennaio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli
Editoriali
Un laboratorio a cielo aperto per dare nuova vita all'agricoltura

Urgente e fondamentale è riappropriarsi della politica per tornare a essere popolo, ovvero punto di riferimento sociale, economico e culturale. Si tratta di saper governare i suoi beni comuni, quali il territorio, l’acqua e l’aria per continuare ad avere cibo sano, acqua potabile e aria pulita
08 gennaio 2026 | 15:00 | Pasquale Di Lena
Editoriali
Olio di oliva a dazio zero dalla Tunisia: chi ci guadagna davvero?

L’attuale regime delle quote di importazione favorisce solo l’industria olearia europea, spagnola in particolare. L’olio di oliva tunisino finirà comunque in Europa ma tutto dipende dal prezzo e dalle condizioni. Senza regole si distrugge il mondo produttivo europeo e tunisino
08 gennaio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli
Editoriali
Le due manifestazioni degli agricoltori a Bruxelles: PAC, Mercosur e crisi dell’agricoltura

Il 18 dicembre nella capitale belga non è andata in scena un’unica manifestazione degli agricoltori ma due: una sfilata istituzionale e una rivolta sociale. Incontri al Parlamento e con la Commissione ma anche tafferugli e liquami versati in strada
19 dicembre 2025 | 14:40 | Alberto Grimelli
Commenta la notizia
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Accedi o Registrati





