L'arca olearia
Tutti alla ricerca del modello olivicolo perfetto
Prosegue l’analisi di quanto è emerso a Portici, nel corso di una due giorni dedicata all’olivo e all’olio. Anche questa volta vi sottoponiamo una breve rassegna ragionata su ciò che si prospetta per il futuro. E' davvero proponibile una svolta?
10 ottobre 2009 | Carlotta Baltini Roversi

Come già messo in luce sabato scorso (link esterno), il primo e il due di ottobre si è svolto a Portici, in provincia di Napoli, un confronto costruttivo fra tutti gli operatori della filiera olivicola-olearia.
I lavori del primo Convegno Nazionale dell'Olivo ed Olio si sono incentrati su una molteplicità di temi, e così, dopo aver presentato gli aspetti relativi al mercato e alla valorizzazione degli oli di oliva, presentiamo ora una breve sintesi di altri interventi, grazie anche alla disponibilità accordataci dal professor Claudio Di Vaio, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ci ha fornito gli abstracts, da cui abbiamo appunto ricavato per voi una libera e sintetica panoramica.
Non sono evidentemente riportati tutti i lavori, ma in questa seconda puntata ci soffermiamo sulla seconda sessione dei lavori.
Buona lettura.
MODELLI COLTURALI E LORO GESTIONE
Riportare la gran parte dei contributi presentati a Portici è un’operazione molto complessa, che richiederebbe la necessità di riportare in volume tutte le relazioni. Dovendo stringere per giungere ai passaggi salienti, è sufficiente almeno fare il punto su alcune relazioni. Come quella per esempio di Angelo Godini, dell’Università degli Studi di Bari, che prevede, per una soluzione ai tanti problemi irrisolti, dell’olivicoltura italiana, la via del superintensivo.
Quasi si confessa: “Un viaggio compiuto in Catalogna, in Spagna, nel novembre 1999, divenne occasione per convincerci ad avviare in Puglia studi sul modello di olivicoltura superintensiva, con meccanizzazione di tutte le operazioni colturali, da messa a dimora, a potatura, irrigazione, concimazione, difesa, raccolta in continuo con macchina scavallatrice. Il modello si basa sull’allevamento ad asse centrale con densità di piantagione di circa 1.700 piante/ha e la sua efficienza dipende dalla disponibilità di varietà con portamento compatto, ramificazione abbondante e uniforme, accrescimento contenuto, rapida e consistente entrata in produzione, e che diano olio di buona qualità â€.
Il professor Godini si è impegnato a lungo su questa strada, tanto che tra il 2001 e il 2006, nella sua Puglia ha contribuito a realizzare tre campi sperimentali secondo il modello del superintensivo. E’ ovvio che abbracciando tale stradfa si riduca inevitabilmente il quadro varietale a disposizione. Con il superintensivo valgono cultivar come l’Arbequina, l’Arbosana e la Koroneiki.
Già , e il nostro vasto patrimonio varietale? Che fine è destinato a fare se si optasse per il superintensivo?
Godini è drastico nel bocciare il modello tradizionale: “La coltivazione tradizionale dell’olivo per la produzione di extra vergine – sostiene –si caratterizza per gli alti costi, che oggi arrivano anche a superare i prezzi di vendita dell’olio, almeno al netto dei sussidi UE, che sono a loro volta destinati a probabile scomparsa dal 2014 in poi. La maggiore voce di spesa è quella per la manodopera, sempre più rara e più cara. Poiché - aggiunge - i livelli produttivi degli alberi della coltura tradizionale non possono essere dilatati a piacere, i prezzi d’acquisto delle materie utili per l’esercizio dell’olivicoltura sfuggono al controllo dei produttori e i prezzi di vendita dell’olio non rientrano tra le attribuzioni concesse agli olivicoltori e alle loro organizzazioni, per tentare di tornare ad essere redditizia, all’olivicoltura non resta che una profonda innovazione che porti alla drastica riduzione dell’impiego del lavoro umano, cosa praticamente impossibile da ottenere coi modelli tradizionaliâ€.
Di olivicoltura toscana, invece, hanno trattato Daniele Sarri e Marco Vieri, del Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell’Università di Firenze, i quali si sono soffermati sul progetto Mateo, ovvero: Modelli Tecnici ed Economici per la Riduzione dei Costi di Produzione nelle Realtà Olivicole della Toscana, di cui abbiamo già scritto. Tale progetto è stato promosso da Arsia Toscana.
Cosa emerge? Secondo Sarri e Vieri, i risultati di tale progetto “hanno permesso di individuare le soluzioni tecniche economicamente più sostenibili dal punto di vista economico, ed hanno fornito agli agricoltori proposte di progresso tecnico concretizzabili ed immediatamente attuabili. La paralisi strutturale del settore olivicolo – precisano – impone un rinnovamento consapevole che tenga conto della necessità di coniugare tradizione ed innovazione in un ‘modello produttivo toscano’ che non può prescindere dai valori della qualità , tipicità , legame con il territorio e la sua culturaâ€.
Non ci sarebbe insomma alcuna via di scampo: “L’olivicoltura odierna, salvo limitati casi di successo, è strutturalmente assimilabile a quella attuata 50 anni faâ€. E allora la chiave di volta per leggere con una luce diversa il futuro dell’olivicoltura toscana è “Olive crop mechanization, Landscape and Typical Mediterranean Product Manteinanceâ€. Tutto chiaro?
Agostino Tombesi , Daniela Farinelli, Mauro Ruffolo e Michela Siena dell’Università degli studi di Perugia, nonché Giulio Scatolini di Aprol Perugia, hanno presentato invece uno studio relativo al triennio di raccolta meccanica per promuovere l’olivicoltura in Umbria. Per loro diventa fondamentale “gestire meglio le chiome, per ridurre il volume e per stimolare una produzione regolare. Le macchine più efficienti per la raccolta possono essere impiegate in molte situazioni e migliorano le loro prestazioni con l’adattamento delle piantagioni e la scelta dei periodi ottimali di raccoltaâ€.
Il gruppo di lavoro costituito da Nasini, Proietti, Balduccini, Del Buono e Gigliotti, dell’Università degli Studi di Perugia, ha invece trattato il tema del compostaggio dei sottoprodotti della filiera olivicola-olearia e degli effetti della fertilizzazione degli oliveti con i compost ottenuti.
L’obiettivo dello studio, condotto in seno alla Facoltà di Agraria, è stato quello di definire un sistema di compostaggio di rifiuti organici provenienti dalla filiera olivicola-olearia (residui di potatura e sanse) e validare così la qualità del compost ottenuto e le sue potenzialità di impiego come ammendante per oliveti. Ne è emerso che tale opportunità costituisce effettivamente “una valida alternativa alla sempre più difficoltosa estrazione dell’olio di sansa e allo smaltimento delle sanse come rifiuto industriale. La fase attiva del processo di compostaggio (matrice costituita da sansa derivante da un sistema di estrazione a 3 fasi e da ramaglie di potatura trinciate, 50:50 in volume) è stata condotta in scala pilota in un ‘composter’ appositamente progettatoâ€; mentre la successiva fase di maturazione è stata attuata in cumulo, al
coperto. I risultati ottenuti? “Denotano la buona attitudine al compostaggio delle sanse dei frantoi oleari miscelati con i residui di potaturaâ€.
E’ stato altrettanto interessante lo studio presentato da Proietti, Nasini, Famiani e Balduccini, dell’Università degli Studi di Perugia. Si sono concentrati sugli effetti della concimazione fogliare azotata sull’attività dell’olivo e sulla qualità dell’olio, concludendo che “l’elevata disponibilità di azoto nelle foglie durante la fase di inoliazione non influenza negativamente la qualità dell’olio e che, in alberi in condizioni di buona dotazione di azoto, la concimazione fogliare con urea da luglio in avanti non induce effetti di rilievo sull’attività vegetoproduttiva dell’alberoâ€.
Un altro tema forte, relativamente alla sessione sui modelli colturali, è stato quello trattato da Narciso Andreoni, del Dipartimento di Chimica e Biotecnologie Agrarie dell’Università degli studi di Pisa, circa il recupero di composti fenolici da materiale di potatura dell’olivo.
“La potatura dell’olivo - ha tenuto a precisare Andreoni – rappresenta una costosa e inevitabile pratica agronomica della filiera di produzione dell’olio di oliva. Il materiale vegetale che ne deriva è spesso triturato e disperso sul suolo, oppure è bruciato sul posto, sebbene ciò sia vietato in diversi comuni, con conseguente perdita di preziosi componenti che vi sono contenuti. Tuttavia, se tale materiale potesse avere delle utilizzazioni, la sua raccolta e lavorazione potrebbero rappresentare una risorsaâ€.
E’ un argomento che tante volte si è tentato di lanciare a più riprese tra le aziende olivicole, ma che evidentemente non è stato compreso a sufficienza proprio per i suoi numerosi vantaggi che comporta.
“Un impiego che appare promettente – ha opportunamente riferito Andreoni – è l’estrazione di varie classi di prodotti e, in particolare, dei composti fenolici, alcuni dei quali sono tipici dell’olivo e presentano interessanti proprietà biologiche e chimicheâ€.
Nel suo lavoro son stati confrontati due metodi di estrazione dei composti fenolici da foglie di olivo effettuati in laboratorio su piccoli i campioni, ma studiati per una loro potenziale applicazione in piccoli impianti di lavorazione, con l'uso rispettivamente di un solvente organico o di soluzioni acquose, in cui sono stati separati composti fenolici (oleuropeina, flavonoidi) ed altri componenti come le clorofille ed è
stata valutata la possibilità di ulteriori utilizzazioni del materiale estratto.
“Per ottenere dei vantaggi in questo tipo di lavorazione – ha precisato Andreoni – è necessario che il materiale di potatura dell'olivo, privo di composti tossici provenienti da trattamenti antiparassitari, venga adeguatamente trattato per inattivare gli enzimi
endogeni, che possono alterare i composti fenolici, e preparato per la lavorazione.
Dall'esame delle prove fatte – ha spiegato Andreoni – si può dedurre che le operazione relative alla raccolta, alla stabilizzazione e alla preparazione del materiale potrebbero essere effettuate presso le aziende agricole, mentre la lavorazione successiva potrebbe essere fatta solo da personale addestrato presso strutture fornite di adeguati impianti per l'uso ed il recupero di solventi e di reagenti e per la separazione e conservazione dei prodotti estratti. In questo modo – ha concluso Narciso Andreoni – il recupero di composti fenolici dal materiale proveniente dalla potatura dell'olivo potrebbe essere vantaggiosa sia da un punto di vista agronomico e ambientale, sia da quello più strettamente economicoâ€.
(2. continua)
LEGGI ANCHE
Cosa bolle in pentola sul fronte olivo, olio e mercati?
link esterno
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Meccanizzazione della potatura sull'olivo: ridurre i costi su impianti tradizionali

In un contesto caratterizzato da costi di produzione crescenti e da una progressiva carenza di manodopera, la meccanizzazione della potatura dell'olivo si conferma una leva strategica per garantire la sostenibilità economica del settore
03 febbraio 2026 | 12:00
L'arca olearia
Impatto dello stress termico sulla qualità dell'olio d'oliva su olivo irrigato

Ecco come lo stress da calore influenza i parametri chiave della qualità dell'olio d'oliva, anche quando l'olivo viene irrigato. Aumenta in contenuto di olio nelle olive ma cambia il profilo in acidi grassi. Forte variabilità nei fenoli
02 febbraio 2026 | 14:00
L'arca olearia
Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione
30 gennaio 2026 | 16:00
L'arca olearia
Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio
30 gennaio 2026 | 15:00
L'arca olearia
Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza
30 gennaio 2026 | 14:00
L'arca olearia
L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti
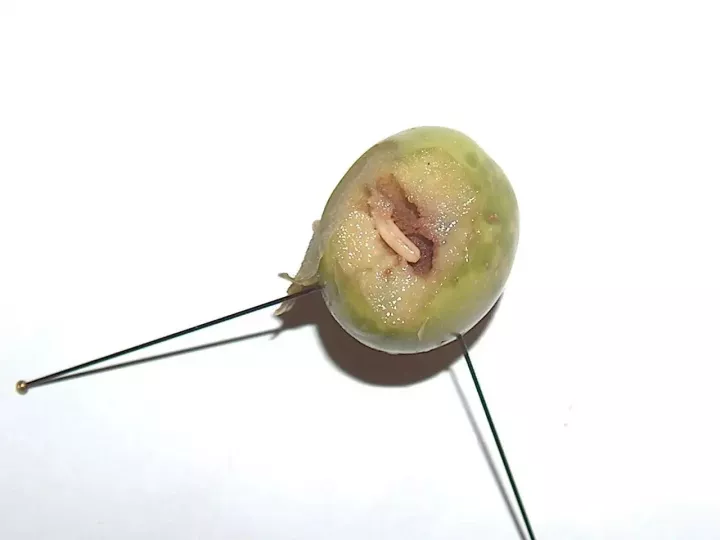
L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico
30 gennaio 2026 | 13:00






