L'arca olearia
Regolamento 2568/91: lo scudo per la tutela della qualità e genuinità degli oli da olive compie trent’anni
Sei cifre che sono entrate nella memoria stabile di tutti gli addetti alla filiera olivicola: 2568/91 noto appunto come il “Regolamento”. Un percorso storico per scoprirne i segreti, la storia, le pecche e le virtù
15 gennaio 2021 | Matteo Storelli
Tra qualche mese, ricorreranno i 30 anni dalla pubblicazione del Regolamento sulla classificazione e sui controlli degli oli di oliva.
Sei cifre che sono entrate nella memoria stabile di tutti gli addetti alla filiera olivicola: 2568/91 noto appunto come il “Regolamento”.
Una sorta di passepartout legislativo per chi effettua i controlli e fonte di ansia continua per chi invece produce, detiene e commercializza l’olio.
Numerosi articoli e pubblicazioni sono stati dedicati all’argomento mettendo il risalto soprattutto il carattere analitico-evolutivo.
Ripercorreremo invece questo cammino guardando al pensiero del legislatore europeo non avulso dal contesto storico in cui egli ha operato.
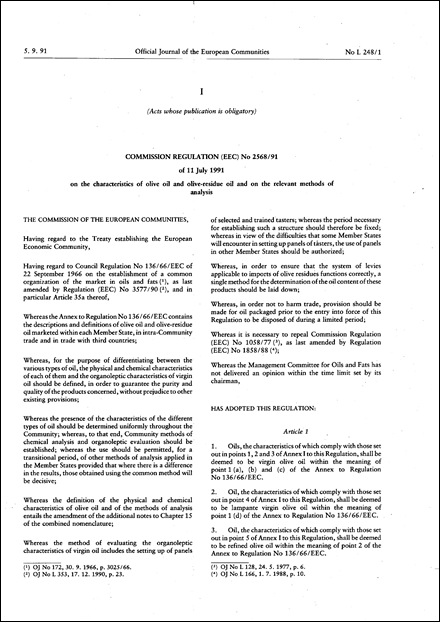 LA GENESI
LA GENESI
1966. E’ considerato l’anno zero per il settore oleario. L’allora Comunità Europea di dotava di una norma sull’Organizzazione Comune di Mercato nel settore dei grassi che sarà in vigore per quasi quarant’anni con lo scopo di perseguire gli obiettivi previsti dalla P.A.C. per la stabilizzazione del mercato dei grassi vegetali, sostenere il reddito degli olivicoltori , stabilire degli standard comuni di qualità fornendo ai consumatori un’adeguata informazione sui prodotti.
Nel settore oleario, in particolare, l’Italia regnava sovrana per produzione, trasformazione, cultura e conoscenza.
Italiani erano i brevetti delle macchine per la trasformazione delle olive e le leggi più avanzate in tema di controlli, commercializzazione e lotta alle frodi in tutto il settore agroalimentare.
Gli altri Stati erano quasi all’età della pietra. Oltre Atlantico, per esempio si definivano tutte le categorie di oli di oliva con a una definizione antecedente gli anni 50 del tipo “grasso liquido ottenuto dalla trasformazione delle olive.“
Da noi invece i primi aggettivi degli oli vergini come fino e sopraffino anticipavano i criteri di qualità che sarebbero stati recepiti nel tempo da tutta la comunità internazionale.
I primi anni 90 furono cruciali per il progetto di integrazione europea per cui si rese indispensabile stabilire in modo uniforme le caratteristiche dei vari tipi di olio adoperando le stesse procedure analitiche per controlli.
La cronaca fece il resto!
Scandali come la sofisticazione del vino al metanolo con decine di decessi scossero le coscienze di tutti i cittadini del vecchio Continente.
Contemporaneamente in Germania si verificarono episodi di contaminazioni di oli di oliva con solventi alogenati, che ebbero un’ altrettanto impatto sull’opinione pubblica internazionale.
In questo contesto si decise di mettere a punto alquanto velocemente un vero e proprio testo unico sul controllo degli oli di oliva che portò alla stesura del “Regolamento“ in cui trovavano posto le definizioni delle varie categorie degli oli, i metodi ufficiali di analisi, i valori limite dei vari parametri legali e le norme doganali per il commercio import-export tra l’allora Comunità Europea e i Paesi Terzi.
Il tutto in appena 10 articoli e sedici allegati .
Un unico strumento per contrastare ogni tipo di frode alimentare: fiscale, merceologica o sanitaria che fosse e regolamentare i commerci.
Non era poco!
Compariva per la prima volta in assoluto un metodo di analisi ufficiale per l’analisi organolettica degli oli vergini, il panel test, che sarebbe stato fonte di accesa di discussione per i successivi trent’anni .
“L’allegato I “ da allora assunse le veci di carta di identità delle varie categorie di oli di oliva. La sua struttura tabellare del tipo “a calendario“ di facile e intuibile interpretazione divenne lo strumento per la classificazione degli oli.
Di questo Allegato I si parlerà molto.
IL PECCATO ORIGINALE La prima versione del regolamento pubblicata sulla G .U.C.E. L 248 del 1991 conteneva diversi errori tipografici e inesattezze che furono corretti con rettifiche successive.
La prima versione del regolamento pubblicata sulla G .U.C.E. L 248 del 1991 conteneva diversi errori tipografici e inesattezze che furono corretti con rettifiche successive.
La svista più sostanziale, quella relativa all’allegato XIV sulle note complementari al capito 15 della Tariffa Doganale Comune fu rimossa dopo quattro anni quando ci si accorse che la sua sede naturale non fosse il regolamento 2568/91 ma quello più generale: il 2658/87 relativo alla Nomenclatura Combinata e alla Tariffa Doganale Comune.
Se l’allegato I rappresentava la cosiddetta carta di identità degli oli di oliva, le note complementari al capitolo 15 della tariffa ne rappresentavano il passaporto.
Due documenti simili per finalità ma che operavano in contesti diversi che solo vent’anni dopo saranno sincronizzati.
Perché parliamo di questo?
Perché la querelle sulle importazioni di oli esteri nacque proprio allora!
L’’allegato XIV conteneva norme di controllo meno restrittive rispetto all’allegato I.
Questo permise per diverso tempo l’importazione di ingenti quantità di oli tunisini in U.E. in regime di temporanea importazione favorendo la nascita di una fiorente industria di confezionamento di questi oli che presentavano spesso valori del trigliceride trilinoleina e indice spettrofotometrico K232 ben più elevati di quelli stabiliti dall’allegato I.
Lo status di prodotto allo stato estero dell’olio in tutte le sue fasi: importazione, trasformazione, riesportazione imponeva infatti che nei controlli si applicasse l’allegato XIV e non l’allegato I .
Se idealmente il “Regolamento” rappresentava la “muraglia di cemento“ con la quale la Comunità proteggeva le sue produzioni olivicole, era stata lasciata la possibilità a “qualcuno” di entrare “dai sotterranei“.
Il principio di simmetria dei controlli andò un po’ in crisi .
Qualche confusione iniziale fu inevitabile . Ci furono quesiti alla Commissione e furono emanate circolari interpretative sino a quando (molti anni dopo) intervenne il legislatore comunitario a sciogliere ogni ambiguità allineando finalmente i testi dei due allegati .
L’INTRUSO
Nei regolamenti “omnibus” il rischio di errori è sempre in agguato.
La disputa se inserire o meno alcuni limiti nell’allegato I fu molto accesa!
Sulla spinta emotiva di Paesi come la Germania, buoni consumatori di olio e che aveva subito la frode da tetracoloetilene fu imposto che i solventi alogenati comparissero nei due allegati per contrastare anche le frodi sanitarie.
Furono imposti valori limite e una metodica di analisi rimaste valide ancora oggi .
Il Consiglio Oleico Internazionale nel frattempo aveva recepito questa sensibilità inserendo i solventi alogenati tra i contaminanti degli oli di oliva in cattiva compagnia con pesticidi e metalli pesanti.
L’Europa fu più ambigua: il valore limite obbligatorio entrò nell’Allegato I dove addirittura figurava (sich !) tra le caratteristiche di qualità degli oli insieme all’acidità, numero di perossidi , spettrofotometria UV e panel test (compagnia sicuramente più allegra ma impropria) .
La cosa non poteva durare.
Nell’ennesima riunione di esperti chimici di Bruxelles del 2003 si decise di allinearsi alle disposizioni COI in qualche modo sfrattando il parametro dall’allegato I e relegandolo in un recondito articolo 7 relativo alla presenza di contaminanti.
Il valore limite come detto c’è e rimane, ma inquadrato in un contesto diverso da quello merceologico in senso stretto o di classifica del prodotto.
Da questo momento venne sancita di fatto la separazione dei controlli merceologici da quelli sanitari secondo lo spirito autentico del Regolamento ossia garantire la conformità merceologica degli oli da olive alle varie categorie.
In ragione di ciò, determinazioni riguardanti i principali contaminanti quali: prodotti fitosanitari, idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, solventi e metalli pesanti non trovarono asilo in questo testo.
Insomma il concetto fu chiaro: la genuinità e la qualità sono sorelle, la salubrità no!
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Estratti di cipolla e agenti di biocontrollo per combattere i patogeni dell’olivo e migliorare l’assorbimento di nutrienti

Agenti protettivi e biostimolanti possono aiutare nella gestione integrata dell’olivo, stimolando la crescita delle radici e migliorando la resistenza allo stress ossidativo nelle piante non sottoposte a stress
19 gennaio 2026 | 15:00
L'arca olearia
La concimazione dell’olivo con ammendanti può sostituire la fertilizzazione minerale?

Valutati gli effetti dell'applicazione di cenere di legna, letame, compost di rifiuti solidi urbani, funghi micorrizici, biochar e zeoliti, prendendo come riferimento l'assenza di fertilizzazione e la concimazione minerale convenzionale
17 gennaio 2026 | 12:00
L'arca olearia
La resistenza al fuoco dei pannelli di foglie di olivo con rivestimenti ritardanti di fuoco

Il potenziale dell'utilizzo dei sottoprodotti delle foglie di olivo come materiale da costruzione: i campioni trattati hanno mostrato un aumento della formazione di char, riducendo il trasferimento di calore e ritardando la combustione
17 gennaio 2026 | 09:00
L'arca olearia
Non ci si può fidare dell’indicazione di origine sull’etichetta dell’olio di oliva, con l’eccezione del 100% italiano

La Spagna si conferma porto delle nebbie con un numero di controlli ben inferiori a quelli che dovrebbe effettuare per legge. La tracciabilità dell’olio di oliva si perde appena si varcano le frontiere, ancor più quando si parla di olio extra-UE. La Corte dei Conti smentisce la Commissione europea
16 gennaio 2026 | 16:00 | Alberto Grimelli
L'arca olearia
L'impatto del metodo di raccolta e conservazione sul profilo fenolico e la composizione degli acidi grassi delle olive

Ecco il vero impatto degli agevolatori per la raccolta delel olive sulla qualità dei frutti, impatto che diventa più significativo col procedere della conservazione. Le differenze in termini di profilo fenolico e in acidi grassi
16 gennaio 2026 | 15:00
L'arca olearia
Sensori MOX per la valutazione dell'autenticità e la rilevazione dell'adulterazione nell'olio extravergine di oliva

L’adozione di approcci analitici integrati sull'olio di oliva, che combinano tecniche consolidate come GC-MS con strumenti innovativi come i nasi elettronici basati su sensori MOX, rappresenta un passo decisivo verso un sistema di controllo più moderno, efficiente e sostenibile
16 gennaio 2026 | 14:00
Commenta la notizia
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Accedi o Registrati





