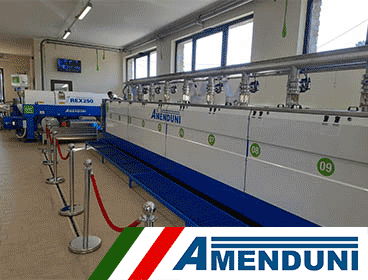L'arca olearia
Il frantoio del futuro dovrà essere a impatto zero
Tallone d'achille dell'impresa olearia è la gestione dei sottoprodotti, in particolare delle acque di vegetazione, fitotossiche e per il cui smaltimento occorrono costi altissimi. Con Sofia ci si avvicina all'obiettivo di una filiera olivicola amica dell'ambiente
13 giugno 2014 | Alberto Grimelli
Ogni anno, in Italia, si producono circa 4 milioni di tonnellate di acque di vegetazione originate dall’acqua di costituzione delle drupe, da quella utilizzata per il lavaggio dei frutti e degli impianti e da quella necessaria per la diluizione delle paste negli impianti continui.
Il frantoio vede nella sansa e nelle acque di vegetazione dei costi di gestione altissimi. I controllori vi vedono i rischi ambientali. La società vi vede un sistema energivoro e poco rispettoso dell'ambiente.
Tutti scontenti, quindi, ma il sistema è rimasto immutato da anni senza che ne traesse giovamento alcuno.
 Questo soprattutto perchè non vi era una tecnologia adeguata per il trattamento delle acque di vegetazione che sono caratterizzate da un comprovato carattere biorefrattario ed inibiente rispetto ai comuni processi a fanghi attivi, dovuto essenzialmente all’elevata concentrazione di polifenoli (variabile tra il 2 ed il 15%) verso i quali deve essere dedicata una particolare attenzione a causa della relativa influenza sulle caratteristiche di tali acque tra cui il colore, l’effetto antibatterico e la fitotossicità. Di conseguenza le acque di vegetazione vengono trattate negli impianti di depurazione solo se ampiamente diluite rispetto ai reflui in ingresso, condizione praticamente impossibile da soddisfare se non con l'utilizzo di enormi volumi d'acqua. Ne consegue che gran parte dei 4 milioni di tonnellate di acque di vegetazione prodotti annualmente in Italia vengono smaltiti in agricoltura.
Questo soprattutto perchè non vi era una tecnologia adeguata per il trattamento delle acque di vegetazione che sono caratterizzate da un comprovato carattere biorefrattario ed inibiente rispetto ai comuni processi a fanghi attivi, dovuto essenzialmente all’elevata concentrazione di polifenoli (variabile tra il 2 ed il 15%) verso i quali deve essere dedicata una particolare attenzione a causa della relativa influenza sulle caratteristiche di tali acque tra cui il colore, l’effetto antibatterico e la fitotossicità. Di conseguenza le acque di vegetazione vengono trattate negli impianti di depurazione solo se ampiamente diluite rispetto ai reflui in ingresso, condizione praticamente impossibile da soddisfare se non con l'utilizzo di enormi volumi d'acqua. Ne consegue che gran parte dei 4 milioni di tonnellate di acque di vegetazione prodotti annualmente in Italia vengono smaltiti in agricoltura.
Lo spandimento sui terreni, a causa di leggi sempre più stringenti con relativi oneri burocratici, delle mutate condizioni climatiche, di costi di trasporto sempre più elevati e di una sensibilità maggiore della società ai temi ambientali, risulta quindi essere una metodologia che ha i giorni contati.
Per questo è aumentata negli ultimi anni l’esigenza di sviluppare tecnologie che permettano una gestione programmabile, a basso costo ed a basso impatto ambientale delle acque di vegetazione.
Numerosi processi e tecnologie sono stati testati per il trattamento delle acque di vegetazione come ad esempio la combinazione di processi biologici aerobici ed anaerobici, biomasse fungine, processi di ossidazione avanzata e filtrazione a membrana. Tuttavia, nessuna delle suddette soluzioni si è dimostrata efficace ed economica e raramente ha trovato applicazione a scala reale.
In questo contesto si inserisce il progetto SOFIA (SOluzione innovativa per la FIlierA dell’olio), iniziato ad Ottobre 2012 e concluso a Maggio 2014, cofinanziato dalla Regione Toscana che vede come partner l’Azienda Agricola Piero Gonnelli (Reggello, Firenze), la Società Gonnelli 1585 srl (Reggello, Firenze) ed il PIN Scrl (Polo Universitario della Città di Prato), società dell’Università degli Studi di Firenze.
Obiettivo del progetto SOFIA è quello di aumentare la competitività del settore olivicolo italiano attraverso l’inserimento di un’innovazione tecnologica e di processo nel settore della produzione di olio d’oliva per il trattamento delle acque ed il recupero della sansa dalle acque di vegetazione. L’inserimento di un processo di evaporazione/condensazione delle acque di vegetazione, oltre a permettere il recupero della sansa e l’eventuale valorizzazione della stessa all’interno del frantoio mediante processi di combustione, permette di risolvere le problematiche ambientali legate allo spandimento su terreno delle acque stesse annullando in primo luogo l’afflusso di sostanze fitotossiche come i polifenoli, aumentare la flessibilità del processo produttivo e consentire lo sviluppo dimensionale delle imprese del settore attraverso la diversificazione delle soluzioni, rendendo lo smaltimento delle acque di vegetazione compatibile con il sistema depurativo, semplificare la gestione dell’attività di estrazione dell’olio e ridurre l’impatto dei trasporti, la gestione dello stoccaggio, e i costi di smaltimento delle acque di vegetazione.
Il carattere innovativo del progetto risiede nella volontà di proporre una filiera alternativa di produzione dell’olio d’oliva ottenuta mediante modifiche parziali di quella esistente che normalmente prevede la produzione di tre flussi distinti con un decanter a tre fasi : l’olio, le sanse e le acque di vegetazione. Attualmente, in Italia le sanse vengono prevalentemente inviate ai sansifici dove si provvede all’estrazione dell’olio residuo con processi chimico-fisici per la produzione di olio di sansa ottenendo come sottoprodotto sanse esauste le quali possono eventualmente ritornare al frantoio ed essere utilizzate come combustibile.
L’applicazione del processo di evaporazione e condensazione alle acque di vegetazione consente il recupero delle sanse (qualitativamente assimilabili alle sanse prodotte da un decanter a tre fasi) che possono successivamente essere riutilizzate per il recupero termico, eventualmente miscelate alle sanse esauste. Le sanse concentrate, inoltre, potrebbero essere utilizzate come materia prima per l’estrazione dei polifenoli allo scopo di sfruttarne le note proprietà biomediche.
Il processo di trattamento delle acque di vegetazione mediante evaporazione risulta, inoltre, funzionale ad un impiego discontinuo, fortemente legato alla stagionalità del processo di produzione di olio d’oliva.
Dal punto di vista delle ricadute economiche ed ambientali, l’adozione di un processo di evaporazione e condensazione delle acque di vegetazione seguito dall’applicazione di processi biologici per il trattamento del condensato permette di ridurre di circa il 90% i volumi necessari per lo stoccaggio delle acque prodotte sfruttando la possibilità di lavorare in continuo e di incrementare la produzione a prescindere dalla disponibilità di terreni idonei allo smaltimento in agricoltura delle acque di vegetazione. La pressoché totale eliminazione della necessità di spandimento su terreno agricolo riduce notevolmente l’impatto ambientale del processo di produzione dell’olio d’oliva legato non solo allo sversamento di composti fitotossici ma anche alla riduzione della CO2 emessa a seguito del trasporto delle acque di vegetazione verso i luoghi di smaltimento.
Articolo correlato: Nulla deve andare sprecato, se c'è mercato. Il caso delle acque di vegetazione
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Gli effetti del carico produttivo e del deficit idrico sul profilo fenolico delle olive

Il diradamento delle olive, simulando una cascola precoce, influisce in modo limitato sull’accumulo di olio nel frutto. Il deficit idrico determina una diminuzione significativa della resa in olio già dalle fasi intermedie di maturazione. L'impatto sui fenoli
27 febbraio 2026 | 16:30
L'arca olearia
Intelligenza artificiale per l'olivicoltura: cosa sa fare e cosa ancora no

E' possibile utilizzare l'IA per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi di produzione, manutenzione e raccolta delle olive. Algoritmi di Deep Learning come Convolutional Neural Networks per l'identificazione della cultivar e la classificazione delle malattie fogliari e la previsione dei raccolti con elevate accuratezze
27 febbraio 2026 | 16:00
L'arca olearia
Differenziazione fiorale e dinamiche di allegagione nell'olivo

La differenziazione fiorale si avvia diversi mesi prima dell’antesi e comprende due fasi: induzione, regolata da segnali endogeni e da accumulo di freddo invernale, e differenziazione morfologica. L'equilibrio dinamico tra genetica, fisiologia e ambiente
27 febbraio 2026 | 15:30
L'arca olearia
Il contributo dell'olivo al mantenimento della stabilità del suolo e contro il dissesto idrogeologico

Gli olivi adulti forniscono un contributo comparabile a vigneti con inerbimento permanente, pur risultando inferiori a boschi. Tuttavia, rispetto a vigneti totalmente lavorati o aree arate, anche gli olivi garantiscono una riduzione apprezzabile della suscettibilità al dissesto
27 febbraio 2026 | 14:40
L'arca olearia
Gli olivi monumentali di Ostuni e la sfida della convivenza con la Xylella fastidiosa

La positività molecolare non coincide necessariamente con sintomatologia grave. In zona infetta la convivenza controllata può essere possibile in determinate condizioni, soprattutto per alberi monumentali ad alto valore paesaggistico
26 febbraio 2026 | 16:00
L'arca olearia
La risposta agli stress ambientali dell'olivo e l'influenza su fioritura e alternanza di produzione

Messa in discussione l’idea che l’alternanza di produzione dell’olivo sia un carattere puramente genetico. All’origine del fenomeno vi sarebbero soprattutto fattori ambientali che influenzano la fioritura
26 febbraio 2026 | 14:00
Commenta la notizia
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Accedi o Registrati