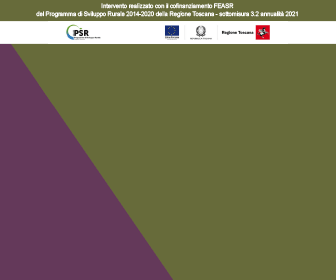Il filo del bucato

Mia nonna parlava con uno spiccato accento tedesco. I nostri incontri si svolgevano in cucina, nel luogo che meno sopportava, ma erano pieni di storie.
C’era nel passo come uno scuotimento verticale di fronde; stava ritta, solenne, aperta a un sorriso laconico che si richiudeva in un attimo, non mostrando che raramente i denti. Una soave increspatura, trattenuta nello specchio di un pozzo: piacere innanzitutto per sé stessa.
Le volevo veramente bene, provavo cioè quel desiderio che avvicina e chiarisce, che anziché contare i metri, sospende gli incroci, trova gli appuntamenti.
Mia nonna parlava con uno spiccato accento tedesco.
I nostri incontri si svolgevano in cucina, nel luogo che meno sopportava, ma erano pieni di storie. E cos’è poi una storia? L’approssimarsi nello spazio e nel tempo di un incrocio, quando s’intravedono due o più alternative e si affollano i segni.
In questo modo, me ne inviò molti e su tutti l’epica della parola data, che confonde in sé sia il tema della promessa sia quello del racconto.
Chi dà la parola, offre un inizio e prospetta una conclusione, l’indizio utile e segreto, magari messo lì sotto il sole eppure ostico, pronto solo per chi sa in che modo maneggiarlo.
Ripensandoci ora, c’erano due oggetti che avevano a che fare con questa paideia casalinga, due oggetti rituali: il filo per stendere e il carrello della spesa.
Mia nonna mi appariva ed era effettivamente imponente, rapida a concedere il sorriso, magari concentrato in un cenno d’incoraggiamento o d’avvertimento, e a rinfoderarlo in un’espressione di severa attesa.
Diventava ancora più imponente, trascinando il carrello verso il mercato di via Tito Speri. Una strada larvale, infera, sprofondata tra due massicce facciate che, prive di alberi e oppresse dalle bancarelle, si presentavano come il retro pur avendo l’ingresso principale sulla strada.
Ripeto, il carrello la slanciava, le raddrizzava le spalle e mostrava sempre una mano lunga, forte che, essendo, di preferenza, la destra era ornata da un anello - lo stesso da che mi ricordi - con una larga fascia d’oro bombata, sormontata da uno scarabeo marrone.
Quella mano avrà su di me un effetto durevole; rappresentava forse la mano posata (inutile e graziosa) delle statue, quella che non sorregge emblemi e, per contrasto, mostra l’altro lato della giustizia, della gloria, della religione, della passione o del dramma. La mano che non usi e dove affiora il prima e il dopo.
Ciò che era e la speranza. La mano nuda, abbandonata, disarmata. La lego, insomma, a questo albeggiare del suo sorriso, quasi subito ritratto in seno al paesaggio e al cielo. L’altro oggetto era il filo del bucato che attraversava un cortile cieco, delimitato dai padiglioni di una tipografia, organo estraneo, trapiantato in una zona franca dell’isolato. Forse, un prato.
Il filo scorreva doppio. C’era una pena nel bucato che si distendeva lentamente, a strappi, accompagnato dal cigolio delle due carrucole. In realtà, lenzuola e indumenti
pendevano come impiccati, perché la nonna non usava mollette, ma piccoli cappi di spago, stretti a bocca di lupo intorno al lembo di stoffa.
Condurre il carrello e tirare la corda del bucato si assomigliavano: erano gesti banali che la figura di Edwige rendeva solenni.
Quale morale, quindi, se non la scelta del come? Raccontare è, in definitiva, una decisione etica e per mia nonna non c’erano che racconti in cui la parola non si poteva rimangiare e andava rispettata fino in fondo, con tutte le conseguenze del caso.
Poi, moltissimi anni dopo, seppi che un pittore avrebbe voluto ritrarle il braccio, dalla spalla alla mano, abbandonato e vivo come quello di una statua che non indichi o tenga alcunché, ma sia integro, fedele al resto, allo sguardo?
Quartiere Prati, 28 dicembre 2008