L'arca olearia
Cosa bolle in pentola sul fronte olivo, olio e mercati?
Quasi un summit dedicato a un comparto in sofferenza ma pur sempre attivo e vitale, che non desiste. Da quanto è emerso a Portici, vi presentiamo una breve rassegna ragionata su ciò che ci aspetta in futuro alla luce del presente
03 ottobre 2009 | Carlotta Baltini Roversi

Il primo e il due di ottobre sono stati giorni intensi. L’importante appuntamento di Portici, in provincia di Napoli ha consentito di poter avviare un confronto costruttivo fra tutti gli operatori della filiera olivicola-olearia.
Ne avevamo già dato notizia, relativamente al primo Convegno Nazionale dell'Olivo ed Olio, ma ora vi presentiamo una breve sintesi degli interventi, cui è bene dare il massimo risalto, giacché non può esserci futuro se non si acquisce sapere.
Un sentito ringraziamento va al professor Claudio Di Vaio, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per averci fornito gli abstracts, da cui abbiamo ricavato una libera e sintetica panoramica. Iniziamo questa settimana con la prima sessione dei lavori, seguiranno le altre.
ANALISI DI MERCATO E VALORIZZAZZIONE
Non si poteva certo trascurare una regione simbolo come la Toscana, e così, a partire da una relazione di Roberto Polidori, Luigi Omodei Zorini, Marco Vieri, Riccardo Gucci, il quadro che è emerso è quello di una filiera della produzione complessa e sfaccettata, fortemente caratterizzata dal punto di vista geografico, tanto da poter parlare più opportunamente di olivicolture toscane. Esiste infatti una netta diversità dal punto di vista strutturale e tecnologico, tra le varie aree, ma le molteplici espressioni di questa regione si ritrovano su un punto comune: l’alto livello qualitativo dell’olio prodotto.
Non mancano i problemi, però: “L’olivicoltura manifesta tuttavia alcune difficoltà di adattamento all’adozione di nuove tecnologie in grado di diminuire i costi unitari di produzione. Il problema della riduzione dei costi di produzione riguarda quindi tutte o quasi le aziende olivicole toscane, si acuisce e diventa una necessità per quelle aziende che competono sui mercati internazionali. La riduzione dei costi di produzione può essere realizzata sviluppando ricerche inter-disciplinari indirizzate alla definizione sia delle caratteristiche strutturali di moderni impianti di oliveto sia di tecnologie produttive volte alla razionalizzazione meccanica delle principali operazioni colturali quali la potatura e la raccolta sia alla definizione dell’efficienza economica-organizzativa delle diverse soluzioni ipotizzateâ€.
Da qui il progetto Mateo, con il dichiarato obiettivo di “proporre modelli organizzativi di gestione dell’oliveto con particolare riguardo alle operazioni di potatura e di raccolta, introducendo un certo grado di meccanizzazione in aziende diverse per tipologia di impianto olivicolo, territorio, e capacità economica di investimento, proponendo metodi di potatura e di gestione della chioma a ridotto fabbisogno di manodopera per impianti intensivi e tradizionali ed effettuando conseguenti analisi economiche per la compatibilità dei moduli e prototipi propostiâ€.
Dalla Toscana al superintensivo, il passaggio è travolgente. Ad affrontare il tema della meccanizzazione e costi della raccolta meccanica dell’oliveto superintensivo, è la relazione dei professori Bellomo e D’Antonio. “L’olivicoltura superintensiva – si legge - è oramai una realtà mediterranea; Bellomo e D’Antonio tale forma di allevamento sta prendendo il posto dei classici oliveti , per secoli icone di un paesaggio tipico e secolare e di produzioni eccellenti, ma che purtroppo in questi ultimi anni hanno risentito di una competizione forte e senza scrupoli esercitata dalle produzioni di altri paese emergenti del bacino mediterraneo. In questa ottica l’olivicoltura superintensiva rappresenta una soluzione per l'olivicoltura italiana; oggi è possibile contrarre al massimo i costi con l’impiego di macchine semoventi che nascono come vendemmiatrici ma che con idonei e minimi interventi è possibile adeguare alle esigenze di raccolta in un oliveto superintensivoâ€.
Le conclusioni di Bellomo e D’Antonio sono che “i costi della raccolta con la vendemmiatrice possono risultare inferiori sia rispetto alla raccolta manuale che rispetto alla raccolta con aste scuotitrici nello stesso impianto superintensivo se si fa riferimento ad un numero di ettari superiore, nel caso di alte produzioni, ai 30 ettariâ€. E inoltre, che “i costi di raccolta per superfici superiori ai 20 ettari risultano significativamente inferiori a quelli degli scuotitori agenti in impianti tradizionali, aventi però uguale produzione specifica.
In ogni caso si ha, con l’impiego della vendemmiatrice, il notevole vantaggio di un bassissimo impiego di manodopera, che resta invariato al variare delle produzioni specifiche, al contrario delle altre macchine e attrezzature per le quali in genere cresceâ€
Quanto alle strategie relative al marketing dell’olio, il settore – come si sa – è nel vortice di una crisi terribile. Questo stato di crisi – ha sostenuto il professor Pomarici - ha sia una componente congiunturale, dovuta alla grave crisi economica internazionale, sia, invece, una componente strutturale, dovuta in questo caso al notevole squilibrio esistente tra domanda e offerta.
Una soluzione c’è: in Italia sarebbe necessaria “un’alleanza tra le diverse componenti della filiera per dare unitarietà e coerenza alle azioni promozionali interneâ€. Un problema vecchio e irrisolto, però, a ben pensarci.
Su un fronte d’azione più generale, Pomarici ritiene sia necessaria “un’alleanza promozionale che abbia in prima fila i principali paesi produttori europei (Italia, Spagna e Grecia) per stimolare la domanda internaâ€, mentre, nei Paesi non produttori, sarebbe utile far leva “sulle numerosissime qualità del prodotto e sulle sue diverse possibili utilizzazioni, ancora conosciute in modo insufficiente anche nei paesi produttoriâ€.
Guardare avanti verso solzuioni nuove, certo, va sempre bene, ma occorre riflettere anche su aspetti che non possono essere per nulla trascurati, com’è il caso del ruolo dell’olivo nel paesaggio agrario. Su questo tema è stata utile la relazione di Gianni Cicia, Mario D’Amico e Gioacchino Pappalardo. Gli olivi secolari hanno un loro ben preciso significato e valore, in quanto tali.
“Purtroppo – si legge nel testo della relazione - il quadro normativo vigente, ancora incentrato sull’antico Decreto Luogotenenziale del 1945, si mostra del tutto inadeguato soprattutto perché sono profondamente mutate le condizioni economiche e sociali che ispirarono il legislatore nell’immediato
dopoguerra. Neppure i recenti interventi legislativi di regioni come la Puglia a tutela degli oliveti secolari appaiono del tutto adeguati. Difatti, vietare tout court lo spianto di olivi secolari non garantisce affatto la conservazione del paesaggioâ€.
C’è più di un motivo per riflettere sulla valenza paesaggistica della nostra olivicoltura. E su questo gli autori della relazione non demordono: “Alla luce delle nuove funzioni riconosciute all’agricoltura – scrivono -una significativa novità potrebbe essere la messa a punto di interventi legislativi che prevedano la valorizzazione, la conservazione e la tutela degli oliveti secolari attraverso nuove forme di sostegno agli olivicoltori e l’individuazione di aree produttive di elevata rilevanza “ambientale†sulle quali puntare per trasmettere alle generazioni future un patrimonio culturale millenarioâ€.
Ma l’olivo è anche un elemento del paesaggio culturale, non solo di quello fisico. Ne relazionano i Calandrelli, Acampora e Cirillo, evidenziando come i terrazzamenti rappresentino di fatto dei fondamentali elementi del paesaggio culturale.
Il terrazzamento è il segno evidente dell’intervento dell’uomo sulla natura, molto importante e significativo per i suoi esiti sula paesaggio. Non a caso “la Comunità Europea ha invitato tutte le nazioni a proteggere i terrazzamenti come sistema fondamentale per la salvaguardia del paesaggio e la lotta alla desertificazione e al degrado dei suoliâ€.
Il terrazzamento non è dunque solo qualcosa di antico che si nega al futuro. Gli autori sono piuttosto chiari ed esplici al riguardo: “solo se riconosciuti ed esaltati nella loro valenza, gli uliveti costieri possono proporsi quali innovativi fattori di sviluppo socio-economico e nello stesso tempo garantire le funzioni ecosistemicheâ€. I terrazzamenti diventano pertanto un’ancora di salvezza per alcuni territori a rischio, e – come opportunamente sostengono gli autori della relazione – “hanno permesso la conservazione del delicato equilibrio idrogeologico dei versantiâ€, e costituiscono oltretutto “un elemento di eredità storica e culturale delle popolazioni mediterranee†che no si può affatto trascurare.
Fine prima puntata. Sul prossimo numero sarà presa in esame la sessione, relativa ai modelli colturali e alla loro gestione.
Info: sul sito della Soi link esterno e sul sito della Facoltà di Agraria di Portici link esterno
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Meccanizzazione della potatura sull'olivo: ridurre i costi su impianti tradizionali

In un contesto caratterizzato da costi di produzione crescenti e da una progressiva carenza di manodopera, la meccanizzazione della potatura dell'olivo si conferma una leva strategica per garantire la sostenibilità economica del settore
03 febbraio 2026 | 12:00
L'arca olearia
Impatto dello stress termico sulla qualità dell'olio d'oliva su olivo irrigato

Ecco come lo stress da calore influenza i parametri chiave della qualità dell'olio d'oliva, anche quando l'olivo viene irrigato. Aumenta in contenuto di olio nelle olive ma cambia il profilo in acidi grassi. Forte variabilità nei fenoli
02 febbraio 2026 | 14:00
L'arca olearia
Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione
30 gennaio 2026 | 16:00
L'arca olearia
Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio
30 gennaio 2026 | 15:00
L'arca olearia
Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza
30 gennaio 2026 | 14:00
L'arca olearia
L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti
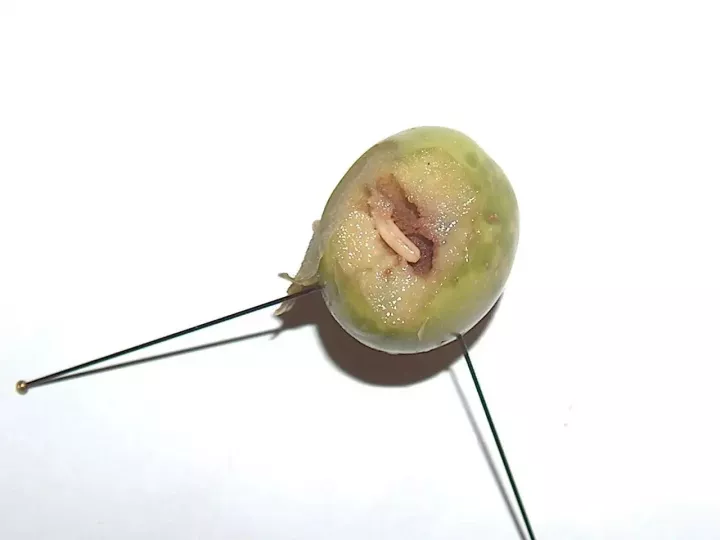
L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico
30 gennaio 2026 | 13:00






