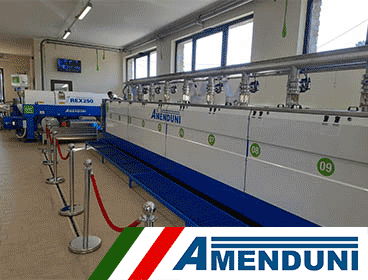L'arca olearia
L'evoluzione della mosca dell'olivo e i rischi per il futuro dell'olivicoltura

Anche la mosca dell’olivo si è coevoluta con la domesticazione della pianta, dalla varietà ancestrale sylvestris all’attuale olea europaea. Diffusione ed evoluzione pongono nuove sfide
31 ottobre 2024 | 14:00 | Alessandro Vujovic
I metodi di studio, della domesticazione dell’olivo, hanno dimostrato che l’attuale genere Olea, specie europaea, subs. europaea, varietà europaea, deriva dalla varietà sylvestris, la quale ha colonizzato l’area mediterranea da 37 a 23 milioni di anni BP (Before Present, l’anno zero come punto di riferimento del radiocarbonio 14C è il 1950), e che è sopravvissuta alle glaciazioni, anche l’ultima (Wurm 110K-11,7K), in almeno sei refugia termofili posizionati nell’area mediterranea tra il 39° e 41° parallelo (Levante meridionale, Anatolia, Penisola ellenica ed isole, sud Italia ed isole, Penisola iberica- Marocco).
 Dalle ricerche effettuate sul DNA nucleare (biparetale), DNA mitocondriale e DNA cloroplastico (questi ultimi caratteristici della trasmissione verticale, materna) degli olivi e, dallo studio dei pollini fossili, presenti nei carotaggi dei corpi idrici e delle torbiere, si è ipotizzato che la varietà sylvestris (WE, Wild Est) sia stata addomesticata, nel Levante meridionale, circa 6500 anni BP dopo una selezione genetica, il cosiddetto “collo di bottiglia”, che ha avuto luogo tra i 20.000- 10.000 anni BP.
Dalle ricerche effettuate sul DNA nucleare (biparetale), DNA mitocondriale e DNA cloroplastico (questi ultimi caratteristici della trasmissione verticale, materna) degli olivi e, dallo studio dei pollini fossili, presenti nei carotaggi dei corpi idrici e delle torbiere, si è ipotizzato che la varietà sylvestris (WE, Wild Est) sia stata addomesticata, nel Levante meridionale, circa 6500 anni BP dopo una selezione genetica, il cosiddetto “collo di bottiglia”, che ha avuto luogo tra i 20.000- 10.000 anni BP.
La base ancestrale primaria, dei pool genetici dell’olivo addomesticato (Q3), si è svolta nel Levante meridionale, dopo un “collo di bottiglia”, portando ad una selezione genetica in risposta ad eventi casuali, come la siccità o le malattie, ha contribuito all’addomesticamento delle altre aree del Mediterraneo, realizzato in periodi successivi. Difatti, l’olivo addomesticato Q3, combinandosi con la forma selvatica dell’area greca (WW, Wild West), ha determinato una nuova forma addomesticata (Q2) posizionata principalmente nel Mediterraneo centrale.
Lo stesso genotipo Q3, attraverso una selezione a “collo di bottiglia”, verificatesi tra il 711-1.492 d. C., combinandosi con la forma selvaggia WW, presente nel Mediterraneo centrale, ha determinato il genotipo Q1, che ha colonizzato la Penisola iberica ed il Marocco.
Le ricerche hanno anche definito che il germoplasma addomesticato Q1, è il risultato della combinazione genetica tra l’apporto maschile del genotipo addomesticato in oriente, il Q3, e quello femminile selvaggio WW già presente in tale area da prima delle glaciazioni.
La forma sylvestris orientale WE, interessata nell’addomesticamento primario, si era separata dalla forma sylvestris WW, presente nell’area centrale del Mediterraneo, 3,79 milioni di anni fa (range 1,66-6,17).
In conclusione a questa premessa, possiamo riassumere che si sono formate tre basi ancestrali dei pool genetici dell’olivo addomesticato Q1, Q2, Q3, caratteristici, rispettivamente, dell’area occidentale, centrale ed orientale del Mediterraneo.
Inoltre sappiamo che, la Batrocera oleae, della quale non abbiamo materiale di studio nei millenni che ci hanno preceduto, trasporta nel suo bulbo esofageo - faringeo e nell’intestino un batterio simbionte obbligato (Candidatus Erwinia dacicola), una Enterobacteriacea che ha un ruolo fondamentale nella riproduzione dell’insetto; questo simbionte primario (dal greco sýn = insieme e bíōsis = vivere) viene trasmesso verticalmente dalla madre alla prole e può aiutarci come marcatore di eventi passati.
Alcuni studi hanno dimostrato che le larve che si sviluppano da uova deposte da adulti, qualora private dei batteri simbionti, non sono in grado di svilupparsi nelle olive, anzi se il bulbo faringeo della mosca è privo della sua tipica microflora simbionte residente, diventa molto più soggetta ad essere invaso da altre specie microbiche, che possono spesso dare origine ad infezioni deleterie per l'insetto stesso.
Il batterio Candidatus Erwinia dacicola è il principale simbionte residente persistente nelle popolazioni di B. oleae da millenni; la sua relazione con l’ospite è stata studiata sin dall’identificazione nel 2005 ed è stato definito da Capuzzo, come una specie batterica non coltivabile (sia in aerobiosi che in anaerobiosi).
Questo endosimbionte è trasmesso verticalmente per via materna, alla generazione successiva, durante l'ovideposizione dalla femmina all'uovo; pertanto esiste in ogni fase dello sviluppo, sebbene sia più abbondante nelle larve e nelle femmine che depongono le uova, ma rimane necessario sia per le larve che per gli adulti. La madre, dotata di ghiandole perianali contrattili, ripiene di batteri, trasmette i simbionti alle uova durante l’ovideposizione; infatti una massa simile a un cappuccio batterico si trova tipicamente intorno al micropilo dell’uovo.
Le condizioni ambientali interne e le risorse dell'insetto sono ampiamente controllate dall'ospite, che fornisce un ambiente più isolato e quindi sono meno direttamente suscettibili ai cambiamenti nell'habitat esterno.
Per quanto riguarda le larve, il batterio concorre alla detossificazione dell’oleuropeina, un glucoside fenolico tossico presente naturalmente nella polpa delle olive e successivamente, durante la fase adulta del dittero, il batterio svolge un ruolo fondamentale nella degradazione di composti azotati altrimenti inaccessibili alla mosca. Difatti, la frazione proteica è un fattore limitante per B. oleae, in quanto la risorsa principale di azoto nella dieta è fornita dagli escrementi di uccelli e l’azoto in essi presente è legato all’acido urico, all’urea ed ai sali di ammonio. La B. oleae non è in grado di degradare purine ed urea; pertanto, la dieta della mosca dell’olivo tende ad essere sbilanciata a favore di aminoacidi non essenziali o contenenti composti azotati non accessibili, questo pone delle limitazioni soprattutto per le femmine che hanno necessità di quantità proteiche maggiori rispetto ai maschi, per la produzione di uova.
Questa relazione mutualistica con il simbionte, è un fattore che ha permesso il successo evolutivo di entrambi, grazie alla flessibilità alimentare legata appunto a questi organismi presenti nel tratto digerente, fenomeno comune anche ad altri insetti.
Poiché, già dal 2005, si sono trovate difficoltà tecniche alla coltivazione del batterio, si è pensato al sequenziamento, del gene 16S rRNA, che è una specie di carta di identità dei microbi, e, nel contempo, anche quella dell’aplotipo mitocondriale (materno) della mosca, permettendo di riconoscere diversi modelli biogeografici di interazione mosca-batterio.
È stata identificata una associazione sia genetica che geografica tra batterio e mosca ospite, con tre aplotipi batterici: htA, htB, htP.
In pratica anche il batterio e la mosca hanno seguito l’evoluzione genetica degli olivi, nei precedenti millenni, nell’area del Mediterraneo.
In particolare il lavoro di Isabel Martinez-Sanudo e Collaboratori, riporta tre aplotipi batterici del rRNA 16S e precisamente: l’htP presente solo in Pakistan come relitto di una antica separazione; l’aplotipo htA presente nella popolazione del Mediterraneo occidentale (Penisola iberica, Marocco, Algeria, Francia, compresa la Corsica e la Sardegna e Regione Liguria) e Sud Africa; l’aplotipo htB esclusivo del Mediterraneo orientale (Egitto, Israele, Palestina, Iran, Cipro e Turchia, eccetto Creta). L’htB è presente anche in California e la mosca ha colonizzato il continente americano nel 1998.
Le popolazioni del Mediterraneo centrale, hanno prevalentemente (per 82%) l’aplotipo del Candidatus Erwinia dacicola htB (Italia, Croazia, Slovenia e Grecia) ed in bassa percentuale (per il 18%) l’htA, dimostrando che la genetica delle cultivar dell’olivo dimostra che un lignaggio precoce è limitato al Levante vicino Oriente, forse l’attuale Siria e Turchia.
Interessante anche il fatto che nel bulbo esofageo della stessa mosca, non coesistevano diversi aplotipi del batterio simbionte.
Quindi il sospetto che genera questa ricerca, che ritengo importante, è che i processi di domesticazione dell’olivo, corrispondenti al lignaggio E1, limitato all’Oriente, (DNA dei cloroplasti) siano correlati con la Candidatus Erwinia dacicola htB, mentre i clorotipi E2 ed E3 sono specifici, rispettivamente delle aree occidentali e centrali del Mediterraneo.
Bibliografia
Capuzzo C. et al. 2005, ‘Candidatus Erwinia Dacicola’, a coevolved symbiotic bacterium of the olive fly Bactrocera oleae (Gmelin). J. Syst. Evol. Microbiol.55, 1641–47. Bigiotti G. et al. 2021, Bacterial symbiosis in Bactrocera oleae, an Achilles’ heel for its pest control. Insect Science, 28, 874–884, DOI 10.1111/1744-7917.12835 Mazzon L. et al. 2017, Considerazioni filogenetiche e biogeografiche su “Candidatus Erwinia dacicola” e prospettive per l’allevamento di Bactrocera oleae (Rossi). Atti Accademia Nazionale Italiana Entomologia. Anno LXIV, 216; 85-91. Martinez-Sanudo I. et al. 2024, The biogeographic patterns of the olive fly and its primary symbiont Candidatus Erwinia dacicola across the distribution area of the olive tree. Scientific Reports 14(1):22483. DOI:10.1038/s41598-024-73055-x
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Gli olivi monumentali di Ostuni e la sfida della convivenza con la Xylella fastidiosa

La positività molecolare non coincide necessariamente con sintomatologia grave. In zona infetta la convivenza controllata può essere possibile in determinate condizioni, soprattutto per alberi monumentali ad alto valore paesaggistico
26 febbraio 2026 | 16:00
L'arca olearia
La risposta agli stress ambientali dell'olivo e l'influenza su fioritura e alternanza di produzione

Messa in discussione l’idea che l’alternanza di produzione dell’olivo sia un carattere puramente genetico. All’origine del fenomeno vi sarebbero soprattutto fattori ambientali che influenzano la fioritura
26 febbraio 2026 | 14:00
L'arca olearia
Lady oleuropeina: quando l'olivo regala benessere e salute

Porre attenzione a comportamenti sostenibili rappresenta un investimento sul futuro. I sottoprodotti come sansa, acque di vegetazione e foglie dell'olivo possono trasformarsi da rifiuti in risorse. Ecco un esempio concreto
26 febbraio 2026 | 12:00 | Giosetta Ciuffa
L'arca olearia
Un nuovo modello predittivo per rivoluzionare la raccolta delle olive

Ecco un modello predittivo in grado di stimare l’accumulo di olio nelle olive sulla base di variabili climatiche come temperatura, radiazione solare e precipitazioni e con un livello di accuratezza vicino all’80%
26 febbraio 2026 | 10:00
L'arca olearia
Senza acqua non si fa olio: il fabbisogno irriguo dell'olivo

L'irrigazione a deficit controllato ha un effetto positivo sulla regolazione della crescita vegetativa e permette una buona produttività ma in un oliveto superintensivo si può risparmiare solo il 22% dell'acqua irrigua senza penalità sulla produzione
25 febbraio 2026 | 14:00
L'arca olearia
L'influenza di temperatura, umidità e CO2 sullo sviluppo della lebbra dell'olivo

Anche bassi livelli di incidenza di lebbra dell'olivo possono compromettere la qualità organolettica e nutrizionale dell’olio d’oliva, riducendone il valore di mercato. L'importanza dei fattori ambientali sul suo sviluppo
24 febbraio 2026 | 14:00