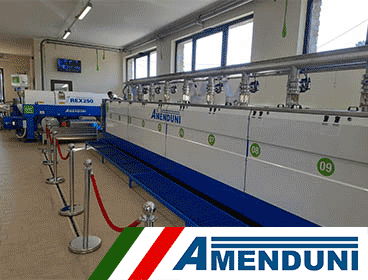L'arca olearia
L'espressione genica nell'olivo determina la risposta alle malattie, compresa Xylella fastidiosa

Oltre al DNA c'è di più. Non è il solo filamento di informazione genetica a fare la differenza ma anche un network di internazioni che determinano tratti agronomici ma anche fisiologici dell'olivo
22 aprile 2022 | Alessandro Vujovic
La trascrittomica è una scienza “omica” intendendo con questo termine l’applicazione biotecnologica che ha un potere d’indagine molecolare esteso all’intero potenziale codificante della cellula. Le scienze omiche sono:
 • la genomica, che studia tutti i geni di un organismo. Genetica e genomica non sono la medesima cosa: infatti tutto ciò che è omico è globale, comprensivo, abbraccia una grande quantità di informazioni. La genetica guarda al singolo gene, la genomica tutti i geni confrontando il patrimonio genetico di organismi appartenenti a specie diverse (genomica comparativa) o descrivendo le funzioni, le interazioni dei geni e quelle dei loro prodotti (genomica funzionale).
• la genomica, che studia tutti i geni di un organismo. Genetica e genomica non sono la medesima cosa: infatti tutto ciò che è omico è globale, comprensivo, abbraccia una grande quantità di informazioni. La genetica guarda al singolo gene, la genomica tutti i geni confrontando il patrimonio genetico di organismi appartenenti a specie diverse (genomica comparativa) o descrivendo le funzioni, le interazioni dei geni e quelle dei loro prodotti (genomica funzionale).
• la trascrittomica, si occupa dell'espressione dei geni studiando i vari RNA messaggeri (mRNA) di un intero organismo, di un particolare organo, tessuto o cellula, nel momento dello sviluppo, in particolari condizioni, in risposta a vari stimoli ambientali oppure a differenti nutrienti. Le diverse caratteristiche delle cellule dipendono da quali geni del DNA sono “accesi” e da quali no. Quindi la trascrittomica studia a che livello, ed in che ordine temporale, i geni di un organismo sono trascritti dal DNA in mRNA dal quale derivano le proteine. L’espressione dei trascritti si modifica a seconda delle condizioni ambientali extra- ed intra-cellulare.
• La proteomica (studia il Proteoma = PROTEine codificate dal GenOMA), si occupa dell'insieme di tutte le proteine di un tessuto o cellula, con l'obbiettivo di determinarne la sequenza amminoacidica, la funzione, la struttura tridimensionale e le sue interazioni. È la componente tradotta del trascrittoma, ma in molti casi le proteine espresse da una cellula possono differire dai geni trascritti per le modificazioni post-traduzionali e post-traslazionali. Mentre il genoma è costante, per una data cellula, identico per tutte le cellule di un organismo vivente, il proteoma è molto dinamico nel tempo, in risposta a fattori esterni, differendo in maniera sostanziale tra i diversi tipi cellulari. Le proteine cellulari possono avere un ruolo strutturale oppure funzionale, tra queste i messaggeri intra- e intercellulari, i recettori, gli enzimi…responsabili delle varie attività cellulari.
• La metabolomica, si occupa del metabolismo, individuando la quantità dei diversi metaboliti, analizzati con tecniche biochimiche, nonché specifici saggi di attività enzimatica. La quantità e l’identità dei metaboliti sia primari che secondari, possono variare in funzione dello stato fisiologico della cellula.
L’Omica, come detto, fa riferimento a un concetto di totalità; diventa facile capire che dietro questa scienza si nasconde una grande quantità di dati che non possono essere gestiti e interpretati se non attraverso la bioinformatica.
Sappiamo oggi che non è il solo DNA, del dogma di Watson e Crick, a determinare la differenza nel comportamento ma è l’espressione genica, la sua regolazione, le modifiche post-trascrizionali e post-traduzionali a cui le proteine vanno incontro, cioè sono le network di interazioni che si vengono a creare tra le tre componenti del dogma: DNA, RNA, proteine.
L'analisi del trascrittoma, dell’olivo, si è concentrato sulla variabilità dell'espressione genica attraverso una descrizione qualitativa e quantitativa dei trascritti di “RNA differenzialmente espressi” da piante esposte alle stesse condizioni di stress ambientale, come strumento di studio della diversità individuale (Imadi S.R. 2015).
Nell'olivo, i primi studi di trascrittomica hanno affrontato l'identificazione di geni associati a tratti agronomici, come lo sviluppo delle drupe, degli organi riproduttivi, del metabolismo dei frutti, del contenuto fenolico e dei flavonoidi e antociani durante la maturazione (Alagna F. 2012, Iaria D.L. 2016, Carmona R. 2015).
La trascrittomica è stata utilizzata per studiare la filogenesi delle tribù di Oleae e per l’identificazione della genetica dei genotipi selvatici (Mariotti R. 2020, Olofsson J.K. 2019).
L'avvento di tecniche di “sequenziamento di nuova generazione” ha migliorato l'analisi del trascrittoma, rendendolo, un potente metodo per identificare i marcatori molecolari associati sia alle variazioni della sequenza genica che alle variazioni dell’espressione genica, soprattutto come risposta dell'olivo a stress biotici e abiotici.
È stata studiata “l'espressione genica differenziale” in relazione a variazioni del contenuto di acidi grassi totali del frutto in condizioni ambientali avverse, come in condizioni di freddo (Leyva-Perez M. 2015), di stress salino (Mousavi S. 2019, Moretti S. 2019) o di siccità (Hernández M.L. 2018).
Gros-Balthazard nel 2019 ha utilizzato le sequenze di RNA, per studiare la storia evolutiva dell'olivo, confrontando “geni differenzialmente espressi” nelle accessioni selvatiche e coltivate, individuando i momenti di selezione che hanno supportato l’evento di addomesticamento Mediterraneo orientale, seguito dalla dispersione verso ovest e una successiva commistione con gli olivi selvatici occidentali.
La risposta trascrizionale alla mosca dell'olivo (Bactrocera oleae ) ha rivelato differenze tra varietà tolleranti e suscettibili (Olea europaea L.) (Grasso F. 2017) e la resistenza coinvolge, molte vie metaboliche in risposta allo stress ossidativo, la stessa struttura cellulare, la segnalazione ormonale ed il metabolismo primario e secondario.
Alcuni autori (Leyva-Perez 2018) (Serrano A. 2020) hanno studiato la resistenza dell'olivo al fungo Verticillium dahlia, con l'analisi dei profili trascrittomici differenziali delle cultivar tolleranti e suscettibili, Frantoio e Picual, consentendo il riconoscimento di proteine correlate alla patogenesi coinvolte nei processi di lignificazione, come marker per la selezione di genotipi tolleranti.
Un approccio simile è stato utilizzato per studiare la “Sindrome da declino rapido dell'olive” causata dal batterio Xylella fastidiosa ssp. pauca. Il confronto tra trascrittomi basali e quelli infetti dei tessuti dello xilema della cultivar Leccino, tollerante, e dell’Ogliarola salentina, suscettibile, ha mostrato il coinvolgimento e la sovraregolazione dei geni, nella cv tollerante, che codificano per le famiglie delle chinasi simil-recettore ricca di leucina (RLK, leucine-rich repeat receptor-like kinasechinasi) e le proteine ​​simili ai recettori (RLP) (Giampetruzzi A. 2016),
Questa risposta è predominante nel Leccino e manca nell’Ogliarola salentina. Inoltre, entrambe le cultivar reagiscono con un forte rimodellamento delle proteine ​​della parete cellulare.
Sempre con analisi trascrittomiche (Novelli S. 2019) è stato evidenziato che X. Fastidiosa ha causato un accumulo di radicali dell’ossigeno (ROS) nei campioni di Leccino rispetto alla Cellina di Nardò. Inoltre, l'infezione ha indotto la sovraregolazione di geni correlati alla difesa, come la NADPH ossidasi, alcune protein-chinasi, fattori di risposta delle piante ai patogeni e alcuni enzimi metabolici. Infine il Leccino migliora la produzione di specifiche molecole antiossidanti e antimicrobiche, per combattere il patogeno ed evitarne la diffusione nei vasi xilematici. In particolare, alte concentrazioni di ROS, attivano le vie di segnalazione della difesa della pianta e che possono rappresentare un fattore chiave nella lotta all'infezione da Xylella.
Le analisi dei composti fenolici, nelle foglie sane e infette, di Leccino e Cellina di Nardò, hanno mostrato una riduzione dell'idrossitirosolo glucoside e solo nel Leccino, un aumento dell'acido chinico, precursore della lignina, la cui deposizione gioca un ruolo importante.
Per determinare se la biosintesi della lignina è coinvolta nella risposta di difesa, è stata studiata l'espressione di geni che codificano enzimi della via del fenilpropanoidi, geni della lignina e la cinnamoil-CoA reduttasi (Sabella E. 2018).
Nelle piante infette di Cellina di Nardò, la Cinnamato-4-idrossilasi (C4H) e la 4-Cumarato:CoA Ligasi (4CL) sono risultate fortemente sottoregolate, indicando una risposta fitopatologica poiché l'inibizione di C4H promuove l'accumulo di acido benzoico e acido salicilico, come segnali di difesa. Invece, nel Leccino, la Cinnamoil-CoA reduttasi è sovraregolato nelle piante infette, mentre la polifenolo-ossidasi, è sottoregolata. La quantificazione della lignina nei rami sani e in quelli infetti, di entrambe le cultivar, ha mostrato un aumento significativo nel Leccino infetto rispetto alla cultivar sensibile; inoltre, le osservazioni istochimiche delle sezioni del fusto hanno presentato una diversa distribuzione della lignina nello sclerenchima e nel tessuto xilematico delle piante di Leccino infette rispetto a quelle sane. I risultati suggeriscono un ruolo critico della lignina nella tolleranza della cultivar Leccino alla Xylella fastidiosa
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Gli effetti del carico produttivo e del deficit idrico sul profilo fenolico delle olive

Il diradamento delle olive, simulando una cascola precoce, influisce in modo limitato sull’accumulo di olio nel frutto. Il deficit idrico determina una diminuzione significativa della resa in olio già dalle fasi intermedie di maturazione. L'impatto sui fenoli
27 febbraio 2026 | 16:30
L'arca olearia
Intelligenza artificiale per l'olivicoltura: cosa sa fare e cosa ancora no

E' possibile utilizzare l'IA per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi di produzione, manutenzione e raccolta delle olive. Algoritmi di Deep Learning come Convolutional Neural Networks per l'identificazione della cultivar e la classificazione delle malattie fogliari e la previsione dei raccolti con elevate accuratezze
27 febbraio 2026 | 16:00
L'arca olearia
Differenziazione fiorale e dinamiche di allegagione nell'olivo

La differenziazione fiorale si avvia diversi mesi prima dell’antesi e comprende due fasi: induzione, regolata da segnali endogeni e da accumulo di freddo invernale, e differenziazione morfologica. L'equilibrio dinamico tra genetica, fisiologia e ambiente
27 febbraio 2026 | 15:30
L'arca olearia
Il contributo dell'olivo al mantenimento della stabilità del suolo e contro il dissesto idrogeologico

Gli olivi adulti forniscono un contributo comparabile a vigneti con inerbimento permanente, pur risultando inferiori a boschi. Tuttavia, rispetto a vigneti totalmente lavorati o aree arate, anche gli olivi garantiscono una riduzione apprezzabile della suscettibilità al dissesto
27 febbraio 2026 | 14:40
L'arca olearia
Gli olivi monumentali di Ostuni e la sfida della convivenza con la Xylella fastidiosa

La positività molecolare non coincide necessariamente con sintomatologia grave. In zona infetta la convivenza controllata può essere possibile in determinate condizioni, soprattutto per alberi monumentali ad alto valore paesaggistico
26 febbraio 2026 | 16:00
L'arca olearia
La risposta agli stress ambientali dell'olivo e l'influenza su fioritura e alternanza di produzione

Messa in discussione l’idea che l’alternanza di produzione dell’olivo sia un carattere puramente genetico. All’origine del fenomeno vi sarebbero soprattutto fattori ambientali che influenzano la fioritura
26 febbraio 2026 | 14:00