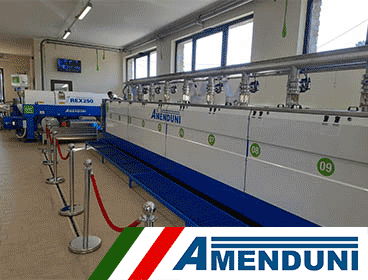L'arca olearia
L'elogio dell'oliera, oggetto quotidiano dal gusto retrò
L'oliera non è certo il contenitore per conservare l'olio extra vergine di oliva ma non si merita di finire vituperata e umiliata. E' parte della nostra cultura olivicolo-olearia. Che si tratti di pezzi di vetro o oggetti artistici, rappresentano comunque un pezzo di storia
09 febbraio 2018 | Marco Antonucci
 (Forse non tutti sanno che) L’oliera nasce con la caduta dell’impero romano, quando la produzione e la commercializzazione dell’olio diminuiscono così drasticamente che diventa talmente raro e prezioso da essere considerato in alcuni casi come denaro contante e si rendono necessari contenitori di forma ridotta e riconoscibile.
(Forse non tutti sanno che) L’oliera nasce con la caduta dell’impero romano, quando la produzione e la commercializzazione dell’olio diminuiscono così drasticamente che diventa talmente raro e prezioso da essere considerato in alcuni casi come denaro contante e si rendono necessari contenitori di forma ridotta e riconoscibile.
Nelle epoche precedenti e sino al medioevo l’olio nell’uso quotidiano si versava direttamente dalla brocca.
Anche se dopo l’anno mille le necessità ecclesiali riattivarono la coltivazione (erano infatti gli ordini religiosi a possedere la maggior parte degli olivi ancora coltivati perché gli oli consacrati erano presenti in ogni chiesa e le lampade sugli altari potevano essere alimentate solo dall'olio d'oliva), l'olio per uso alimentare si trovava solo nelle famiglie molto ricche e nei conventi: in questo periodo storico il grasso più comune utilizzato era la sugna.
Questa scarsità di prodotto ha fatto quindi nascere l’esigenza di un contenitore più piccolo e robusto, per portare direttamente in tavola l’olio, insieme agli altri condimenti quali il garum (condimento a base di pesce macerato in spezie e vino), il miele, le salse a base di semi odorosi e l’aceto. Le prime oliere furono realizzate in terracotta, solitamente prive di tappo, una sorta di mini-brocca che aveva una funzione simile all’acetabolo (recipiente da tavola per aceto) e che poggiava su un unico supporto insieme a sale, pepe e spezie: con questo nuovo tipo di recipiente si inizia a diffondere il concetto di “contenitore per uso finale” che può essere facilmente identificato (essendo inedito) e trasportabile.
 Con l’avvento del rinascimento la gastronomia non subisce una grande trasformazione, piuttosto un perfezionamento, un arricchimento e un accrescimento in senso edonistico: sulla tavola compaiono le forchette, i bicchieri individuali, gli stuzzicadenti, i tovaglioli… E tra questi l’oliera, già presente sulle tavole, supera il concetto di semplice contenitore per diventare oggetto di attrazione, di valore, espressione della classe sociale. I materiali cambiano e si affinano: la terracotta rimane in cucina per lasciare spazio a ceramica, metallo e vetro.
Con l’avvento del rinascimento la gastronomia non subisce una grande trasformazione, piuttosto un perfezionamento, un arricchimento e un accrescimento in senso edonistico: sulla tavola compaiono le forchette, i bicchieri individuali, gli stuzzicadenti, i tovaglioli… E tra questi l’oliera, già presente sulle tavole, supera il concetto di semplice contenitore per diventare oggetto di attrazione, di valore, espressione della classe sociale. I materiali cambiano e si affinano: la terracotta rimane in cucina per lasciare spazio a ceramica, metallo e vetro.
Dal Re Sole alla Rivoluzione Francese è un tripudio di nuovi prodotti e cibi che richiedono recipienti particolari: la farina di mais e la polenta, la maionese, il soufflé, il foie gras, il cacao americano e il tè cinese, solo per citarne alcuni. In questo cambiamento l’oliera mantiene invariati la forma e la mansione, ma accresce la sua funzione rappresentativa, con l’utilizzo di materiali sempre più pregiati quali l’argento, l’oro cesellato, le pietre preziose il cristallo e il vetro soffiato; sulle credenze delle sale da pranzo vengono sfoggiati dei ménage (set completo di oliera, acetiera, spargisale e pepe) sempre più prestigiosi, vanto e dimostrazione del ceto sociale raggiunto.
 Dobbiamo attendere il dopoguerra per vedere il primo stravolgimento del concetto di oliera: l’avvento della plastica rigida e morbida infatti consente la realizzazione di forme inusuali e colorate che non hanno più corrispondenza con la funzione dell’oliera e spesso scivolano nel kitsch (nella definizione di Gillo Dorfles), negandone anche il ruolo rappresentativo. Più o meno nello stesso periodo la Bauhaus prima e il razionalismo/funzionalismo poi l’hanno trasformata in un mero oggetto di “disegno industriale” nel quale il concetto di forma/funzione viene enfatizzato fino all’estremo, arrivando alla completa destrutturazione dell’idea stesso di oliera.
Dobbiamo attendere il dopoguerra per vedere il primo stravolgimento del concetto di oliera: l’avvento della plastica rigida e morbida infatti consente la realizzazione di forme inusuali e colorate che non hanno più corrispondenza con la funzione dell’oliera e spesso scivolano nel kitsch (nella definizione di Gillo Dorfles), negandone anche il ruolo rappresentativo. Più o meno nello stesso periodo la Bauhaus prima e il razionalismo/funzionalismo poi l’hanno trasformata in un mero oggetto di “disegno industriale” nel quale il concetto di forma/funzione viene enfatizzato fino all’estremo, arrivando alla completa destrutturazione dell’idea stesso di oliera.
Ma lo stravolgimento più grande avviene con l’approvazione della legge 161 del 30/10/14 con la quale si introduce il tappo antirabbocco per le bottiglie di olio extra vergine di oliva utilizzate nei pubblici esercizi: una norma che nella maggior parte dei casi è stata presentata dai mezzi di comunicazione come “una legge che vieta l’oliera”, trasformando questo oggetto che ci accompagna da secoli in un fuorilegge, una sorta di minaccia per la nostra gastronomia e cultura.
Certo, l’oliera non è il miglior contenitore per conservare l’olio, non è facile da lavare, necessita di massima pulizia e attenzione…. Ma non si merita una fine così umiliante.
Ecco perché mi permetto di dedicarle questo elogio.
Bibliografia
- Tomas Maldonado, Disegno Industriale: un Riesame, Feltrinelli economica, Milano 1988
- Gillo Dorfles, Introduzione al Disegno Industriale, Einaudi, Torino, 1972
- Gillo Dorfles, Il Kitsch, Mazzotta Editore, Milano, 1990
- Marco Antonucci, Dai Greci ai Giorni Nostri. La Storia dei Contenitori, in “Olivo e Olio”, n. 6, anno XVI, Giugno 2013
- C.Knight, J. Glaser, Etichette, Confezioni ed Espositori, Logos, Modena 2008
- F. Rosa, S. Silliani a cura di, Consumatore, Alimenti e Marketing: fra Globalizzazione e Culture Locali, Forum Edizioni, Udine 2001
- Giovanna Tonelli, Ricchezza e Consumo: il Lusso di una Famiglia Nobile Milanese nei Primi Anni dell’Ottocento, in Mediterranea. Ricerche Storiche, anno IV, dicembre 2007.
- L’Evoluzione della Cucina nel Tempo, www.ipsarvespucci.it
- G. Domenici, Gli Strumenti della Valutazione, Tecnodid, Napoli 1996
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Gli olivi monumentali di Ostuni e la sfida della convivenza con la Xylella fastidiosa

La positività molecolare non coincide necessariamente con sintomatologia grave. In zona infetta la convivenza controllata può essere possibile in determinate condizioni, soprattutto per alberi monumentali ad alto valore paesaggistico
26 febbraio 2026 | 16:00
L'arca olearia
La risposta agli stress ambientali dell'olivo e l'influenza su fioritura e alternanza di produzione

Messa in discussione l’idea che l’alternanza di produzione dell’olivo sia un carattere puramente genetico. All’origine del fenomeno vi sarebbero soprattutto fattori ambientali che influenzano la fioritura
26 febbraio 2026 | 14:00
L'arca olearia
Lady oleuropeina: quando l'olivo regala benessere e salute

Porre attenzione a comportamenti sostenibili rappresenta un investimento sul futuro. I sottoprodotti come sansa, acque di vegetazione e foglie dell'olivo possono trasformarsi da rifiuti in risorse. Ecco un esempio concreto
26 febbraio 2026 | 12:00 | Giosetta Ciuffa
L'arca olearia
Un nuovo modello predittivo per rivoluzionare la raccolta delle olive

Ecco un modello predittivo in grado di stimare l’accumulo di olio nelle olive sulla base di variabili climatiche come temperatura, radiazione solare e precipitazioni e con un livello di accuratezza vicino all’80%
26 febbraio 2026 | 10:00
L'arca olearia
Senza acqua non si fa olio: il fabbisogno irriguo dell'olivo

L'irrigazione a deficit controllato ha un effetto positivo sulla regolazione della crescita vegetativa e permette una buona produttività ma in un oliveto superintensivo si può risparmiare solo il 22% dell'acqua irrigua senza penalità sulla produzione
25 febbraio 2026 | 14:00
L'arca olearia
L'influenza di temperatura, umidità e CO2 sullo sviluppo della lebbra dell'olivo

Anche bassi livelli di incidenza di lebbra dell'olivo possono compromettere la qualità organolettica e nutrizionale dell’olio d’oliva, riducendone il valore di mercato. L'importanza dei fattori ambientali sul suo sviluppo
24 febbraio 2026 | 14:00
Commenta la notizia
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Accedi o Registrati