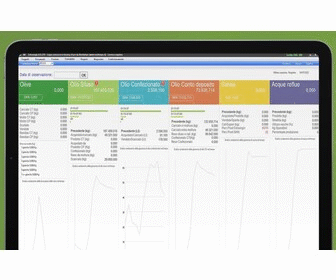Mondo Enoico
Eccessi di precipitati di quercitina nelle bottiglie di Sangiovese
Il problema spesso si verifica a distanza di anni dall'imbottigliamento. Quali interventi tecnologici possono essere attuati allo scopo di diminuire il rischio della precipitazione della quercetina nei vini rossi?
19 dicembre 2014 | R. T.
La quercetina `e un composto fenolico appartenente alla classe dei flavonoidi. Essa si trova nelle bucce delle uve bianche e colorate, prevalentemente sotto forma di glicosidi.
Al momento della pigiatura e durante la fermentazione del mosto in presenza delle parti solide dell’uva, i flavonoli diffondono dalle cellule delle bucce nel mosto. Nello
stesso tempo iniziano le reazioni di idrolisi delle forme glicosilate, con produzione degli agliconi.
 La quercetina, molecola a struttura planare, nelle sue forme di aglicone e di glicoside, può comportarsi da cofattore (copigmento), associarsi agli antociani e generare
La quercetina, molecola a struttura planare, nelle sue forme di aglicone e di glicoside, può comportarsi da cofattore (copigmento), associarsi agli antociani e generare
con questi dei complessi molecolari. Alla copigmentazione degli antociani si attribuisce un ruolo importante nella formazione del colore del vino giovane.
Se il tenore in antociani monomeri diminuisce durante la maturazione del vino, in quanto essi vengono coinvolti nelle reazioni di polimerizzazione e nella formazione di piranoantocianine, pigmenti sempre meno sensibili all’attacco degli ioni idrogenoe della SO2, vengono a mancare le molecole a cui la quercetina si associa sottraendosi agli equilibri di solubilità. Quando ciò avviene, se il tenore della quercetina supera il valore della sua solubilità ad una determinata temperatura, essa può precipitare e formare i depositi che, in qualche caso, sono stati osservati in botte e in bottiglia.
In questi ultimi anni in qualche vino rosso prodotto da uve Sangiovese, in bottiglia, è stato osservato un precipitato voluminoso di quercetina aglicone che non ne ha reso possibile la commercializzazione.
Il deposito di quercetina aglicone spesso si forma a notevole distanza di tempo dall’imbottigliamento (1,5 – 2 anni). Gli interventi di chiarifica non hanno impedito la
formazione del sedimento. Il fenomeno si è manifestato soprattutto nei vini ottenuti da uve di elevata qualità, caratterizzate da un più rilevante livello di sintesi, di concentrazione e di
estraibilità dei polifenoli a livello di bucce e da un più elevato rapporto parti solide/mosto.
E' possibile abbattere il contenuto in flavonoli – in particolare di quercetina glucoside e aglicone – per mezzo di trattamenti con PVPP, con carbone decolorante e per mezzo del contatto con l’ossigeno, senza riflessi negativi sulla qualità del vino. Gli antociani sono stati asportati o trasformati solo marginalmente da questi trattamenti.
Un contatto del vino con l’ossigeno durante la fase di maturazione, dovrebbe indurre una sua diminuzione del contenuto in quercetina.
Questo spiegherebbe, almeno in parte, perchè il deposito è stato riscontrato nei vini conservati in botti grandi in cui sono state meno intense le reazioni di ossidazione e non nei vini in barriques in cui il vino è venuto a contatto con tenori più elevati di ossigeno. La minor frequenza del fenomeno nei vini che hanno subito un maggior numero di travasi, confermerebbe queste deduzioni.
Sulla base di queste considerazioni, si può ipotizzare che anche il contatto spinto del mosto con l’ossigeno durante la fermentazione alcolica, previsto da certe tecniche
di vinificazione, potrebbe portare ad una diminuzione del tenore in quercetina. Questa ipotesi, tuttavia, deve essere verificata.
Bibliografia
Donato Lanati, Dora Marchi e Patrizia Cascio - Precipitati di quercitina nei vini - 37th World Congress of Vine and Wine and 12th General Assembly of the OIV, 06007 (2014)
Potrebbero interessarti
Mondo Enoico
Vino per le Feste natalizie: si beve meno e solo alta qualità
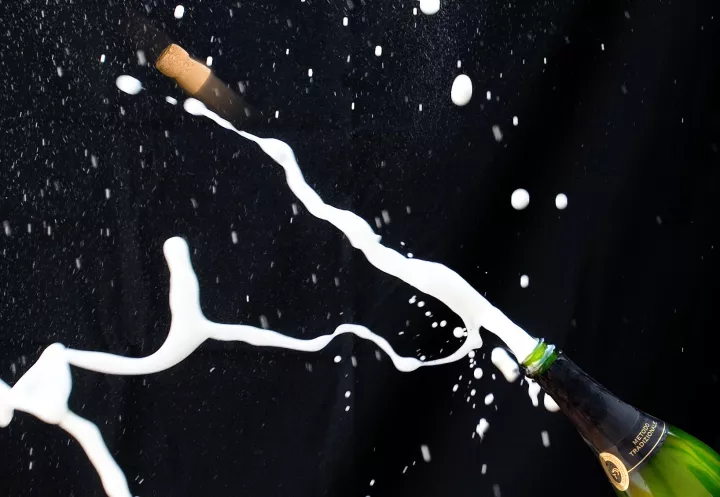
In crescita le bollicine italiane premium, come Franciacorta, Trento e Alta Langa, in calo gli Champagne medio-bassi. Nei fatidici 35 giorni di fine anno in Italia, non supereremo i 90-92 milioni di bottiglie di bollicine stappate. 240 milioni di tappi Made in Italy nel mondo
10 dicembre 2025 | 15:00
Mondo Enoico
Trattamenti fogliari per migliorare le risposte della vite alla siccità, alle alte temperature e alla salinità

Le applicazioni fogliari possono migliorare la tolleranza della vite alla salinità, alla siccità e allo stress termico modulando le risposte fisiologiche e il metabolismo secondario, sostenendo così la stabilità della produzione e la qualità dell'uva
08 dicembre 2025 | 13:00
Mondo Enoico
L'Italia è il più grande produttore mondiale di vino nel 2025

Il mercato mondiale del vino dovrebbe rimanere sostanzialmente equilibrato, poiché la crescita limitata della produzione contribuirà a stabilizzare le scorte in un contesto di indebolimento della domanda e di continue incertezze commerciali
14 novembre 2025 | 10:00
Mondo Enoico
Viticoltura hi-tech: il Politecnico crea vigneti virtuali per i trattori autonomi
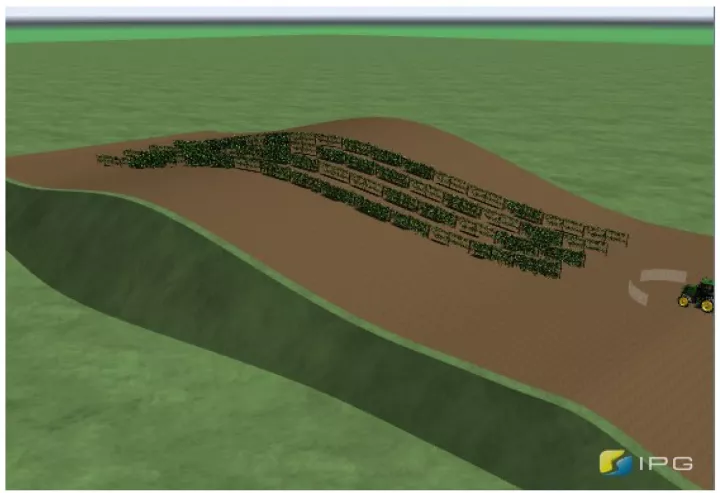
Da uno studio pubblicato su AgriEngineering nuove metodologie per simulare e controllare in modo autonomo le operazioni nei vigneti, verso un’agricoltura più efficiente e sostenibile
13 novembre 2025 | 09:00
Mondo Enoico
Le riesportazioni globali di vino valgono circa 4,55 miliardi di euro

Per quanto riguarda Italia e Francia, che sono sia produttori, sia consumatori e soprattutto grandi esportatori di vino, l’Oiv considera e stima percentuali di riesportazione dell’8% (168 milioni di litri) e del 9,6% (133,5 milioni di litri) sui rispettivi volumi di vino esportati.
11 novembre 2025 | 13:00
Mondo Enoico
Vini a bassa gradazione e dealcolati: normative e applicazioni

L’effetto della genetica e della tecnica agronomica nella produzione di vini che nascono “light” già in vigneto, grazie all’utilizzo dei cloni di vite più adatti e con una gestione che contiene il grado zuccherino dell’uva
08 novembre 2025 | 14:00