Bio e Natura
L’olivo e la vite tra i protagonisti della ricerca dell’Università di Pisa sui cambiamenti climatici
Le sfide in vigneto e in oliveto imposte dalle mutazioni del clima sono sempre più incalzanti ed urgenti. L’agricoltura di precisione, ma non solo, può rappresentare un nuovo approccio di gestione sostenibile
20 dicembre 2019 | Giacomo Palai
Negli ultimi anni gli effetti dei mutamenti del clima affliggono più o meno indirettamente la maggior parte degli aspetti della vita sociale e produttiva della nostra società. Anche il mondo accademico nelle proprie attività di ricerca si trova frequentemente ad affrontare nuove e continue criticità sollevate dalla variabile “clima”; dalle scienze agrarie all’ingegneria, dalla medicina alla giurisprudenza, tutti sono interpellati nel dare risposte alle nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici.
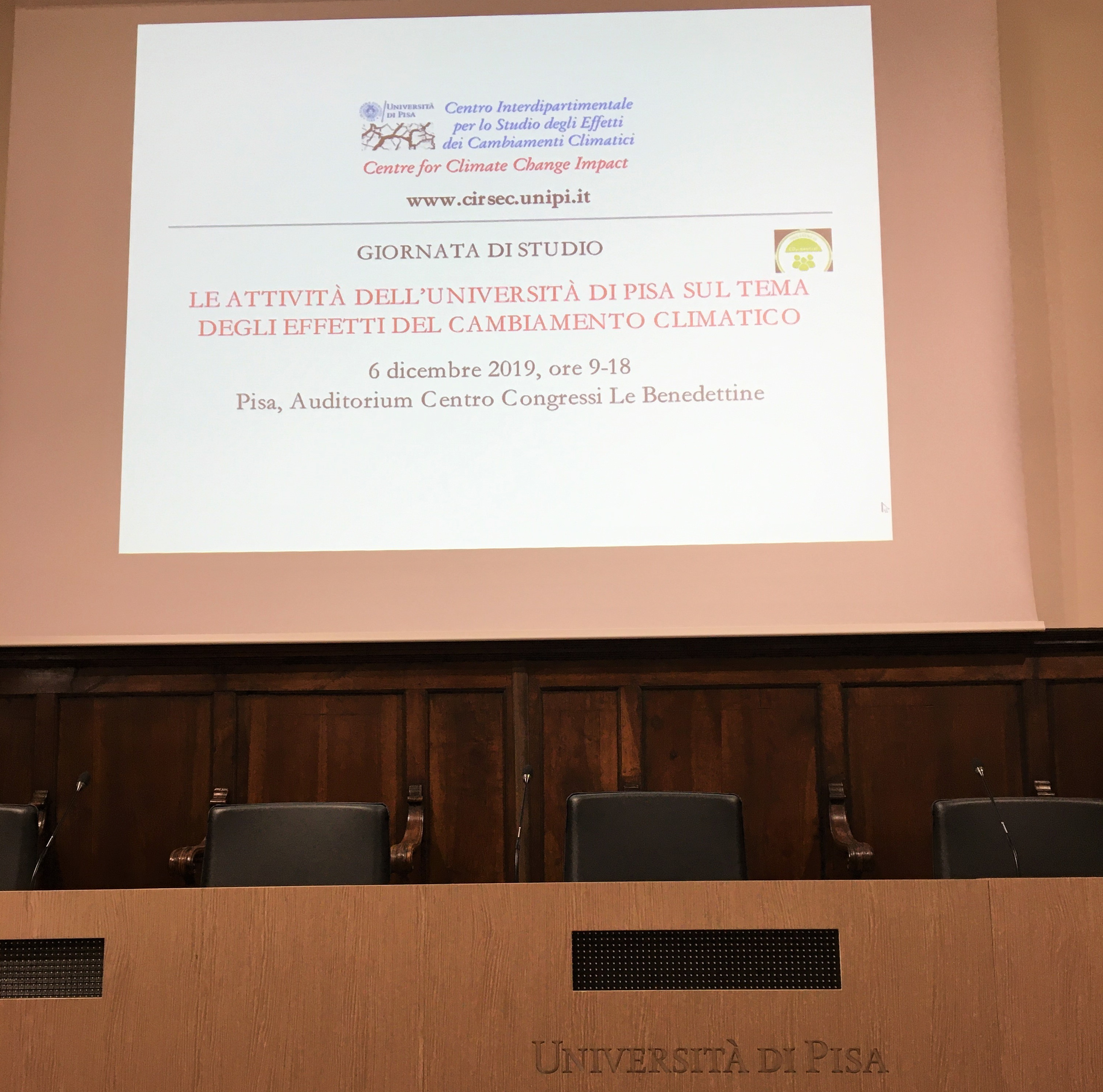 Proprio in questa prospettiva, il nuovo Centro interdipartimentale per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa è nato con l’obiettivo di mettere insieme gruppi di lavoro interdisciplinari allo scopo di promuovere e coordinare il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei prodotti della ricerca sui temi inerenti gli effetti delle mutazioni climatiche sull’uomo e sul nostro pianeta.
Proprio in questa prospettiva, il nuovo Centro interdipartimentale per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa è nato con l’obiettivo di mettere insieme gruppi di lavoro interdisciplinari allo scopo di promuovere e coordinare il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei prodotti della ricerca sui temi inerenti gli effetti delle mutazioni climatiche sull’uomo e sul nostro pianeta.
Lo scorso 6 Dicembre presso il complesso Le Benedettine di Pisa, il CIRSEC ha organizzato una giornata di studio sulle attività dell’università pisana sul tema degli effetti del climate change. Tra i vari relatori afferenti allo stesso CIRSEC, il Dott. Giovanni Caruso, docente di viticoltura ed olivicoltura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali nonché responsabile scientifico del Precision Fruit Growing Lab presso lo stesso dipartimento, ha presentato alcuni dati sulla gestione sostenibile dell’acqua e del suolo in vigneto e in oliveto in funzione degli effetti dei cambiamenti climatici. Infatti, la gestione agronomica dell’olivo e della vite sta inevitabilmente cambiando negli ultimi decenni, e nel recente passato lo sta facendo proprio in funzione delle mutazioni del clima. L’alterata distribuzione delle piogge costringe ad interventi irrigui sempre più frequenti, soprattutto quando i periodi di siccità sono molto prolungati. Allo stesso modo ma in situazioni diametralmente opposte, è sempre più necessaria un’efficace protezione del suolo da eventi piovosi molto intensi e dunque dal rischio ruscellamento, lisciviazione e fenomeni erosivi. La pratica irrigua in olivicoltura e viticoltura si è evoluta in maniera differente. L’olivo, un albero rustico, coltivato su suoli spesso marginali tradizionalmente non irrigato poiché in grado di produrre frutti anche in situazioni di forte siccità. In viticoltura invece l’irrigazione veniva considerata spesso come pratica di forzatura con effetti negativi sulla qualità. Oggi parliamo di irrigazione sia in olivicoltura che in viticoltura, riscoprendone una rinnovata importanza di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In particolare si parla di protocolli di irrigazione in deficit, ovvero l’apporto di volumi irrigui alla coltura sottoponendola allo stesso tempo a stress idrici controllati in specifiche fasi fenologiche. Dal lavoro sperimentale svolto negli ultimi anni è emerso come ad esempio sono sufficienti volumi irrigui ridotti per arrivare a raddoppiare la produzione su olivo, rispetto a piante in asciutto. In viticoltura invece, l’irrigazione può essere utilizzata per rallentare la maturazione del grappolo che proprio a causa dei cambiamenti climatici tende ad accumulare gli zuccheri troppo rapidamente costringendo a raccogliere anticipatamente spesso allontanandosi dalla maturazione fenolica e aromatica, con ripercussioni negative sulla qualità dei vini che saranno prodotti.
Gestire il suolo in modo sostenibile vuol dire utilizzare coperture vegetali in grado di ridurre fenomeni erosivi specialmente nelle aree di collina. Questo effetto positivo di solito non è accompagnato da effetti negativi sulla qualità né sulla produttività, ma anzi si ha un incremento della portanza del suolo, fondamentale per la tempestività delle pratiche agronomiche; su un suolo inerbito infatti la velocità di infiltrazione è di circa 8 volte maggiore rispetto ad uno lavorato; questo vuol dire non avere ristagni e, da un punto di vista operativo, la possibilità di entrare in campo anche il giorno dopo una pioggia.
Anche l’agricoltura di precisione può rappresentare un nuovo approccio di gestione sostenibile: ad esempio l’utilizzo di mappe di prescrizione e macchine a rateo variabile può aiutare a limitare gli input chimici, idrici ed energetici lavorando in modo sito-specifico. L’utilizzo di sensori prossimali e sulla pianta permettono di monitorare in continuo la coltura con un alto livello di dettaglio; il telerilevemento permette invece di avere una visione di insieme a livello di intero vigneto. La gestione dell’irrigazione può essere coadiuvata dall’utilizzo di mappe di induzione elettromagnetica che consentono di stimare l’umidità del terreno; con le stesse tecniche di telerilevamento è inoltre possibile ottenere ricostruzioni 3D del vigneto e dell’oliveto, che dal punto di vista pratico in termini di climate change permettono di monitorare l’incremento di biomassa delle piante, fornendoci dati utili sul sequestro del carbonio durante l’anno e utilizzabili in modelli di bilancio del carbonio della coltura stessa.
La giornata studio organizzata dal CIRSEC ha evidenziato ancora una volta gli effetti importanti che hanno i cambiamenti climatici sull’agricoltura. In particolare, nel comparto agricolo italiano e toscano, la viticoltura e l’olivicoltura rappresentano due filiere chiave da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Le sfide in vigneto e in oliveto imposte dalle mutazioni del clima sono sempre più incalzanti ed urgenti. Il mondo della ricerca è al lavoro: se vogliamo continuare ad avere delle produzioni uniche e di altissima qualità, la strada per il futuro passa proprio da una gestione agronomica attenta, sostenibile, e tecnicamente avanzata.
Potrebbero interessarti
Bio e Natura
Fitofarmaci nei suoli europei

I ricercatori hanno analizzato campioni di terreno provenienti da diverse aree del continente: circa il 70% dei suoli esaminati contiene tracce di pesticidi. Tra i più colpiti ci sono i funghi micorrizici arbuscolari, microrganismi che vivono in simbiosi con le radici delle piante
23 febbraio 2026 | 15:00
Bio e Natura
Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica
01 febbraio 2026 | 11:00
Bio e Natura
Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro
30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi
Bio e Natura
I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione
29 gennaio 2026 | 14:00
Bio e Natura
Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori
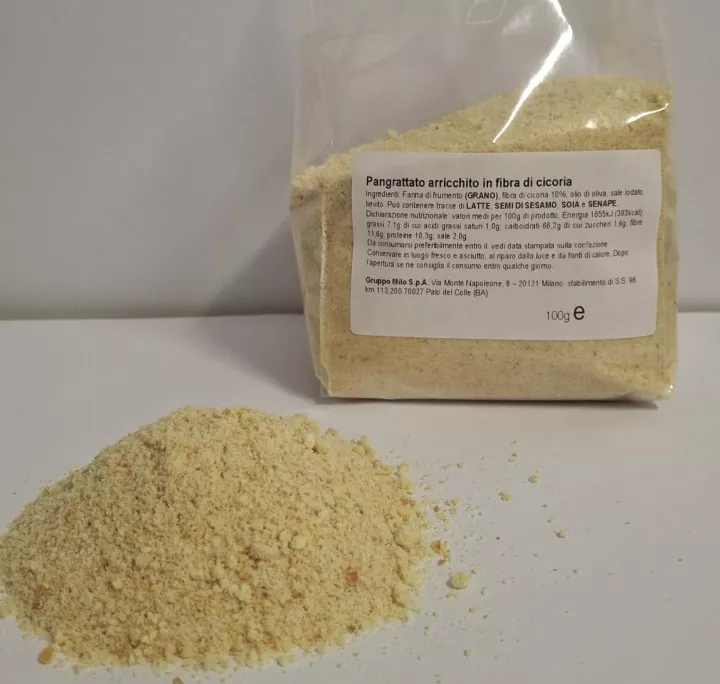
L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato
23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo
Bio e Natura
Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti
22 gennaio 2026 | 16:00






