Articoli
FERRUCCIO PARAZZOLI: "CON L'ARRIVO DELLA TV IL LINGUAGGIO RURALE HA PERSO IN CENTRALITA' ED EFFICACIA. NON E’ PIU’ PATRIMONIO COMUNE"
Sono oramai perduto, confida l'autore di "MM Rossa". Ho bisogno del rumore della città. In metropolitana, tra una folla di fantasmi, i veri attori siamo noi: ci guardiamo negli occhi per scrutarci
01 novembre 2003 | Luigi Caricato
Ferruccio Parazzoli ha da poco pubblicato per gli Oscar Mondadori, all’interno della collana “Scrittori del Novecentoâ€,MM Rossa, una discesa nel profondo, tra i sotterranei della metropolitana milanese, ma anche tra gli abissi dell’animo umano, in cerca di risposte, di segni di assoluto nel quotidiano e nell'ovvio.
Scrittore raffinato e intenso, non nasconde la propria identità di cattolico e anzi la mette in evidenza con orgoglio e senza alcun indugio. Nell’aprile 2004, uscirà , sempre per Mondadori, un suo nuovo romanzo dal titolo Resurrezione.
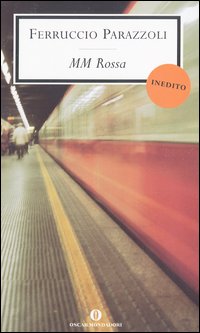
In un suo articolo apparso su “Vita Pastoraleâ€, redatto in forma di lettera, si legge una dichiarazione forte già nel titolo: “Smettiamola col gergo ruraleâ€. Destinatario della “letteraâ€, un parroco; figura reale o ideale, al quale lei rivolge l’invito a rinunciare a immagini ed espressioni di una cultura ancora rurale, di cui si è peraltro persa ogni traccia nel linguaggio comune…
Sì, mi riferivo al linguaggio della cosiddetta omiletica, che, come sappiamo tutti, è in piena crisi, proprio perché si tratta di un linguaggio oramai inadatto ai fedeli dei grandi e medi centri urbani. La mia affermazione si riferiva in particolare all’omelia, ovvero al commento del Vangelo. Gli evangelisti, noi sappiamo bene, scrivevano allora ricorrendo a espressioni e immagini che si riferivano al mondo del tempo, fondato sulla ruralità . Oggi, però, sarebbe anche ora che la Chiesa cattolica ne mutasse l’approccio.
Ma non è più soltanto il linguaggio rurale a venir meno, anche il concetto stesso di ruralità , non le pare?
Certo. Io è da tempo ormai che non vivo più in campagna. Anche se in realtà non ci sono mai vissuto. Ho trascorso tuttavia gli anni dell’adolescenza a Macerata, nell’Italia centrale, dove è nato mio padre. Erano gli anni che andavano dal ’45 al ’50. Mi trovavo immerso in una società assolutamente rurale, che ho conosciuto bene. Ma allora, va detto, non c’era la TV. Quindi si viveva tra noi, e al massimo si sentiva la radio, quell’affare lì che “parlavaâ€, la sera; ma non tutti ne avevano l’occasione e la possibilità . Ecco, allora si stava più in compagnia. Era diverso. Oggi il linguaggio si è più standardizzato, con l’arrivo della TV. Di conseguenza, tutto il linguaggio rurale è diventato un linguaggio specifico, altrettanto tecnico come quello di altre attività . Ora è un linguaggio utilizzato specificamente e in via esclusiva per determinate funzioni; non fa più parte del linguaggio comune.
Però si assiste a un ritorno alla natura. La vita in città pesa e quindi si cerca di far ritorno a una dimensione alternativa. Ed ecco il successo del turismo rurale e gastronomico. Queste nuove tendenze, seppure frutto più di una moda e di un’evasione, possono in qualche modo influire sul linguaggio della società ?
No, non credo che possano influenzare il linguaggio queste nuove tendenze. Si tratta di utopie momentanee, di fenomeni transitori. La gente vive dove lavora, dove si diverte. Si può parlare invece di “vacanzeâ€; e infatti lo sono, è un ritorno alla natura da intendersi appunto come ricerca di luoghi vacanti, vacus transitori.
E com’è il suo personale rapporto con la natura? Lei è nato a Roma, ma ha vissuto anche a Macerata…
Sì, sono nato a Roma nel periodo più brutto che ci potesse essere, tra fine fascismo e guerra, quindi negli anni di Roma “città apertaâ€. A Macerata invece ho avuto un rapporto bellissimo e diretto con la natura. E, soprattutto nell’età adolescenza, non c’era di meglio per assaporare una dimensione di libertà e appagamento.
In seguito mi sono trasferito a Milano, ch’è poi la mia vera città . Non riconosco affatto Roma, perché troppo bella e stupefacente. Non potrei viverci. Milano invece mi si confà . Oramai sono diventato strettamente metropolitano. Credo che non potrei vivere in posti diversi da Milano. Un tempo sognavo di vivere gli anni della pensione nella mia casa in Liguria, verso Sestri Levante, in collina. Pensavo di starmene lì tranquillo, a scrivere. Oggi mi sarebbe del tutto impossibile farlo per un lungo periodo di tempo. Ho bisogno del rumore di piazzale Loreto, a Milano. Ho bisogno di girare per le vie della città e fare a gomitate per guadagnare l’uscita dal portone e raggiungere l’edicola. Niente, sono oramai perduto.
Da qui dunque il suo ultimo libro, MM Rossa, dichiaratamente metropolitano…
Sì, perché non mi basta più la superficie della città . Ne adoro anche i sotterranei, dove si svolge tutta un’altra vita, ch’è certo la stessa, ma azzerata. Nella metropolitana non funzionano i cellulari, intanto. Nessuno ci pensa, ma vuol dire che restano interrotte le comunicazioni e che i veri attori siamo noi. Ci guardiamo allora in faccia, anche perché fuori non c’è niente da vedere. Solo il buio del tragitto. In autobus o in tram è diverso, non ho bisogno di guardare gli altri, perché ci sono gli alberi o altre distrazioni all’esterno. In metropolitana siamo invece pressati e dobbiamo inventarci un modo per sopravvivere quel quarto d’ora, venti minuti o mezz’ora; e non solo guardandoci in faccia, ma restando in stretto contatto corporeo. Non è facile, a pensarci. Oggi non ci si può toccare, e nemmeno sfiorare.
La MM Rossa come protagonista del suo libro diventa l’espressione vitale di una umanità più immediata, quasi un modo per disgelare e rappresentare la commedia umana. E’ forse l’unica soluzione possibile per tentare di incrociare gli sguardi, anche se in maniera un po’ titubante...
Si, con qualche titubanza, ma anche in maniera terribile e con la convinzione che quel volto, quella persona, quello sguardo lo si vede una volta e poi mai più. In un simile contesto è molto di più che essere morti. Si tratta di una folla di fantasmi, certamente corporea, al momento, ma fantomatica.
Riguardo invece a suo padre, ne viene fuori un ritratto meraviglioso e profondo; in MM Rossa si legge che auspicava di vedere la città dall’alto, avendo inventato un “eliocicloâ€, una bicicletta che per mezzo dell’elio avrebbe potuto muoversi in aria volando. Una pura voglia di evasione o un forte desiderio di inventare?
Una voglia di inventare e nel medesimo tempo anche una forma di evasione nella sua, come dire, semplicità o ingenuità lapalissiana. Si chiedeva il perché gli uomini dovessero muoversi tutti sopra il livello stradale, quando invece ci si può alzare con un sistema che lui credeva di avere inventato. Perché allora non alzarsi verso l’alto? Ma non con gli elicotteri, con una specie di bicicletta che aveva realizzato per davvero. Ci aveva provato.
Tra i suoi tanti titoli, molti hanno come riferimento l’aspetto propriamente religioso. La religiosità , dunque, quale elemento forte dell’ispirazione letteraria.
Religiosità , sì. E mi meraviglio che non sia un elemento caratterizzante per molti altri scrittori. Lei dice giustamente la religiosità , che poi non è la spiritualità , o, meglio ancora, la dimensione metafisica nel senso letterale del termine. Mi meraviglio, inoltre, di come manchi, leggendo un romanzo di un contemporaneo, questa dimensione. Non è neppure prevista, o, per lo meno, l’autore crede che una simile dimensione non possa esistere. A mio parere, invece, è impossibile sfuggire, perché le due dimensioni, del reale e del soprannaturale, si intrecciano e si mischiano in continuazione. Ecco, per me la dimensione religiosa – che per un fatto biografico si riflette nel cristianesimo – mi aiuta a sfondare i limiti della realtà , limiti che sono del tutto inesistenti. Mi annoio moltissimo a leggere romanzi che non abbiano questa uscita di sicurezza.
E’ forse una sorta di paura, da parte degli altri autori? Paura di mettersi a nudo e ammettere una propria religiosità , una dimensione che non si chiuda e si esaurisca nel dato reale e tangibile dell’esserci?
Non credo. E’ che la narrativa italiana ha una tradizione borghese e laica, a parte qualche eccezione. Molto spesso è l’emanazione di quel ghetto in cui la cultura cattolica si è chiusa da tempo, per sua colpa o a causa di altre circostanze. Il mondo cattolico se ne infischia della letteratura e dell’arte. Ha in forte sospetto il mondo della letteratura, in generale.
Infatti non esiste, nel mondo cattolico, una vera attenzione per la letteratura. La si fugge, in qualche modo…
Si non c’è e non la possono coltivare, perché il pubblico cosiddetto cattolico non ama molto leggere, tranne una certa élite che ama studiare. Si è fatto un deserto attorno alla narrativa di argomento religioso. Deserto che io sto per interrompere. E lo dico in anteprima a lei, in aprile uscirà un mio romanzo intitolato Risorgerò.
Come il mio primo romanzo, Il giro del mondo, che si svolgeva intorno a Macerata, ch’era poi la storia di un prete di campagna, anche questo narra la storia di un prete, ma di città . Ancora una volta è la metropoli ad essere protagonista.
Il personaggio centrale del romanzo è un giovanissimo prete che all’uscita del seminario viene mandato in una parrocchia di Milano, dove incontra tutto ciò che c’è da incontrare e partecipa alla vita parrocchiale e soprattutto a ciò che sta fuori, con tutti i problemi pratici e morali della vita comune. E ancora una volta si tratta di un romanzo metropolitano, ma questa volta “scandalosamente†cattolico. I temi della fede cristiana sono qui espressi nel vero senso della resurrezione della carne.
Dal prete di campagna al prete di città , dunque. Ecco, ma come si comporta oggi un prete di campagna?
Credo che sia rimasto così com’era un tempo, ma non ne ho un’esperienza diretta, tranne quando vado in vacanza. Non è cambiato molto, da allora. Tuttavia, in un periodo più lontano dal nostro si era isolati, non c’erano i mezzi di comunicazione, si viveva sotto una cappa, non circolava aria. Adesso anche l’ultimo prete dell’ultimo borgo è informato su tutto, non ha bisogno di essere chiamato dal vescovo per accedere alle informazioni. Quindi, anche se la situazione è per certi versi la medesima di prima, la testa, lo spirito, è diverso.
Lei ha dichiarato: “La parola detta ha un’altra velocità , un’altra forza, anche destabilizzanteâ€. Esistono dunque due differenti dimensioni, due differenti mondi?
Quando parlo, parlo secondo me stesso e basta. Faccio riferimento alla mia esperienza personale, a dei dati di fatto. Siamo dentro la quotidianità più immediata. Quando si scrive si entra invece in un’altra dimensione. Lo scrittore non equivale al suo libro. Gli scrittori non dovrebbero mai farsi vedere e conoscere, perché sono due identità diverse, il libro e lo scrittore. Il libro è qualcosa che nasce mentre lo si scrive. Uno può fare tutti gli schemi che vuole, lo faccio anch’io, però avviene qualcosa di rabdomantico quando si scrive, intervengono delle forze diverse…
Non dovrebbe farsi conoscere lo scrittore, lei dice. Ed effettivamente la società attuale neanche lo accetta come punto di riferimento. Spesso lo rifiuta. Ecco, non è grave il fatto che non abbia voce? Non è assurdo che il punto di vista della velina o del calciatore abbiano oggi un peso diverso e più consistente rispetto allo scrittore?
Si, non ha visibilità perché non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche nel momento estremo della morte, se va bene, la notizia viene data in coda al telegiornale, dopo tutte le altre notizie, dopo lo sport, il calcio, la Ferrari. Quando viene assegnato il premio Nobel, mai che si fornisca una scheda relativa allo scrittore. Alle volte mi arrabbio, poi ci ripenso e dico: “no, meglio cosìâ€. C’è poco da fare, la letteratura, l’arte e anche la musica, sono fenomeni di élite. Oggi si è un po’ allargata, questa fascia di utenti, ma non moltissimo; e comunque perfino l’élite stessa viene continuamente sviata dagli allettamenti dalle sirene della propaganda, dalle insidie della pubblicità trasmessa sempre e unicamente attraverso la TV. Dopo di che, ci sono i fenomeni di massa che diventano essi stessi libro. Non c’è da spaventarsi, il libro è soltanto una forma fisica, ci si può mettere dentro di tutto, perfino le barzellette di Totti. Ormai siamo nella società dello spettacolo e tutto ciò fa da effetto schiumogeno, che sottrae spazi, porta via e rende difficile l’attenzione anche per l’elite che vorrebbe una società diversa. Oggi si accede in libreria e si scoprono spazi immensi, bellissimi. A me viene però l’angoscia, perché, a parte la vetrinetta dove trovano ubicazione i best sellers secondo loro, dentro la libreria è come un sahara, dove tutto appare uguale. Lo ripeto, a me viene un’angoscia terribile. C’è per fortuna una élite simile un po’ ai monaci medievali, che non demorde e va a cercare i libri giusti, che le interessano.
Quello che appare ai nostri occhi è un fenomeno soprattutto italiano, perché altrove si legge di più e gli scrittori vendono. C’è una letteratura di intrattenimento, ma di qualità …
Già , vendono di più. Credo che dipenda da un fatto proprio culturale. Siamo stati colonizzati dall’America, che ci ha portato i propri scrittori, grossi professionisti, validi. Da noi abbiano invece continuamente coltivato una letteratura borghese o addirittura regionalistica, e nessuno, specialmente l’editoria, ha mai pensato di coltivare e allevare dei professionisti della scrittura che non puntino al sublime, ma a un prodotto di qualità . Adesso però si comincia a farlo, vedremo.
Bibliografia
Nato a Roma nel 1935, Ferruccio Parazzoli è autore di numerosi romanzi, tra cui Il giro del mondo (finalista al premio Campiello, 1977), Carolina dei miracoli (1979, pubblicato per la prima volta a puntate su "Famiglia Cristiana"), Uccelli del paradiso (finalista al premio Campiello, 1982), Il giardino delle rose (cinquina premio Strega, 1985), La nudità e la spada (1990), La camera alta (1998), Nessuno muore (2001).
Tra le opere di argomento religioso: Indagine sulla crocifissione (1982), Gesù e le donne (1989), Io credo? (1995), Vita di Gesù (1999).
Il più recente lavoro di narrativa è MM Rossa (Mondadori, 2003).
Potrebbero interessarti
Articoli
Il Premio Casato Prime Donne 2013 a Linda Laura Sabbadini
A poco più di un mese dal Decreto Legge sul femminicidio, il Premio Casato Prime Donne viene assegnato al direttore ISTAT Linda Laura Sabbadini che, per prima, ha rivelato le dimensioni della violenza sulle donne
03 settembre 2013
Articoli
Reputazione on line fondamentale per il turismo del XXI secolo
Tra difficoltà e diffidenze ecco come affrontare internet e le opportunità che offre
27 luglio 2013
