Mondo Enoico
Brettanomyces bruxellensis e Pichia guilliermondii: nemici del buon vino
Sicuramente la prima specie, anche nota come Dekkera, è più conosciuta ma l'interazione metabolica tra le due può dare risultati anche peggiori. Il vero rischio sono però le ammine biogene
19 febbraio 2011 | Graziano Alderighi
Vi sono lieviti utili, come i Saccaromiyces cerevisiae e ve ne sono altri che producono alterazioni considerevoli nel profilo aromatico di un vino.
Conoscere le potenzialità di sviluppo di questi ultimi nel mosto in fermentazione è indispensabile per evitare spiacevoli sorprese.
I Brettanomyces sono batteri pressochè ubiquitari che troviamo in diversi alimenti, come birre e formaggi. Si trovano anche sulle bucce di diversi frutti zuccherini, tra cui, naturalmente, l'uva.
Si tratta di lieviti che hanno un metabolismo ossidativo e, per alcune tipologie di substrato e di ceppo, anche fermentativo.
Ma perchè i Brettanomyces vengono considerati così pericolosi in enologia? Innanzitutto perchè producono aromi sgradevoli, riconducibili alla classe chimica dei fenoli volativi, e in secondo luogo perchè sono alcol tolleranti.
Pressochè tutti i batteri, infatti, risentono negativamente, bloccando sviluppo e crescita, di concentrazioni di etanolo anche relativamente basse.
I Brettanomyces, viceversa, non modificano il loro ritmo di crescita fino a un contenuto di etanolo dell'8%, riducendosi solo quando la concentrazione raggiunge il 10-12%, per bloccarsi definitivamente con contenuti maggiori o uguali al 14%.
Come controllare dunque i Brettanomyces?
Con l'anidride solforosa. A concentrazioni di SO2 comprese tra 0,25 mg/l e 0,8 mg/l si ha una riduzione significativa della crescita e dell'attività di questi lieviti. Sopra la soglia di 0,8 mg/l si ha la devitalizzazione del batterio.
Il problema, semmai, si può presentare in fase di fermentazione malolattica, durante la quale le concentrazioni di SO2 vanno progressivamente a ridursi. In questo caso, se il contenimento della vitalità durante la fermentazione alcolica, è stata solo parziale, si può assistere a un ritorno di proliferazione, con conseguenti alterazioni. Per impedire che ciò accada in Francia è uso utilizzare le solfatazioni continue, ovvero l'aggiunta costante di piccole dosi di anidride solforosa al vino in affinamento. Tale pratica, tuttavia, potrebbe anche risultare controproducente, stimolando la selezione di ceppi resistenti ad elevate concentrazioni di SO2.
I fenoli volatili, quali i 4-etil-fenol, 4-vinil-fenolo, 4-etil-guaiacolo e 4-etil-catecolo, responsabili, a vario titolo, di percezioni quali sudore di cavallo, cuoio, pelle, odore di medicinale, speziati anomali e molto intensi, non solo i soli composti
Se, per alcuni esperti, tali sensazioni, entro determinate soglie percettive sono persino attributi utili, certamente non possono essere considerate tali le ammine biogene, prodotte anche dai Brettanomyces. Si tratta di composti che al di sopra dei 200 mg/l possono dare risposte intolleranti o causare problemi di intossicazione. Le due molecole più studiate sono l'istamina e la tiramina. In particolare l'istamina si può trovare nei vini e sia l'Unione europea, sia alcuni Paesi del nord Europa hanno varato regolamenti per stabilirne i valori limite.
Se nel passato la ricerca si è concentrata prevalentemente sui Brettanomyces, oggi si amplia l'orizzonte per capire se l'interazione con altri ceppi batterici possa modificare il profilo chimico e aromatico dei vini.
Recentemente, per esempio, è stato studiato l'effetto di Pichia guilliermondii, in fermentazioni miste di di Dekkera bruxellensis e Saccharomyces cerevisiae.
I risultati hanno mostrato livelli significativi di 4-etil-fenolo e 4-etil-guaiacolo (720 e 545 mu g l-1, rispettivamente), e elevati livelli di 4-vinil-fenolo (> 4500 mu g l-1), quando P. guilliermondii veniva inoculato dall’inizio della fermentazione.
L’interazione metabolica che avviene tra le specie di P. guilliermondii produttrici di vinilfenolo e le specie di D. bruxellensis che presentano un’elevata attività vinilfenolo riduttasi ha come risultato una produzione maggiore di fenoli volatili nel vino.
Potrebbero interessarti
Mondo Enoico
Le cantine sono piene: quasi 61 milioni di ettolitri di vino in giacenza

Forte aumento delle giacenze dei vini rispetto a un anno fa. Il 56,8% del vino in Italia è detenuto nelle regioni del Nord ed è in prevalenza rosso con i vini varietali detenuti costituiscono appena l’1,5% del totale
13 febbraio 2026 | 09:00
Mondo Enoico
Nasce la Glera del futuro: sette nuove varietà resistenti per sostenere il Prosecco Doc e Docg

Quattro delle sette varietà resistenti nascono dal programma di miglioramento genetico autonomo di VCR e sono in fase avanzata di iscrizione al Registro varietale nazionale, con disponibilità prevista tra febbraio 2026 e fine 2027
02 febbraio 2026 | 11:00
Mondo Enoico
Aumentano le giacenze di vino nelle cantine italiane

Rispetto alla vendemmia 2024 in forte aumento sia la gicenza di vini che di mosti. Nel solo Veneto è presente il 27,1% del vino nazionale. Le prime 20 denominazioni contribuiscono al 58,4% del totale delle giacenze di vini a indicazione geografica
07 gennaio 2026 | 13:00
Mondo Enoico
Vino per le Feste natalizie: si beve meno e solo alta qualità
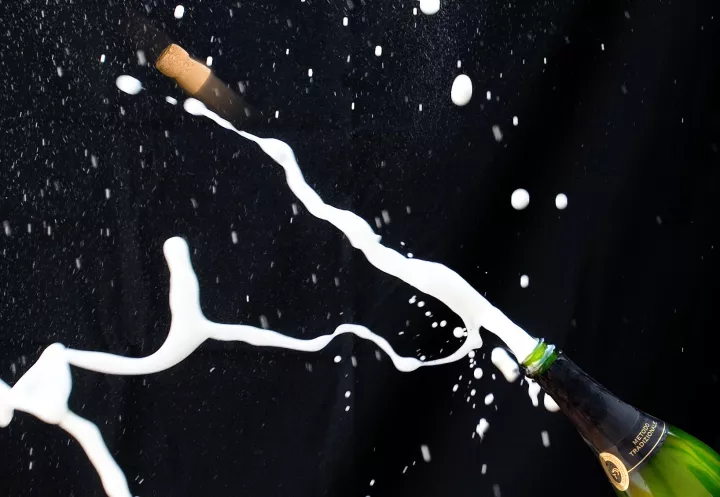
In crescita le bollicine italiane premium, come Franciacorta, Trento e Alta Langa, in calo gli Champagne medio-bassi. Nei fatidici 35 giorni di fine anno in Italia, non supereremo i 90-92 milioni di bottiglie di bollicine stappate. 240 milioni di tappi Made in Italy nel mondo
10 dicembre 2025 | 15:00
Mondo Enoico
Trattamenti fogliari per migliorare le risposte della vite alla siccità, alle alte temperature e alla salinità

Le applicazioni fogliari possono migliorare la tolleranza della vite alla salinità, alla siccità e allo stress termico modulando le risposte fisiologiche e il metabolismo secondario, sostenendo così la stabilità della produzione e la qualità dell'uva
08 dicembre 2025 | 13:00
Mondo Enoico
L'Italia è il più grande produttore mondiale di vino nel 2025

Il mercato mondiale del vino dovrebbe rimanere sostanzialmente equilibrato, poiché la crescita limitata della produzione contribuirà a stabilizzare le scorte in un contesto di indebolimento della domanda e di continue incertezze commerciali
14 novembre 2025 | 10:00






