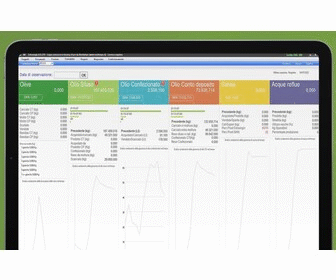L'arca olearia
Lo sguardo altrove, una critica agli olivicoltori del nostro Paese
Dopo il summit dei Paesi oliandoli di Imperia, interviene il professor Giuseppe Fontanazza per fare il punto sullo scenario mondiale. Da noi - diversamente da Spagna, Portogallo e in parte Grecia - gli aiuti comunitari non sono stati finalizzati al miglioramento delle strutture produttive e di trasformazione
09 gennaio 2010 | Giuseppe Fontanazza

Il resoconto sul “Summit dei Paesi Oliandoli a Imperiaâ€, mi spinge a fare un intervento, stimolato da quanto riportato su Teatro Naturale il 15 dicembre 2009 link esterno
Come prima considerazione faccio riferimento alla chiusura dell’incontro di Luigi Caricato per sottolineare di essere assolutamente d’accordo con quanto egli asserisce sulla opportunità di abbandonare guerre per la difesa delle frontiere nazionali dell’olivicoltura contro vecchi e nuovi Paesi produttori; sia perché l’espansione del mercato crescente richiede l’individuazione di nuove aree olivicole a livello mondiale, ma anche perché l’Italia, tradizionalmente legata alla produzione di qualità sulla base delle conoscenze e innovazioni prodotte negli ultimi trenta anni, è in grado di orientare la propria produzione e di conseguenza il mercato verso un prodotto di qualità certificata, tipica e garantita nel rispetto del consumatore mondiale, ad un prezzo ragionevole.
Il Summit che aveva come obiettivo – almeno così mi pare di capire – quello del confronto tra la nostra produzione e quella degli altri Paesi olivicoli, mi sembra non abbia raggiunto appieno lo scopo, in quanto è risultata limitata la presenza non soltanto di molti Paesi significativi, ma anche dei suoi rappresentanti più qualificati. Mi sarei infatti aspettato che a rappresentare i Paesi convenuti, seppur ripeto poco numerosi, venissero chiamati oltre che singoli produttori, funzionari pubblici, esperti del settore o dirigenti di Organizzazioni professionali in modo da meglio cogliere la reale situazione delle differenti aree olivicole del vecchio e nuovo mondo della produzione. Affermo ciò, sulla base di quanto si evince dal resoconto del Summit; le informazioni che se ne ricavano per i singoli Paesi riguardano infatti aziende specifiche o gruppi limitati non sempre rappresentativi della situazione generale. Mentre vaghe risultano le indicazioni sugli obiettivi da perseguire per raggiungere produzioni di oli extra vergini qualificati, tali da incidere sul mercato mondiale ai fini della garanzia del consumatore finale e della redditività dell’impresa nel diversificato scenario socio-economico e ambientale che caratterizza la olivicoltura dei singoli Paesi.
A parte le notizie riferite al principale Paese produttore, la Spagna, già ampiamente note, dove, tra l’altro, si sottolinea l’eccesso e il disordine di produzione di olio di oliva, non viene evidenziato il fatto che negli ultimi anni il Paese sta compiendo uno sforzo notevole, ad opera di singoli produttori o organizzati in Dop, per superare l’attuale generico standard qualitativo di massa dell’extra vergine che caratterizza l’olio spagnolo, nel tentativo di recuperare redditività dalla coltura. Nell’intervento manca infatti una proposta strategica finalizzata alla organizzazione in senso autonomo di un sistema di mercato al fine di contrastare il cedimento, privo com’è di difesa, nei confronti del monopolio di chi concentra nella propria struttura industriale di confezionamento la massa di prodotto generico nazionale e d’importazione prevalentemente dai Paesi del Nord Africa. Tutto ciò, data la specifica situazione spagnola quale Paese a forte esportazione, ha come riflesso l’affermazione di un prezzo a livello mondiale dell’extra vergine talmente modesto da rendere antieconomica la coltivazione in tutto il bacino del Mediterraneo.
A poco serve per l’Italia riscontrare come dato di fatto lo stato precario della olivicoltura di molte aree olivicole meridionali dove il modesto prezzo del prodotto, spesso inferiore ai costi di produzione, sta portando all’abbondano di intere aree olivicole che potrebbe comportare, in situazioni pedo-orografiche particolarmente sensibili, il degrado ambientale.
Mi sia consentito, inoltre, di fare un’annotazione particolare sull’intervento di Gerrie Duvenage, in considerazione della conoscenza diretta di ciò che si è verificato in Sud Africa a partire dalla metà degli anni ’90 – e non, come egli afferma, negli ultimi 20 anni – e particolarmente nella Morgenster Estate, che ho seguito personalmente sin dall’avvio del progetto olivicolo, che ha riguardato l’introduzione delle varietà , la costituzione del vivaio per la produzione di piante ad uso proprio e per la commercializzazione e la realizzazione degli impianti olivicoli aziendali ed extra.
Condivido quanto riferito nel medesimo intervento relativamente all’interesse che il Paese sta mostrando per lo sviluppo dell’olivicoltura su media scala e particolarmente verso il consumo di olio di oliva extra vergine, talmente cresciuto in pochi anni al punto che attualmente appena il 10-15% riesce ad essere soddisfatto dalla produzione nazionale.
E’ da sottolineare che il prezzo di vendita dell’olio locale, rivolto al consumo interno ed in minima parte all’esportazione, contrariamente a quanto si verifica negli altri Paesi olivicoli, ivi compresi quelli di nuova produzione (Cile, Argentina, Australia, Stati Uniti), rimane a livelli medio-alti comparabili addirittura con quello delle aree olivicole italiane “elette†in tal senso (Toscana, Umbria e Laghi Lombardi per cui il valore aggiunto risulta particolarmente elevato.
Il Sud Africa, come altri Paesi di nuova frontiera hanno goduto delle innovazioni tecnologiche, soprattutto italiane, riferite sia alla scelta varietale che alle tecniche di propagazione, produzione e trasformazione. Tale Paese inoltre si avvantaggia tuttora di una larghissima disponibilità di manodopera con bassissimi salari e del fatto che, diverse aziende, orientate proprio da Morgenster, a seguito della introduzione delle innovazioni Iro-Cnr da me trasferite unitamente alle nuove cultivar brevetti Cnr, hanno realizzato impianti di tipo intensivo dove è stato possibile attivare meccanizzazione della raccolta e della potatura, e favorire la realizzazione in proprio di frantoi di ultima generazione a garanzia della economia di coltivazione e di un’ottima qualità del prodotto.
Quindi ritengo che, proprio in Sud Africa così come si è verificato in Cile, in Argentina e in Australia, dove i prezzi contenuti del terreno e la mancanza di vincoli socio-economici e di tradizione, gli imprenditori hanno potuto attuare investimenti a costi contenuti seguendo criteri d’impresa, come è possibile constatare in numerose aziende medio-grandi; di conseguenza ben poco hanno da lamentarsi del fatto che l’Italia e i Paesi comunitari siano avvantaggiati dagli interventi a sostegno della coltura.
A riguardo invece va fatta una critica a quegli olivicoltori del nostro Paese che hanno, in generale, goduto di tale “privilegioâ€, più a fini di economia familiare o aziendale, contrariamente ad altri Paesi come Spagna, Portogallo e in parte Grecia, dove l’utilizzazione dei fondi messi a disposizione dall’Europa è stata finalizzata al miglioramento delle strutture produttive e di trasformazione, consentendo abbattimento dei costi, innalzamento delle produzioni e miglioramento della qualità .
Nel nostro Paese prevale l’illusione che il solo marchio “made in Italyâ€, quale garanzia assoluta di qualità a livello nazionale e internazionale possa indirizzare il consumatore italiano verso l’autoconsumo di olio extra vergine di oliva autoctono ad un prezzo medio-alto, rispetto a quello importato da altri Paesi; non tenendo conto che la superiorità qualitativa italiana o presto o tardi si troverà a confrontarsi con quella di altri Paesi mediterranei ed extra mediterranei avviati verso la produzione di extravergine di qualità .
L’interrogativo che riguarda specificatamente l’Italia che oggi ci si pone è: potrà salvarsi il prodotto italiano con la difesa del solo marchio “Made in Italy� Oppure, in alternativa,vista la copertura pressoché totale del territorio olivicolo nazionale della produzione a denominazione di origine, fare ricorso al potenziamento e alla migliore organizzazione delle Dop, quale unica opportunità per garantire al consumatore la reale qualità obiettiva e la tipicità codificata nei differenti disciplinari?
La mia opinione è che ciò potrà avvenire se il Paese, con le Istituzioni dedicate, in sintonia con una migliore organizzazione del mondo della produzione, attraverso specifiche strategie di marketing, riuscirà a fare affermare il miglior prodotto italiano di olio extra vergine per sostenere il confronto con la qualificata produzione di Paesi come il Cile, l’Australia e lo stesso Sud Africa e domani Usa ed altri Paesi verso cui sono fortemente orientati.
E’ proprio al riguardo che sarebbe stato interessante conoscere dalla viva voce di qualificati rappresentanti dei Paesi presenti al dibattito e di altri del mondo Mediterraneo e non, assenti al meeting, l’orientamento produttivo per una sfida mondiale e comune di mercato dell’olio extra vergine di qualità , ad un prezzo remunerativo ma ragionevole, in alternativa a quello modesto dell’offerta industriale; il tutto a vantaggio oltre che del produttore anche della salute del consumatore, visto che tale prodotto rappresenta in concreto: alimento fondamentale, eccellente condimento e cibo funzionale per l’uomo che vuole migliorare la propria salute.
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
Il differente effetto delle fartilizzazione fogliare sull'olivo in presenza di suolo acido o alcalino

Occorre conoscere la diversa efficacia della concimazione fogliare organica, in particolare negli oliveti non irrigati con tipi di terreno distinti.
07 luglio 2025 | 12:00
L'arca olearia
Il genoma completo delle varietà italiane di olivo Frantoio e Leccino

E' la prima volta che si mettono a confronto in modo così dettagliato i genomi di queste due cultivar di olivo, particolarmente interessanti per le loro differenze nella resistenza alla siccità e alla salinità
07 luglio 2025 | 10:00
L'arca olearia
I limiti e i punti deboli della lotta adulticida contro la mosca dell’olivo

La lotta adulticida contro la mosca dell’olivo si sta imponendo sempre di più come sistema di lotta primario in olivicoltura. Tra le criticità, oltre ai costi, le capacità delle popolazioni di muoversi e la sovrapposizione delle generazioni
04 luglio 2025 | 17:00
L'arca olearia
Il grado di inserzione ottimale dei rami di olivo per avere la massima efficienza nella raccolta delle olive con scuotitore

La geometria dell'olivo può svolgere un ruolo fondamentale, determinando la propagazione delle vibrazioni attraverso l'albero, determinando quindi una migliore efficienza della raccolta ma anche riducendo lo sforzo fisico sugli alberi e sui macchinari
04 luglio 2025 | 16:00
L'arca olearia
L’uso di additivi in fase di gramolazione per aumentare il contenuto di fenoli nell’olio extravergine di oliva

Al momento l’utilizzo di additivi che abbiano un’influenza biochimica sul processo di estrazione dell’olio di oliva è proibita nell’Unione europea ma comprendere come l’inibizione di alcuni enzimi può cambiare il profilo dell’olio è indispensabile
04 luglio 2025 | 15:00
L'arca olearia
L'impatto di pirofeofitine e diacilgliceroli sulla qualità dell'olio extravergine di oliva e la sua shelf life

Introdotti come standard commerciali in Australia e California, ora il Codex Alimentarius ne sta discutendo l'introduzione a livello globale. Conosciamo meglio pirofeofitine e diacilgliceroli, oltre alla loro utilità
04 luglio 2025 | 14:00