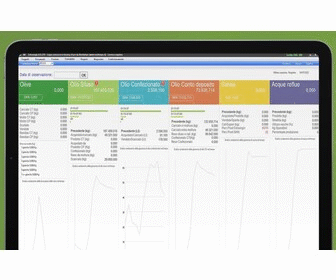L'arca olearia
L'evoluzione delle tecniche di deamarizzazione sulle olive

Il progetto oro verde-oliva Ascolana del Piceno Dop ha perfezionato un sistema per la riduzione dell’impatto ambientale del processo di deamarizzazione delle olive, utilizzando l'anidride carbonica
18 luglio 2024 | Alberto Felici, Leonardo Seghetti
Da quando l’uomo è sulla terra, ha sempre cercato dei metodi per addolcire le olive e renderle gradevoli al palato, ovvero mangiabili. Da subito aveva capito della diversità delle cultivar in funzione della nota amara.
L’uomo aveva anche capito che se si raccoglievano le olive tardivamente (quando erano tutte nere) si addolcivano naturalmente sulla pianta... era il momento in cui anche gli uccelli le mangiavano.
La grande intuizione dell’uomo sulla deamarizzazione fu quando nella conservazione degli alimenti iniziò ad usare il sale, sia come secco, che in soluzione. Abbinando sale secco e freddo, le olive perdono acqua e con essa buona parte del principio amaro; ancora oggi questa tecnica è usata dal mondo agricolo e dall’industria di trasformazione con diverse varianti, tra cui utilizzazione del forno.
 Da millenni le olive venivano trasportate “colymbades” (in acqua e sale), durante il trasporto e per un determinato periodo si addolcivano con il tempo; viene usata tale tecnica anche per le olive verdi più grandi come la Cultivar Ascolana Tenera, citata da Plinio 70anni d.c.; ed oggi è ampliamente dimostrato che alcuni batteri presenti nella salamoia favoriscono la deamarizzazione, idrolizzando il principio amaro. Passano centinaia di anni e grazie ai monaci Benedettini olivetani in quel di Ascoli Piceno iniziarono ad usare cenere di legna e calce in soluzione (Ranno) tutto ciò per accelerare il processo di addolcimento delle olive. Da questo periodo si introducono i lavaggi delle olive che diventano importanti come la successiva fase di fermentazione/conservazione in salamoia. Con l’acquisizione di conoscenze più approfondite si arriva alla deamarizzazione con il sistema chiamato “sivigliano” in cui l’agente deamarizzante è rappresentato dalla soda (idrossido di sodio) che è capace di idrolizzare il principio amaro delle olive “oleouropeina” penetrando nella polpa per almeno due terzi di essa o totalmente. Seguono i lavaggi con acqua per eliminare la soda e la conservazione in idonea salamoia all’8%. In alcuni territori si abbina soda e sale (Sicilia) per favorire l’addolcimento delle olive. Con il sistema sivigliano si utilizza tanta acqua per i lavaggi delle olive con un rapporto minimo di 1 a 3 ed anche più.
Da millenni le olive venivano trasportate “colymbades” (in acqua e sale), durante il trasporto e per un determinato periodo si addolcivano con il tempo; viene usata tale tecnica anche per le olive verdi più grandi come la Cultivar Ascolana Tenera, citata da Plinio 70anni d.c.; ed oggi è ampliamente dimostrato che alcuni batteri presenti nella salamoia favoriscono la deamarizzazione, idrolizzando il principio amaro. Passano centinaia di anni e grazie ai monaci Benedettini olivetani in quel di Ascoli Piceno iniziarono ad usare cenere di legna e calce in soluzione (Ranno) tutto ciò per accelerare il processo di addolcimento delle olive. Da questo periodo si introducono i lavaggi delle olive che diventano importanti come la successiva fase di fermentazione/conservazione in salamoia. Con l’acquisizione di conoscenze più approfondite si arriva alla deamarizzazione con il sistema chiamato “sivigliano” in cui l’agente deamarizzante è rappresentato dalla soda (idrossido di sodio) che è capace di idrolizzare il principio amaro delle olive “oleouropeina” penetrando nella polpa per almeno due terzi di essa o totalmente. Seguono i lavaggi con acqua per eliminare la soda e la conservazione in idonea salamoia all’8%. In alcuni territori si abbina soda e sale (Sicilia) per favorire l’addolcimento delle olive. Con il sistema sivigliano si utilizza tanta acqua per i lavaggi delle olive con un rapporto minimo di 1 a 3 ed anche più.
Da quanto brevemente detto il progetto OroVerde- Oliva Ascolana del Piceno DOP nasce dalla sinergia tra diversi segmenti del settore Agricolo, il settore dell’istruzione e quello della ricerca scientifica; il tutto con la collaborazione della regione Marche che, attraverso il programma Sviluppo Rurale 2014-2022, progetto ID 41887, ha sostenuto tutte le attività progettuali che riguardavano la deamarizzazione dell’oliva tenera ascolana del piceno-DOP.
La compagine progettuale era molto variegata; infatti oltre al Consorzio per la Tutela dell’Oliva ascolana del Piceno DOP, erano presenti le aziende picene del settore agroalimentare “Cooperativa Agricola Case Rosse”, “Tenuta la Riserva” ed “Altagamma”, l’Istituto agrario “Ulpiani” di Ascoli Piceno e l’Università di Camerino attraverso il coinvolgimento della Scuola di Architettura e Design e della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.
Il progetto ha visto la ha realizzazione di una serie di attività sperimentali finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale del processo di deamarizzazione; a tal scopo di campioni di oliva tenera ascolana DOP, in quantità gradualmente crescenti nel corso delle varie annualità, sono state deamarizzate utilizzando una soluzione di idrossido di sodio, in linea con le prescrizioni del disciplinare di produzione.
Una volta completata questa fase di lavorazionesi è proceduto alla progressiva riduzione dell’idrossido attraverso una serie di lavaggi con acqua fino a portare il pH della soluzione in cui erano immerse le olive ad un valore compreso tra il 7/8 rispetto ai valori iniziali di pH pari a 12/13 e creando così le condizioni ottimali perla successiva azione dei batteri che, attraverso un processo di fermentazione, completavano la maturazione dell’oliva fino alla formazione di quel prodotto finale che tutti noi possiamoapprezzare sulle nostre tavole.
Il lavaggio con acqua è stata la fase su cui si è principalmente incentrata l’attività progettuale; tipicamente questa operazione è caratterizzata da una variabilità nel numero dei lavaggi, nella loro durata e nei quantitativi di acqua utilizzata; mediamente un buon risultato si ottiene con 3 lavaggi spalmati in un arco temporale di circa 3 giorni ed utilizzando complessivamente una quantitativo di acqua pari a circa 3 litri per ogni chilogrammo di oliva (1 litro in ognuno dei 3 lavaggi).
Nel progetto OroVerde la compagine progettuale ha messo a punto una nuova procedura di lavaggio che prevedeva l’immissione di anidride carbonica proveniente dalla fermentazione di mosti ottenuti da uve biologiche.
L’immissione di anidride carbonica è stata effettuatasia nei vari stadi della fase di lavaggio con acqua, che nella soluzione di idrossido di sodio contenente le olive non appena si fosse accertato il completamento della fase di deamarificazione e quindi saltando completamente la fase di lavaggio.
L’anidride carbonica in presenza di acqua forma una soluzione di bicarbonato che reagisce rapidamente con l’idrossido di sodio portando ad rapido abbassamento del pH ; le attività sperimentali hanno consentito di mettere a punto un protocollo operativo facilmente replicabile che ottiene questo risultato già a partire dal primo lavaggio o, addirittura,dalla soluzione iniziale idrossido di sodio-olive; riducendo notevolmente od addirittura eliminando in questo modo i lavaggi con acqua.
Le determinazioni organolettiche e sensoriali hanno dimostrato che tutti i campioni di olive trattati con anidride carbonica hanno le stesse caratteristiche organolettiche delle olive deamarizzate senza l’aggiunta di anidride carbonica, ma possiedono migliori caratteristiche sensoriali leggermente migliori, riscontrando quindi un maggior gradimento da parte del consumatore.
In questo modo di ottengono contemporaneamente molteplici risultati; innanzitutto si ha una riduzione dell’anidride carbonica proveniente dai mosti che viene immessa in atmosfera, un importante risparmio idrico poiché si possono evitare quasi tutti o addirittura tutti i lavaggi, una riduzione dei tempi che dai circa 3 giorni si riducono ad alcune ore con ovvie ricadute sui costi di produzione.
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
I limiti e i punti deboli della lotta adulticida contro la mosca dell’olivo

La lotta adulticida contro la mosca dell’olivo si sta imponendo sempre di più come sistema di lotta primario in olivicoltura. Tra le criticità, oltre ai costi, le capacità delle popolazioni di muoversi e la sovrapposizione delle generazioni
04 luglio 2025 | 17:00
L'arca olearia
Il grado di inserzione ottimale dei rami di olivo per avere la massima efficienza nella raccolta delle olive con scuotitore

La geometria dell'olivo può svolgere un ruolo fondamentale, determinando la propagazione delle vibrazioni attraverso l'albero, determinando quindi una migliore efficienza della raccolta ma anche riducendo lo sforzo fisico sugli alberi e sui macchinari
04 luglio 2025 | 16:00
L'arca olearia
L’uso di additivi in fase di gramolazione per aumentare il contenuto di fenoli nell’olio extravergine di oliva

Al momento l’utilizzo di additivi che abbiano un’influenza biochimica sul processo di estrazione dell’olio di oliva è proibita nell’Unione europea ma comprendere come l’inibizione di alcuni enzimi può cambiare il profilo dell’olio è indispensabile
04 luglio 2025 | 15:00
L'arca olearia
L'impatto di pirofeofitine e diacilgliceroli sulla qualità dell'olio extravergine di oliva e la sua shelf life

Introdotti come standard commerciali in Australia e California, ora il Codex Alimentarius ne sta discutendo l'introduzione a livello globale. Conosciamo meglio pirofeofitine e diacilgliceroli, oltre alla loro utilità
04 luglio 2025 | 14:00
L'arca olearia
Il rame da solo non basta contro la mosca dell’olivo

Non serve un’alta dose di rame per contrastare la mosca dell’olivo. Un dosaggio molto più basso, abbinato a trattamenti con particelle di silicato, può ridurre significativamente le infestazioni di Bactrocera oleae
03 luglio 2025 | 14:00
L'arca olearia
L’influenza sulla fenologia dell’olivo della varietà, della località e dell’interazione genotipo-ambiente

La data di maturazione delle olive non è uniforme all'interno della chioma dell'albero: i rami esposti a nord e a ovest maturavano più tardi rispetto a quelli esposti a sud e a est. Il risveglio dalla dormienza è stato precoce nei rami esposti a sud e a est
02 luglio 2025 | 16:00