L'arca olearia
Dalla campagna al diritto penale e civile: la legge Salva Olio
La legislazione sull'olio d'oliva rappresenta ancora una volta una traccia innovativa lasciata dall’Italia che l’Unione europea, nel tempo, non potrà ignorare. Un'analisi critica, in una tesi di laurea, della legge Mongiello
08 luglio 2016 | Delia D'Alesio
Tra i ricordi più vivi che ho della mia infanzia c’è il sole che filtra tra le foglie verdi e argento degli olivi più antichi ed il racconto di mio nonno, che al tempo mi sembrava una favola, di come da un frutto così umile e minuto potesse sgorgare una ricchezza tanto preziosa per l’uomo. Mi sono portata dietro, a Roma e sulla carta dei libri, quell’aria di campagna e l’idea che tutte le sofisticazioni giuridiche e tecnologiche, che l’evoluzione implementa e architetta, poggiano sempre su un oggetto arcaico che ha condiviso la nostra storia. Allora ho pensato che bisogna portare del rispetto per questi frutti della terra che ci hanno visto crescere e ci hanno nutrito imperturbabili al cospetto della nostra inventiva e inermi contro le nostre manie di onnipotenza.
 Produciamo, commerciamo, regoliamo e l’oggetto dei nostri negozi sfuma in secondo piano rispetto a quella che, invece, dovrebbe essere solo la forma indiretta del traffico e della norma: il valore economico. Così è stato per l’olio, il gusto del quale, come figlia del centro Italia, fa parte delle mie primissime memorie sensoriali, quelle irrazionali e immediate.
Produciamo, commerciamo, regoliamo e l’oggetto dei nostri negozi sfuma in secondo piano rispetto a quella che, invece, dovrebbe essere solo la forma indiretta del traffico e della norma: il valore economico. Così è stato per l’olio, il gusto del quale, come figlia del centro Italia, fa parte delle mie primissime memorie sensoriali, quelle irrazionali e immediate.
Ho studiato il diritto civile perché i rapporti fra privati rappresentano l’essenza delle necessità che portano l’uomo a creare strumenti idonei a risolvere problemi pratici e trovare soluzioni valide per trasmettere beni tra soggetti che non necessariamente parlano la stessa lingua ed usano la stessa moneta, ma quando l’artificio è teso a superare o invalidare, o frodare la creazione della natura, lo schema che ho studiato mi si sfalda tra le mani. Se dommatica è la tutela della parte debole di un rapporto giuridico, tanto più mi convince la protezione di quella parte se essa fruisce direttamente di ciò che acquista e tanto più se il momento satisfattivo si realizza con l’assimilazione del bene. L’alba del diritto ha visto il baratto tra derrate alimentari, il seminatore con l’allevatore, il pescatore col cacciatore e non mi stupirei ad immaginare che la moneta sia nata per “prezzare” un prodotto trasformato, come nel bacino del Mediterraneo è l’olio sopra ogni cosa. Quello stesso olio che poi fu tra le cause scatenanti del conflitto commerciale tra Roma e Cartagine per la supremazia economica tra i produttori di olio d’oliva nelle colonie puniche o latine del resto d’Europa, conflitto che si ripropone dopo 2200 anni nello stesso scenario.
Il mercato agroalimentare è stato regolato, fino a qualche anno fa, da normative fondanti sulle stesse regole romane del periodo di cui si è accennato, la compravendita di cibo, del resto, non aveva mutato forme o ragioni d’essere in maniera eclatante e forse solo con l’apertura del mercato globale degli anni ’30 del XX secolo e la perdita naturale da parte dell’Italia del primato nel commercio con l’estero rispetto a determinati alimenti, ha portato a riflettere sulla necessità di una rivoluzione circa il valore da far apprezzare all’estero: dalla quantità straniera ormai irraggiungibile per i produttori italiani, alla qualità italiana irraggiungibile per gli altri. Bisognava vendere non più un numero di olive spremute, ma un succo dal colore inconfondibile, dal profumo inebriante e dal sapore persistente che raccontasse delle scogliere liguri, delle colline fiorentine, delle valli umbre, dei calanchi aprutini e del sole pugliese che, solo in Italia e per sempre all’ Italia, il consumatore ricollega perché riconosce.
 Dal momento che ritengo il diritto un prodotto della società, e tanto più il diritto dei privati, non posso ammettere una legislazione che parla di terra e di cibo e non considera gli aspetti concreti di una tradizione millenaria, storicamente e geograficamente ben circoscritta. Se il tecnocrate estone, danese o fiammingo non riesce, giustamente, a comprendere il senso di tutto questo perché non è cresciuto spezzando i suoi pomeriggi di gioco, di studio o di lavoro con pane e olio e non conosce le fessure vive del tronco tortile di un olivo secolare, gli Italiani devono scegliere soggetti capaci di rappresentare la ricchezza del nostro Paese, di negoziare onestamente, trasmettendo a qualunque controparte il senso più puro e profondo della difesa di un patrimonio immateriale.
Dal momento che ritengo il diritto un prodotto della società, e tanto più il diritto dei privati, non posso ammettere una legislazione che parla di terra e di cibo e non considera gli aspetti concreti di una tradizione millenaria, storicamente e geograficamente ben circoscritta. Se il tecnocrate estone, danese o fiammingo non riesce, giustamente, a comprendere il senso di tutto questo perché non è cresciuto spezzando i suoi pomeriggi di gioco, di studio o di lavoro con pane e olio e non conosce le fessure vive del tronco tortile di un olivo secolare, gli Italiani devono scegliere soggetti capaci di rappresentare la ricchezza del nostro Paese, di negoziare onestamente, trasmettendo a qualunque controparte il senso più puro e profondo della difesa di un patrimonio immateriale.
Un tassello importante per la tutela dei prodotti oleari realmente italiani è stato posto da una donna pugliese - l’Onorevole Colomba Mongiello - che, conoscendo e avendo a cuore la qualità dell’extravergine italiano, ha voluto fortemente che il Parlamento adottasse uno strumento legislativo di protezione e di valorizzazione di questo alimento. La legge 14 gennaio 2013, n. 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, c.d. “Legge Salva Olio”, si compone di diciassette articoli divisi in cinque capi e riordina le disposizioni esistenti in materia, ponendole ad un livello ancora più elevato di tutela. Fondamentali sono le innovazioni giuridiche in tema di etichettatura, si prevede che l’indicazione d’origine non debba solo essere facilmente visibile e leggibile, ma anche apposta nel campo visivo anteriore del recipiente così da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo (art. 1); in tema di controlli, vi sono specificazioni sull’organizzazione ed il funzionamento dei comitati di assaggiatori (art. 2); in tema di tutela del consumatore, si prevede un ampliamento della disciplina sanzionatoria relativa alle pratiche commerciali ingannevoli, descrivendo all’art. 4 una figura specifica di pubblicità ingannevole riguardante i prodotti oleari, inoltre viene disposta una nuova tipologia di reato per i marchi che possono ingannare il pubblico sulla provenienza geografica della materia prima degli oli di oliva vergini (art. 5), infine vengono introdotte due importanti novità: l’indicazione in etichetta del termine minimo di conservazione, non superiore ai diciotto mesi (disposizione alla quale la recente legislazione europea ha imposto di rinunciare) e l’obbligo di utilizzo dei cosiddetti “tappi anti-rabbocco” per le confezioni di oli vergini proposti al consumatore nei pubblici esercizi, così da impedire che la bottiglia d’olio utilizzata possa essere riempita all’infinito o con olio non prodotto dall’azienda indicata in etichetta. Il capo IV, infine, è dedicato alle norme sul contrasto delle frodi e predispone una serie di sanzioni che delineano per la prima volta un apparato penale agroalimentare volto a tutelare la filiera olivicola italiana, in particolare si prevede l’espansione della responsabilità degli enti nel caso di reati quali l’adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, il commercio di sostanze alimentari contraffatte, adulterate o nocive, l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci e infine la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Si tratta, quindi, di una norma nazionale che irrompe nel panorama legislativo europeo e che tende a rendere già superata la disciplina contenuta nel regolamento n. 29/2012 della Commissione. Una normativa d’avanguardia che il nostro Paese deve avere premura di rendere operativa a pieno regime, poiché un prodotto, in particolar modo alimentare, senza leggi adeguate che lo tutelano vale molto meno e per il nostro Paese questa perdita costa cara.
Questi sono, essenzialmente, i motivi che mi hanno portata ad approfondire a livello accademico il tema della sicurezza alimentare ed in particolare la recente legislazione sull’olio d’oliva, quest’ultima rappresenta ancora una volta una traccia innovativa lasciata dall’Italia che l’Unione, nel tempo, non potrà ignorare.
Potrebbero interessarti
L'arca olearia
I limiti e i punti deboli della lotta adulticida contro la mosca dell’olivo

La lotta adulticida contro la mosca dell’olivo si sta imponendo sempre di più come sistema di lotta primario in olivicoltura. Tra le criticità, oltre ai costi, le capacità delle popolazioni di muoversi e la sovrapposizione delle generazioni
04 luglio 2025 | 17:00
L'arca olearia
Il grado di inserzione ottimale dei rami di olivo per avere la massima efficienza nella raccolta delle olive con scuotitore

La geometria dell'olivo può svolgere un ruolo fondamentale, determinando la propagazione delle vibrazioni attraverso l'albero, determinando quindi una migliore efficienza della raccolta ma anche riducendo lo sforzo fisico sugli alberi e sui macchinari
04 luglio 2025 | 16:00
L'arca olearia
L’uso di additivi in fase di gramolazione per aumentare il contenuto di fenoli nell’olio extravergine di oliva

Al momento l’utilizzo di additivi che abbiano un’influenza biochimica sul processo di estrazione dell’olio di oliva è proibita nell’Unione europea ma comprendere come l’inibizione di alcuni enzimi può cambiare il profilo dell’olio è indispensabile
04 luglio 2025 | 15:00
L'arca olearia
L'impatto di pirofeofitine e diacilgliceroli sulla qualità dell'olio extravergine di oliva e la sua shelf life

Introdotti come standard commerciali in Australia e California, ora il Codex Alimentarius ne sta discutendo l'introduzione a livello globale. Conosciamo meglio pirofeofitine e diacilgliceroli, oltre alla loro utilità
04 luglio 2025 | 14:00
L'arca olearia
Il rame da solo non basta contro la mosca dell’olivo

Non serve un’alta dose di rame per contrastare la mosca dell’olivo. Un dosaggio molto più basso, abbinato a trattamenti con particelle di silicato, può ridurre significativamente le infestazioni di Bactrocera oleae
03 luglio 2025 | 14:00
L'arca olearia
L’influenza sulla fenologia dell’olivo della varietà, della località e dell’interazione genotipo-ambiente

La data di maturazione delle olive non è uniforme all'interno della chioma dell'albero: i rami esposti a nord e a ovest maturavano più tardi rispetto a quelli esposti a sud e a est. Il risveglio dalla dormienza è stato precoce nei rami esposti a sud e a est
02 luglio 2025 | 16:00






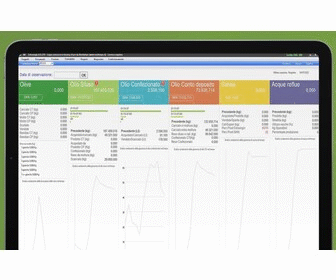

Roberto La Pira
11 luglio 2016 ore 10:14Una gradevole lettura