Libri
Esiste ancora un mondo agricolo? Oppure resta solo un'espressione che si usava una volta?
L'agricoltura, la ruralità è come un fiume carsico che nella storia appare e scompare. Ma esso esiste, lavora, scava, modifica paesaggi ,territori, economie. Alcune libere riflessioni tratte dalla lettura di “Radici&Gemme” di Alfonso Pascale
23 maggio 2014 | Antonio Carbone
Prima di entrare nel merito del libro, vorrei formulare un riconoscimento ad Alfonso, del utilità culturale e politica del libro per proseguire una riflessione su argomenti che ci permettono di ripensare ad un periodo lungo della Storia d'Italia, dal Risorgimento ai giorni nostri, con un'ottica che è quella della ruralità, dell'agricoltura in senso ampio, di quella “società civile” che l'attualità cerca di rimuovere, di cancellare e di annullare, come legittimo punto di vista per giudicare e interpretare anche il nostro futuro. Qui io trovo l'originalità e la forza di questo libro condividendone lo spirito, lo sforzo culturale ed etico, ancor prima che politico. Ovvero osservare il trascorrere di questo arco lungo di vita del nostro Paese con gli occhi del “mondo agricolo”. Espressione che si usava una volta.
 Del libro mi ha affascinato questa impostazione, perché una letteratura su singoli argomenti già esiste. C'è una pubblicistica su quella che è stata la riforma agraria, quello che è stato il movimento delle terre, quello che è stato il ruolo di contadini nel Risorgimento,sull’innovazione tecnica e agrochimica nel primario e poi sulla Politica Agricola Comunitaria ecc.. . Quello che mancava è lo sforzo di mettere insieme tutti questi tasselli e costruire un mosaico unitario, con un punto di vista legittimo: quello della “società civile agricola”. Della ruralità.
Del libro mi ha affascinato questa impostazione, perché una letteratura su singoli argomenti già esiste. C'è una pubblicistica su quella che è stata la riforma agraria, quello che è stato il movimento delle terre, quello che è stato il ruolo di contadini nel Risorgimento,sull’innovazione tecnica e agrochimica nel primario e poi sulla Politica Agricola Comunitaria ecc.. . Quello che mancava è lo sforzo di mettere insieme tutti questi tasselli e costruire un mosaico unitario, con un punto di vista legittimo: quello della “società civile agricola”. Della ruralità.
Questo è un elemento per me fondamentale. Esso mi porta ad una considerazione che ritrovo nel libro e che oggi mi è ancor più chiara. L'agricoltura, la ruralità, diciamo così, è come un fiume carsico che nella storia appare e scompare. Ma esso esiste, lavora, scava, modifica paesaggi, territori, economie. E crea i presupposti per nuovi equilibri ambientali e sociali. Proprio come un fiume carsico. La cultura urbana ed industrialista, oggi egemone, spesso ha portato a non vedere questa risorsa e quindi ad ignorarla. Ma quella energia c’è, ed opera nella società e nelle coscienze dei cittadini. E, secondo me, a questa fonte dovremmo per certi aspetti tornare ad abbeverarci.
E quest'operazione di emersione la compie, Alfonso con questo libro, nel senso che se uno avesse mai immaginato che la ruralità nella dimensione socio-culturale, economica, nei suoi valori, nel suo patrimonio storico ed etico fosse morta, alla fine della lettura di: Radici & Gemme capirebbe che quella ruralità non solo non è morta ,ma essa è vitale e fonte di ricerca ed innovazione utile per affrontare il futuro ed uscire dalla crisi strutturale della società occidentale. A noi l'intelligenza di capire come ripescare quella risorsa, quell'acqua vitale ed irrigare il nuovo scenario, la nuova condizione esistenziale .
Detto questo come considerazione generale, voglio soffermarmi su due questioni, con una premessa: forse questo dibattito meriterebbe di essere organizzato in più momenti tematici poiché il periodo storico considerato è lungo e ricco di eventi e quindi alto il bisogno di approfondimento .
Personalmente ho scelto di trattare due elementi presenti nel testo ed entrambi strategici per le vicende del passato e per l'attualità ,per le implicazioni sociali e la qualità della democrazia per il nostro futuro: la riforma agraria (cap. IV ) e la crisi della rappresentanza (cap. VII).
Sulla riforma agraria si è scritto tanto con grande autorevolezza per cui io ne parlo con la più grande umiltà . Per quello che ho avuto modo di leggere in diversi testi, ed in relazione a quanto scritto nel libro mi pongo alcune domande che peraltro anche Alfonso si pone: la riforma agraria fu una riforma liberale? Si,anche se debole. Però mi chiedo: la riforma agraria fu vera riforma ? se al termine riforma diamo una valenza non contingente, non parziale, non esasperatamente rispondente ad esigenze tattiche, se invece la intendiamo come un progetto ,un’ idea forte, di lungo respiro che modifichi realmente gli equilibri socio economici,che dia prospettive a quello che si vuol riformare, e soprattutto sia in grado di misurarsi con il futuro dell’agricoltura Europea e mondiale , fu vera riforma? beh , in merito, nutro qualche dubbio.
Non a caso abbiamo avuto solo una Riforma Stralcio mai completata e solo per alcuni territori e regioni, pur in presenza di una necessità nazionale. Non completata peraltro su temi fondamentali e vitali per una moderna politica agricola: la riforma dei patti agrari ed una riconversione produttiva, passando dalle coltivazioni asciutte a quelle irrigue. In particolare la trasformazione dei contratti di mezzadria in affitto, la cui riforma arriverà molto più tardi, quando è già in atto un nuovo e massiccio esodo dalle campagne verso le città a sostegno della industrializzazione. Cosi come bisogna aspettare gli anni 70 per affrontare in modo strutturale e su vasta scala il problema della irrigazione nelle campagne .
Uno dei limiti di quella vicenda è riscontrabile certamente in un’ azione riformatrice fortemente inquinata da elementi di contingenza politica: a partire dal bisogno del Governo di privilegiare una lotta anticomunista, di tacitare le forze latifondiste e conservatrici , con lauti risarcimenti per i parziali espropri,pagati dallo Stato ,risorse che saranno poi reinvestite, non in agricoltura, ma nell’edilizia e nell’industria. La maggiore responsabilità è stata quella di attuare una riforma senza credere più nell’agricoltura come uno dei motori attivi per l’economia italiana. Una riforma per chiudere un ciclo non per aprirlo.
Infatti il Governo aveva scelto il modello dello sviluppo industriale tout court ed aveva relegato l’Agricoltura ad una funzione di area di parcheggio ,da gestire più con politiche assistenziali piuttosto che di sviluppo competitivo verso i mercati agroalimentari europei e mondiali. Per questo, qui, non concordo su un giudizio negativo sul ruolo svolto dalla Sinistra politica e sociale in quella fase. Esso è, a mio avviso, ingeneroso ed inesatto in quanto la maggiore spinta riformatrice in agricoltura proveniva proprio da quella parte politica e culturale. La spinta riformatrice ha le sue radici ed i suoi protagonisti migliori proprio tra le masse contadine, bracciantili ,gli intellettuali ed gli studiosi che a vario titolo si riconoscevano nelle forze politiche e sociali della sinistra
Infatti, a riprova di quanto sopra sostenuto la riforma agraria - in assenza di una visione, come dicevo, strategica del primario dopo una prima fase di avvio riformatore costringe gli agricoltori, che avevano beneficiato della concessione di piccole quote di terra ,schiacciati dai debiti e privi di una strumentazione idonea per produrre in termini competitivi,ad abbandonare le terre e tornare ad emigrare.
Io che ho visto protagonisti Rocco Scotellaro, Carlo Levi e le lotte dei braccianti - quella storia l'ho vissuta . Ricordo le piazze piene dei contadini senza terra che lottavano per averla e poi successivamente la lacerante ripresa dell’emigrazione .
Tutto questo perché quella riforma stralcio alla fine è stata abbandonata al suo destino . Le conseguenze di questa scelta le riscontriamo ancora oggi .
Mi fermo qui. Anche se potremmo discutere a lungo.
L'altra tematica del libro che mi affascina e vorrei approfondire, per esperienza diretta, (ad Alfonso mi lega un’antica amicizia, perché io facevo il segretario della Federbraccianti in Basilicata ,mentre lui era lì il presidente della Confcoltivatori) - è la questione dell’evoluzione e crisi della rappresentanza sociale in Agricoltura. Oggi questo problema, che non riguarda solo il mondo agricolo ma pressoché tutte le organizzazioni sociali di massa, è centrale per definire la democrazia economica e politica del nostro Paese.
Nel primo dopoguerra e mi riferisco ai soggetti storici dell’ agricoltura,– la rappresentanza dei soggetti attivi del processo produttivo agricolo e delle popolazioni rurali si basava su alcuni elementi fondanti. Possesso o non possesso del bene terra,tutela degli interessi specifici del comparto, legittime aspirazioni ad una emancipazione sociale ed economica( “pane e lavoro”), avere una visione generale della società . Si direbbe oggi, avere un” bene comune”. Il tutto con un forte collante ideologico e di classe rappresentato dai partiti :democrazia cristiana ,socialisti, comunisti .Organizzazioni tutte sempre espressione di movimenti di massa reali.
Dopo la fase alta del primo dopo guerra il fiume rigoglioso e visibile dell’agricoltura –per usare la metafora del fiume carsico- si è lentamente ma inesorabilmente inabissato.
Le organizzazioni professionali e sindacali da una parte rivendicavano politiche di sviluppo e dall’altra si attrezzavano ad essere soggetti del trasferimento e della gestione di politiche assistenziali e neo corporative,facilitate da governi compiacenti e da una contingenza economica favorevole. In sostanza dall’interesse generale ci si arroccava nello specifico settoriale ,anche grazie ad una Politica Agricola Comunitaria che con il facile sostegno economico ai produttori alimentava queste rivendicazioni. Qui Alfonso riporta, in modo eccellente, tutta la questione sulla definizione dell’ Agricoltore nel codice civile e le sue implicazioni nella politica agricola nazionale. Le OO.PP. in questa fase vanno perdendo così i connotati di organizzazione autonome e di massa e diventano sempre più soggetti para istituzionali privilegiati della Politica governativa in un processo di reciproca legittimazione.
Si alimenta, in tal modo, una insana separatezza dell’Agricoltura dal resto della società. Si alimenta un uso improprio della specificità agricola, si cerca di imporre un modello industrialista del primario, avversando il pluralismo delle agricolture e degli operatori,si penalizzano le aree rurali ed interne sempre più marginalizzate.
La rappresentanza, peraltro indebolita dal venir meno del collante politico-ideologico, indebolita dagli eventi politici mondiali ed europei , dalla nascente crisi dei partiti di riferimento, dai processi di globalizzazione dei mercati e dall’espandersi di una nuova comunicazione capillare e diffusa, si fonda sempre più sulla erogazione di servizi agli agricoltori e sul rivendicazionismo settoriale e localistico, su un neo corporativismo che perde di vista l’interesse generale del Paese. La nascita dei Cobas del latte, come dei Forconi, ne sono l’esempio più evidente.
Ma, ancora una volta il fiume carsico lavora. Il modello agroindustriale mostra le sue contraddizioni sociali, economiche,alimentari ed ambientali. I vari scandali sulla qualità dei prodotti alimentari, una coscienza diversa tra i cittadini sui temi delle risorse naturali ed del cibo modifica profondamente gli orientamenti ed il rapporto dei cittadini e dei consumatori con il primario.
L’agricoltura da specificità settoriale diventa questione generale .
Tutto questo ,a mio avviso è evidente in una data : il 3 Giugno del 1990.
Il Referendum contro i pesticidi in agricoltura. Da una parte la società civile, nuove organizzazioni dei cittadini, consumatori, agricoltori biologici, ricercatori per nuovi modelli produttivi agricoli, associazioni ambientaliste e per il cibo di qualità e dall’altra le tre organizzazioni storiche dell’agricoltura a difesa del modello corporativo ed industrialista fondato sull’agrochimica inquinante. Il referendum non raggiunse il quorum, ma l’onda lunga del cambiamento era partita.
Potrebbero interessarti
Libri
Nel nome del pane: l’agroalimentare dei nostri giorni in un romanzo, forse
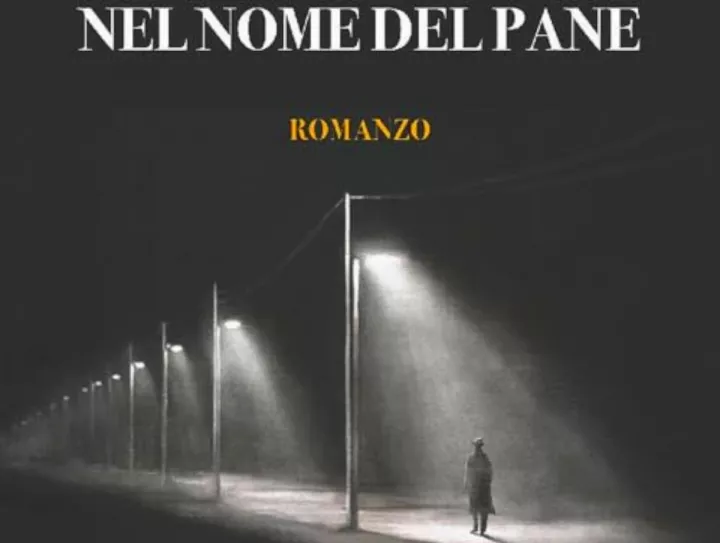
L’opera prima di Luigi Chiarello incuriosisce dal titolo e avvia lungo un percorso che interroga ciascuno di noi sul rapporto personale, e poi della società tutta, col cibo. Il passato sono storia e simboli, il presente è un’incognita
28 novembre 2025 | 11:00 | Alberto Grimelli
Libri
I Georgofili e il Giubileo: un volume con letture scelte sull’agricoltura negli anni giubilari
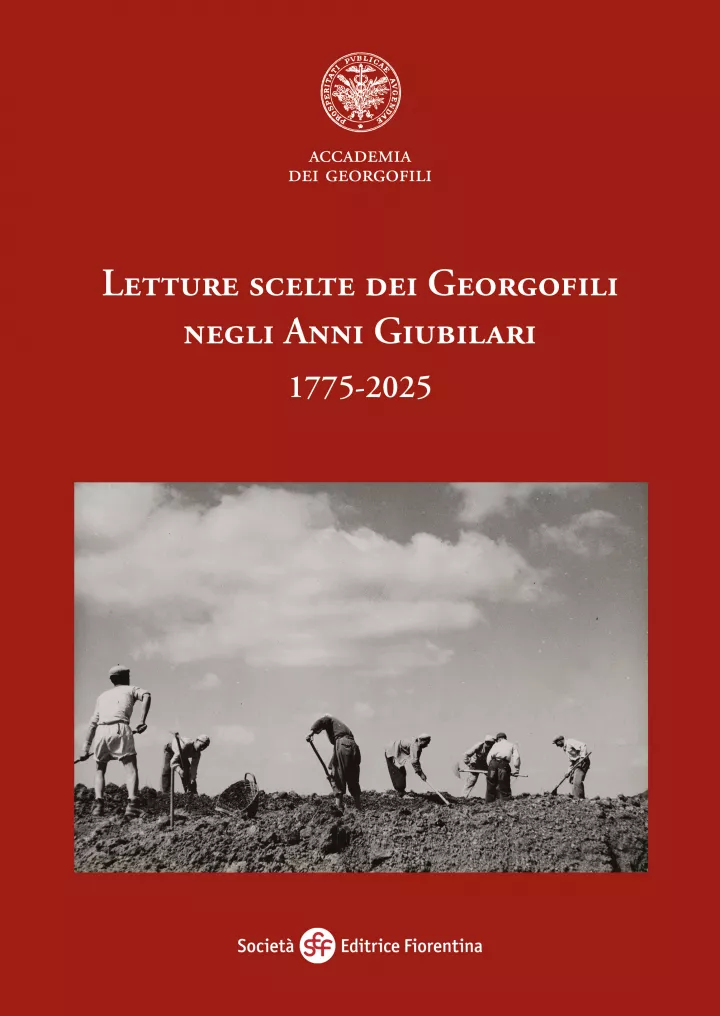
Il volume raccoglie 17 letture svolte da Accademici negli altrettanti anni giubilari compresi tra il 1775 e il 2025 ed offre al lettore diversi spunti, fornendo l’opportunità di ripercorrere un viaggio a tappe, scandito dalle cadenze degli anni giubilari, lungo il cammino dell’agricoltura nazionale
26 novembre 2025 | 17:00
Libri
Guida Vitae 2026: le 400 eccellenze selezionate da AIS in degustazione a Firenze

Il 15 novembre alla Stazione Leopolda a Firenze l'evento con le finali dei premi per i sommelier tra cui il concorso Miglior Sommelier d’Italia. L'Associazione Italiana Sommelier presenta la Guida Vitae 2026
14 novembre 2025 | 18:00
Libri
Fonte di Foiano è l'azienda dell'anno per Flos Olei, l'extravergine migliore è spagnolo

Anche quest’anno l’Italia si dimostra un punto di riferimento internazionale. Grande vitalità del settore in gran parte del globo: dalla Spagna, alla Croazia, alla Grecia, al Sudafrica fino al Cile
05 novembre 2025 | 15:00
Libri
In un volume i 75 anni della storia dell’Accademia e del suo ruolo di valorizzazione del settore vitivinicolo
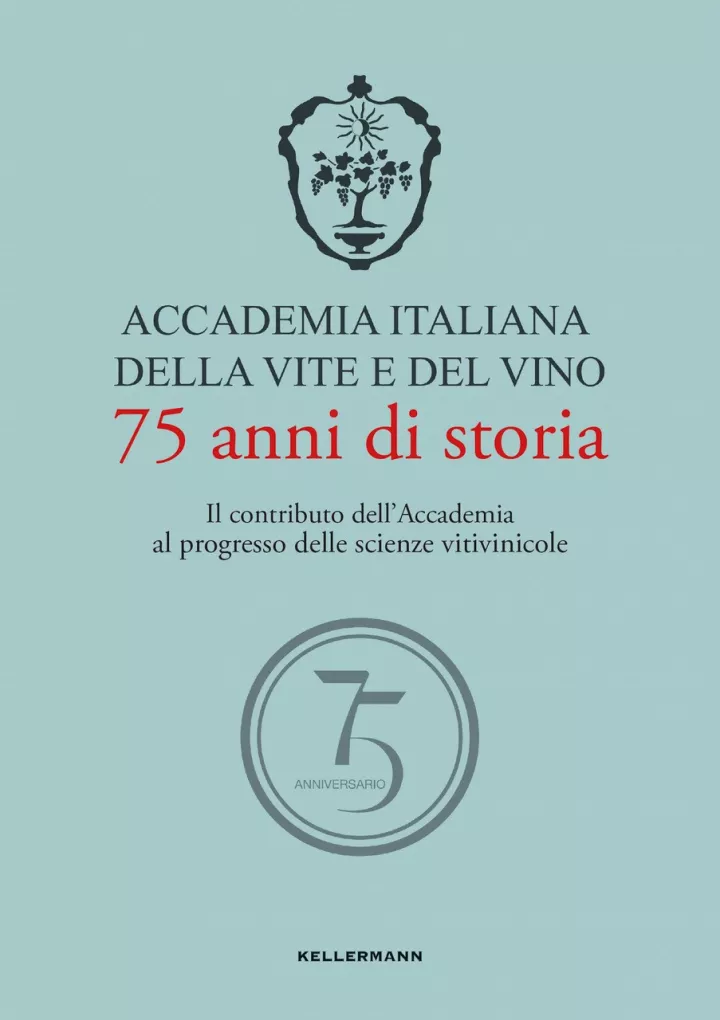
L’Accademia della Vite e del Vino conta oggi 554 membri nelle diverse categorie, ha patrocinato convegni, incontri scientifici e tecnici e ha organizzato e svolto ben 340 Tornate Accademiche, di cui 17 all’estero in Paesi europei ed extra-europei
23 aprile 2025 | 17:00
Libri
La Guida agli Extravergini di Slow Food Italia compie 25 anni

Tante novità e una decisione politica: fuori dalla Guida le aziende che attuano il superintensivo. Un lavoro di squadra per far conoscere oli, storie e territori: 823 aziende segnalando 1321 oli extravergini di qualità
02 aprile 2025 | 09:00



