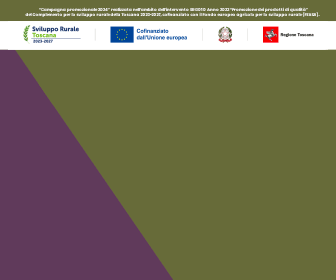Quo vadis
Ai piedi di un olivo sulla via francigena, il viaggio come terapia per l'anima

Nei mille percorsi per le nostre campagne, come sempre sostenuto da Pandolea, si possono trovare incredibili narratori. Persone che offrono il suo pieno coinvolgimento, intellettuale, emotivo ed affettivo, diventando "terapeuti"
29 settembre 2017 | Cristiano Berilli
 Percorrendo il tratto della Via Francigena nel territorio di Siena, nei pressi di Monteriggioni, io e mia moglie abbiamo fatto una sosta in un’azienda agricola situata proprio su un segmento del tragitto originale, oggi non più utilizzato, di cui resta ben visibile ancora una parte del selciato. Siamo capitati lì un po’ per caso, guidati dalla bellezza naturale del luogo, dato che la struttura non rientra tra gli ostelli segnalati sul tracciato. Il proprietario della tenuta, con evidente spontanea attitudine, sollecitato anche dalla nostra accesa curiosità, ha manifestato subito il desiderio di illustrarci alcuni aspetti particolari del sito medievale in cui abbiamo avuto l’onore e il piacere di riposare e riflettere. Ho notato la presenza di alcuni elementi architettonici di età antica, probabilmente il primo insediamento poteva essere una ’statio’, una ‘mansio’ romana, per lo smistamento delle merci e dei cavalli, che serviva la vicina Cassia. Il racconto si prolungava, siamo stati perciò invitati a sederci all’ombra di un grande olivo isolato, poco distante dalla splendida vigna, ancora carica di grappoli maturi, in un punto da cui il bosco, che tutto circonda, sembra incidere il filo superiore dell’orizzonte delle mura cicliche della vicina fortezza, ricordata da Dante, un contesto di paesaggio a tratti selvaggio, eppure così accogliente, morbido, ordinato per secoli dalla sapiente mano dell’uomo (“…però che come su la cerchia tonda Monteriggion di torri si corona…”, Dante, Inferno XXXI). La narrazione, integrata dai nostri interventi, si è fatta presto conversazione, la solitudine dei passi risonanti nei giorni trascorsi sullo sterrato dei sentieri, animata fino ad allora dai saluti gentili e corsivi dei pellegrini, diveniva ora, ai piedi del vecchio olivo, condivisione, relazione, cordiale confidenza. Ci siamo resi conto che quella sosta aveva impresso al cammino un nuovo ‘tempo’, una velocità diversa, e capivamo che una persona sconosciuta rifletteva in noi, come noi in lui, la gioia quasi familiare di essere parte di tanta storia, ciascuno con il proprio percorso, il proprio ritmo, il proprio progetto, la propria voglia di ‘ospitalità’, pur nella propria irriducibile ‘estraneità’.
Percorrendo il tratto della Via Francigena nel territorio di Siena, nei pressi di Monteriggioni, io e mia moglie abbiamo fatto una sosta in un’azienda agricola situata proprio su un segmento del tragitto originale, oggi non più utilizzato, di cui resta ben visibile ancora una parte del selciato. Siamo capitati lì un po’ per caso, guidati dalla bellezza naturale del luogo, dato che la struttura non rientra tra gli ostelli segnalati sul tracciato. Il proprietario della tenuta, con evidente spontanea attitudine, sollecitato anche dalla nostra accesa curiosità, ha manifestato subito il desiderio di illustrarci alcuni aspetti particolari del sito medievale in cui abbiamo avuto l’onore e il piacere di riposare e riflettere. Ho notato la presenza di alcuni elementi architettonici di età antica, probabilmente il primo insediamento poteva essere una ’statio’, una ‘mansio’ romana, per lo smistamento delle merci e dei cavalli, che serviva la vicina Cassia. Il racconto si prolungava, siamo stati perciò invitati a sederci all’ombra di un grande olivo isolato, poco distante dalla splendida vigna, ancora carica di grappoli maturi, in un punto da cui il bosco, che tutto circonda, sembra incidere il filo superiore dell’orizzonte delle mura cicliche della vicina fortezza, ricordata da Dante, un contesto di paesaggio a tratti selvaggio, eppure così accogliente, morbido, ordinato per secoli dalla sapiente mano dell’uomo (“…però che come su la cerchia tonda Monteriggion di torri si corona…”, Dante, Inferno XXXI). La narrazione, integrata dai nostri interventi, si è fatta presto conversazione, la solitudine dei passi risonanti nei giorni trascorsi sullo sterrato dei sentieri, animata fino ad allora dai saluti gentili e corsivi dei pellegrini, diveniva ora, ai piedi del vecchio olivo, condivisione, relazione, cordiale confidenza. Ci siamo resi conto che quella sosta aveva impresso al cammino un nuovo ‘tempo’, una velocità diversa, e capivamo che una persona sconosciuta rifletteva in noi, come noi in lui, la gioia quasi familiare di essere parte di tanta storia, ciascuno con il proprio percorso, il proprio ritmo, il proprio progetto, la propria voglia di ‘ospitalità’, pur nella propria irriducibile ‘estraneità’.
 Risulta sin dai documenti di una vicina pieve dell’anno 1001- ci ha raccontato tra molti altri dettagli affascinanti - che i pellegrini fossero soliti fermarsi a riposare nella corte e in una ‘sala’ di quell’antico xenodochio, ma, soprattutto, pare certo che convenissero in quel punto a conversare, a raccontare storie delle più diverse specie, a ‘novellare’, come in un Decamerone ogni volta improvvisato, ciascuno integrando un bagaglio di esperienze di vita recente e lontana, intrecciando miti e realtà, ristorando così il corpo e lo spirito, nel percorso simbolico e salvifico alla ricerca di sé, dell’altro, della redenzione. Immaginando quella variegata ‘comunità’ di novellatori, di uomini e donne in sosta ma proiettati verso un destino ‘mitico’, ho fatto cenno alla collaborazione con Pandolea, sottolineando come la cultura olivicola sia in grado di tessere legami ideali e rispondere a concrete esigenze di formazione e condivisione, anche per il benessere alimentare dei singoli e per la valorizzazione della tradizione dei territori.
Risulta sin dai documenti di una vicina pieve dell’anno 1001- ci ha raccontato tra molti altri dettagli affascinanti - che i pellegrini fossero soliti fermarsi a riposare nella corte e in una ‘sala’ di quell’antico xenodochio, ma, soprattutto, pare certo che convenissero in quel punto a conversare, a raccontare storie delle più diverse specie, a ‘novellare’, come in un Decamerone ogni volta improvvisato, ciascuno integrando un bagaglio di esperienze di vita recente e lontana, intrecciando miti e realtà, ristorando così il corpo e lo spirito, nel percorso simbolico e salvifico alla ricerca di sé, dell’altro, della redenzione. Immaginando quella variegata ‘comunità’ di novellatori, di uomini e donne in sosta ma proiettati verso un destino ‘mitico’, ho fatto cenno alla collaborazione con Pandolea, sottolineando come la cultura olivicola sia in grado di tessere legami ideali e rispondere a concrete esigenze di formazione e condivisione, anche per il benessere alimentare dei singoli e per la valorizzazione della tradizione dei territori.
 L’albero dell’olivo grondava ancora della pioggia della notte precedente, in cui era andata via la luce elettrica a causa del temporale; distratto dalla caduta di una goccia sul viso, ho ricordato un passaggio dell’ultimo articolo scritto per Teatro Naturale, dove, in riferimento al linguaggio agricolo e alle sue connessioni con il linguaggio filosofico, guidati da Seneca, abbiamo approfondito il tema del rapporto tra uomoumanità e ‘humus’, ‘coltura’, terra da coltivare. Noi, ‘umili’ peregrini, inesperti, principianti, portavamo in quel tratto di strada così denso di ‘interferenze’ il nostro ‘mito’, un nuovo racconto, elementi di scambio e di solitaria libertà, nell’aria vaporosa di un settembre piovoso, prossimi alla vendemmia, gli occhi rivolti alla vite che dà la vita, nel vino di tinta sanguigna, re della natura ‘umida’, che redime, che ci rende partecipi del divino e consapevoli della nostra ‘umana’ fragilità, duplici, tra dimensione dionisiaca ed escatologia cristiana. Come nel mito del generoso Prometeo, la nostra meta incorporava la metafora ed il dono della ‘speranza’, quell’idea radicale della liberazione dell’umanità, unica possibilità, essendo precluso ogni altro sforzo titanico, per poter continuare un viaggio di destino mortale, l’aspettativa e la conquista della saggezza come ’farmaco’ di straordinaria potenzialità terapeutica, oltre l’illusione di univoco progresso tecnologico contemporaneo (“…artes ministrae sunt…sapientia domina rectrixque…”, ep. 32). In quella occasione, più che mai, sospesi nel ‘tempo che avevamo deciso’, sentivamo di ‘agire’ quella cura di sé così insistentemente propugnata dal filosofo, cardine di un’arte del vivere che, proiettandosi nei rapporti interpersonali, si manifesta nella cura degli altri come pratica sociale, in un’etica della reciprocità, in una sinergia utile alla realizzazione di un equilibrio sia individuale che sociale.
L’albero dell’olivo grondava ancora della pioggia della notte precedente, in cui era andata via la luce elettrica a causa del temporale; distratto dalla caduta di una goccia sul viso, ho ricordato un passaggio dell’ultimo articolo scritto per Teatro Naturale, dove, in riferimento al linguaggio agricolo e alle sue connessioni con il linguaggio filosofico, guidati da Seneca, abbiamo approfondito il tema del rapporto tra uomoumanità e ‘humus’, ‘coltura’, terra da coltivare. Noi, ‘umili’ peregrini, inesperti, principianti, portavamo in quel tratto di strada così denso di ‘interferenze’ il nostro ‘mito’, un nuovo racconto, elementi di scambio e di solitaria libertà, nell’aria vaporosa di un settembre piovoso, prossimi alla vendemmia, gli occhi rivolti alla vite che dà la vita, nel vino di tinta sanguigna, re della natura ‘umida’, che redime, che ci rende partecipi del divino e consapevoli della nostra ‘umana’ fragilità, duplici, tra dimensione dionisiaca ed escatologia cristiana. Come nel mito del generoso Prometeo, la nostra meta incorporava la metafora ed il dono della ‘speranza’, quell’idea radicale della liberazione dell’umanità, unica possibilità, essendo precluso ogni altro sforzo titanico, per poter continuare un viaggio di destino mortale, l’aspettativa e la conquista della saggezza come ’farmaco’ di straordinaria potenzialità terapeutica, oltre l’illusione di univoco progresso tecnologico contemporaneo (“…artes ministrae sunt…sapientia domina rectrixque…”, ep. 32). In quella occasione, più che mai, sospesi nel ‘tempo che avevamo deciso’, sentivamo di ‘agire’ quella cura di sé così insistentemente propugnata dal filosofo, cardine di un’arte del vivere che, proiettandosi nei rapporti interpersonali, si manifesta nella cura degli altri come pratica sociale, in un’etica della reciprocità, in una sinergia utile alla realizzazione di un equilibrio sia individuale che sociale.
 Ci diceva il nostro compagno di viaggio - tale era oramai ai nostri occhi il proprietario del podere - che quando decise di trasferirsi in Toscana piantò presto i cipressi che ci hanno accolto all’ingresso, a comporre la linea disciplinata di un maestoso viale, oggi l’unica verticale sulla superficie ampia dei boschi, dell’oliveto e dei vigneti; aggiungeva che dalla Liguria aveva deciso di portare proprio l’albero dell’olivo su cui eravamo seduti, per via del vincolo affettivo, con un tentativo di trapianto che non immaginava avesse potuto avere esito positivo, per un esemplare già piuttosto avanti negli anni. L’ho interrotto per un attimo, pensando di nuovo a Seneca che, sempre nell’Epistolario a Lucilio, si sofferma su alcuni aspetti tecnici della questione del trapianto degli olivi; il passo, lettera 86, prende spunto da un soggiorno che il filosofo racconta di aver fatto nella villa di Scipione l’Africano, paradigma della difesa e della liberazione della patria, figura monumentale della storia antica, personaggio di cui esalta, in quel punto, la ‘moderazione’ e la frugalità e che gli offre l’occasione per una lezione su come trapiantare gli olivi. In linea con le nostre riflessioni, non potevamo non notare, con sorpresa, gli aspetti somiglianti tra la nostra sosta e quella dello scrittore latino; viene descritta la struttura della villa, in quel di Literno, le pietre, il bosco tutt’intorno, le torri di difesa, le innumerevoli piante da frutto, ma in particolare il piccolo bagno e la dedizione ‘umile’ al lavoro della terra. Dopo aver lamentato il lusso sfrenato e inutile che invece caratterizzava le dimore dei liberti e di altre categorie di personaggi, per cui lo stile di vita di Scipione passava per quello di un esule, l’autore si sofferma sugli insegnamenti appresi da un padre di famiglia attentissimo, padrone del podere a quel tempo, un tale Egialo, da cui seppe che gli alberi, anche se vecchi, si possono trapiantare. Si legge nel testo che è necessario che lo facciano gli anziani, che piantano gli oliveti per gli altri, come costui che ne ha trapiantato uno intero di alberi di tre o quattro anni, già produttivi. Cita quindi un passo di Virgilio in cui si dice che “proteggerà anche te quell’albero che cresce lentamente e farà ombra ai nipoti”. Precisa che due sono i modi per trapiantare gli olivi, e le viti, e li descrive con tutti i particolari (ep. 86, 17- 21). Il nostro amico ha due nipoti, in età prescolare; ogni tanto passavano davanti a noi, incuriositi, correndo, giocando, riempiendo gli occhi del nonno di un’indefinibile allegria. Ai piedi di quell’olivo trapiantato che ci stava ospitando si intrecciavano evidentemente storie antiche e nascevano nuovi percorsi, l’itinerario della Francigena continuava a raccogliere in sé nuovi ‘itinera’, come un fiume i suoi affluenti, ogni sentiero preparando un’inattesa relazione, che rendeva urgente la meditazione sul sé in rapporto con l’altro, con l’’ospite’ e con lo straniero – ‘hostis’ ed ‘hospes’ hanno lo stesso etimo - con chi modifica con noi e spesso per noi il tessuto naturale del cammino, invitandoci a concepire il rapporto come una tensione costante, verso la misura dinamica, la moderazione, l’‘aurea mediocritas’, che deve essere, secondo i precetti dello stoico, parte fondativa della cura della propria esistenza e di quella del prossimo. ‘Cura’ è termine latino che corrisponde quasi letteralmente alla parola greca ‘theràpeia’, e indica la sollecitudine, la preoccupazione, l’interesse per qualcuno, una certa forma di premura. Terapia, in origine, significa ‘mettersi al servizio di’, ‘porsi in ascolto’, ‘ob-audire’, ‘avere o sentire interesse per la condizione dell’altro’. Chi ci ospitava, in quel momento costruito in modo apparentemente così casuale, ci offriva il suo pieno coinvolgimento, intellettuale, emotivo ed affettivo, si faceva ‘terapeuta’, ci faceva dono della sua ‘cura’, nel dialogo e nella mediazione, nella modulazione di conoscenze e sensazioni. Sono molti gli studiosi che leggono nell’etimo delle parole ’medico’-‘medicina’, e corradicali, dal verbo ‘medeor’, un significato originario di ‘provvedere’, ‘prendersi cura’, ‘rimediare’, certamente lontano dall’attuale ambito tecnico. Il greco antico presenta la forma ‘medèo’ e quella mediopassiva ‘medomai’, che è ‘prendersi cura’ e anche ‘ponderare’, ‘valutare’, ‘prendere in considerazione’.
Ci diceva il nostro compagno di viaggio - tale era oramai ai nostri occhi il proprietario del podere - che quando decise di trasferirsi in Toscana piantò presto i cipressi che ci hanno accolto all’ingresso, a comporre la linea disciplinata di un maestoso viale, oggi l’unica verticale sulla superficie ampia dei boschi, dell’oliveto e dei vigneti; aggiungeva che dalla Liguria aveva deciso di portare proprio l’albero dell’olivo su cui eravamo seduti, per via del vincolo affettivo, con un tentativo di trapianto che non immaginava avesse potuto avere esito positivo, per un esemplare già piuttosto avanti negli anni. L’ho interrotto per un attimo, pensando di nuovo a Seneca che, sempre nell’Epistolario a Lucilio, si sofferma su alcuni aspetti tecnici della questione del trapianto degli olivi; il passo, lettera 86, prende spunto da un soggiorno che il filosofo racconta di aver fatto nella villa di Scipione l’Africano, paradigma della difesa e della liberazione della patria, figura monumentale della storia antica, personaggio di cui esalta, in quel punto, la ‘moderazione’ e la frugalità e che gli offre l’occasione per una lezione su come trapiantare gli olivi. In linea con le nostre riflessioni, non potevamo non notare, con sorpresa, gli aspetti somiglianti tra la nostra sosta e quella dello scrittore latino; viene descritta la struttura della villa, in quel di Literno, le pietre, il bosco tutt’intorno, le torri di difesa, le innumerevoli piante da frutto, ma in particolare il piccolo bagno e la dedizione ‘umile’ al lavoro della terra. Dopo aver lamentato il lusso sfrenato e inutile che invece caratterizzava le dimore dei liberti e di altre categorie di personaggi, per cui lo stile di vita di Scipione passava per quello di un esule, l’autore si sofferma sugli insegnamenti appresi da un padre di famiglia attentissimo, padrone del podere a quel tempo, un tale Egialo, da cui seppe che gli alberi, anche se vecchi, si possono trapiantare. Si legge nel testo che è necessario che lo facciano gli anziani, che piantano gli oliveti per gli altri, come costui che ne ha trapiantato uno intero di alberi di tre o quattro anni, già produttivi. Cita quindi un passo di Virgilio in cui si dice che “proteggerà anche te quell’albero che cresce lentamente e farà ombra ai nipoti”. Precisa che due sono i modi per trapiantare gli olivi, e le viti, e li descrive con tutti i particolari (ep. 86, 17- 21). Il nostro amico ha due nipoti, in età prescolare; ogni tanto passavano davanti a noi, incuriositi, correndo, giocando, riempiendo gli occhi del nonno di un’indefinibile allegria. Ai piedi di quell’olivo trapiantato che ci stava ospitando si intrecciavano evidentemente storie antiche e nascevano nuovi percorsi, l’itinerario della Francigena continuava a raccogliere in sé nuovi ‘itinera’, come un fiume i suoi affluenti, ogni sentiero preparando un’inattesa relazione, che rendeva urgente la meditazione sul sé in rapporto con l’altro, con l’’ospite’ e con lo straniero – ‘hostis’ ed ‘hospes’ hanno lo stesso etimo - con chi modifica con noi e spesso per noi il tessuto naturale del cammino, invitandoci a concepire il rapporto come una tensione costante, verso la misura dinamica, la moderazione, l’‘aurea mediocritas’, che deve essere, secondo i precetti dello stoico, parte fondativa della cura della propria esistenza e di quella del prossimo. ‘Cura’ è termine latino che corrisponde quasi letteralmente alla parola greca ‘theràpeia’, e indica la sollecitudine, la preoccupazione, l’interesse per qualcuno, una certa forma di premura. Terapia, in origine, significa ‘mettersi al servizio di’, ‘porsi in ascolto’, ‘ob-audire’, ‘avere o sentire interesse per la condizione dell’altro’. Chi ci ospitava, in quel momento costruito in modo apparentemente così casuale, ci offriva il suo pieno coinvolgimento, intellettuale, emotivo ed affettivo, si faceva ‘terapeuta’, ci faceva dono della sua ‘cura’, nel dialogo e nella mediazione, nella modulazione di conoscenze e sensazioni. Sono molti gli studiosi che leggono nell’etimo delle parole ’medico’-‘medicina’, e corradicali, dal verbo ‘medeor’, un significato originario di ‘provvedere’, ‘prendersi cura’, ‘rimediare’, certamente lontano dall’attuale ambito tecnico. Il greco antico presenta la forma ‘medèo’ e quella mediopassiva ‘medomai’, che è ‘prendersi cura’ e anche ‘ponderare’, ‘valutare’, ‘prendere in considerazione’.  Entrambe le lingue alludono soprattutto ad una disposizione d’animo di interesse per l’altro, per cui medico è colui che costruisce una relazione, avendo cura di prestare particolare e specifica attenzione alla condizione dell’altro. Nelle Etimologiae di Isidoro di Siviglia, il termine si fa risalire proprio all’aggettivo ‘modus’, la misura – si pensi ancora al verbo ‘modulor’ - e la medicina si definisce come pratica filosofica, in quanto anch’essa parte integrante dell’essere uomo. Per Galeno il migliore dei medici deve essere necessariamente anche filosofo. Secondo un’altra interessante etimologia, la medicina deriverebbe dall’aggettivo ‘medius’, dal concetto di ‘medietas’ che ha fatto da puntello alle nostre divagazioni, quella virtù del ‘giusto mezzo’ che Aristotele fra gli altri pone a fondamento della sua visione etica. La medicina dunque come pratica della ‘medietà’, della ‘moderazione’, una ‘strada maestra e mediana’, lontana dagli estremismi farmacocratici e della negligenza assoluta. Ecco, anche noi eravamo impegnati a ‘misurarci’ con il nostro Ippocrate, eravamo il caso particolare a cui dare ‘valore’, di cui avere cura, a cui offrire e da cui acquisire nuova conoscenza, ‘ars vitae et vitis’, nuova strada, il ‘medium’ per traghettare altrove, un punto in mezzo, di passaggio, mediatori prometeici di una nuova speranza e medicamento di un inatteso presente. Può essere ancora più interessante rilevare che il termine ’mediocritas’, in certe proposizioni della filosofica stoica, definisce anche uno stato specifico delle passioni, così come le malattie lievi del corpo non sono un compiuto stato di salute: in forza della stessa etimologia infatti – medium -, essa rappresenterebbe un grado imperfetto che non coincide con il grado più pieno sia della salute che della malattia, per cui le passioni spesso diventano vere e proprie malattie dell’anima, quando cedono in particolare agli effetti derivanti dalle relazioni interpersonali. In tale prospettiva, l’analisi stoica delle passioni si snoda attorno ad una ‘medicalizzazione’ degli impulsi passionali secondo cui, come l’indebolimento del corpo produce la malattia, la debolezza della ragione apre la via alla malattia dell’anima. Questa interpretazione medico-filosofica delle passioni, trattata anche da Aristotele nel ‘De anima’, è presente in Ippocrate e poi in Galeno, ma, aldilà della classificazione degli elementi e dei temperamenti che ne scaturisce, ciò che a noi interessa è l’aspetto della reciprocità dei saperi, quella necessità di strategie terapeutiche condivise in grado di restituire all’uomo il pieno possesso di sé stesso, sotto la guida delle ragione, che anche nella filosofia epicurea portano al saldo dominio di sé e alla piena espressione della propria libertà. La condizione dell’uomo di fronte alla paura - della morte, della miseria, delle malattie-, trova uno spazio salvifico nella prudenza, nel dominio della ragione, in cui si costruisce la ‘moderazione’, la ‘temperanza’, strumenti utili al raggiungimento della ‘securitas’, la condizione partecipe della felicità. Scrive Seneca che “è la disposizione dell’animo che conferisce valore alle cose di poco conto, che nobilita le cose umili e immiserisce le cose di gran conto e pregiate; anche quelle cose che amiamo hanno una natura non ben definita, né di bene né di male: quello che conta è sapere dove sono indirizzate da chi le regola e dà loro un senso” (ben. 1, 6, 2). La medicina, ‘ars liberalissima’, è filosofia, essendo sia ‘contemplativa’ che ‘activa’; questo aspetto consente una vera e propria assimilazione tra le due arti, in una comune prospettiva salutista.
Entrambe le lingue alludono soprattutto ad una disposizione d’animo di interesse per l’altro, per cui medico è colui che costruisce una relazione, avendo cura di prestare particolare e specifica attenzione alla condizione dell’altro. Nelle Etimologiae di Isidoro di Siviglia, il termine si fa risalire proprio all’aggettivo ‘modus’, la misura – si pensi ancora al verbo ‘modulor’ - e la medicina si definisce come pratica filosofica, in quanto anch’essa parte integrante dell’essere uomo. Per Galeno il migliore dei medici deve essere necessariamente anche filosofo. Secondo un’altra interessante etimologia, la medicina deriverebbe dall’aggettivo ‘medius’, dal concetto di ‘medietas’ che ha fatto da puntello alle nostre divagazioni, quella virtù del ‘giusto mezzo’ che Aristotele fra gli altri pone a fondamento della sua visione etica. La medicina dunque come pratica della ‘medietà’, della ‘moderazione’, una ‘strada maestra e mediana’, lontana dagli estremismi farmacocratici e della negligenza assoluta. Ecco, anche noi eravamo impegnati a ‘misurarci’ con il nostro Ippocrate, eravamo il caso particolare a cui dare ‘valore’, di cui avere cura, a cui offrire e da cui acquisire nuova conoscenza, ‘ars vitae et vitis’, nuova strada, il ‘medium’ per traghettare altrove, un punto in mezzo, di passaggio, mediatori prometeici di una nuova speranza e medicamento di un inatteso presente. Può essere ancora più interessante rilevare che il termine ’mediocritas’, in certe proposizioni della filosofica stoica, definisce anche uno stato specifico delle passioni, così come le malattie lievi del corpo non sono un compiuto stato di salute: in forza della stessa etimologia infatti – medium -, essa rappresenterebbe un grado imperfetto che non coincide con il grado più pieno sia della salute che della malattia, per cui le passioni spesso diventano vere e proprie malattie dell’anima, quando cedono in particolare agli effetti derivanti dalle relazioni interpersonali. In tale prospettiva, l’analisi stoica delle passioni si snoda attorno ad una ‘medicalizzazione’ degli impulsi passionali secondo cui, come l’indebolimento del corpo produce la malattia, la debolezza della ragione apre la via alla malattia dell’anima. Questa interpretazione medico-filosofica delle passioni, trattata anche da Aristotele nel ‘De anima’, è presente in Ippocrate e poi in Galeno, ma, aldilà della classificazione degli elementi e dei temperamenti che ne scaturisce, ciò che a noi interessa è l’aspetto della reciprocità dei saperi, quella necessità di strategie terapeutiche condivise in grado di restituire all’uomo il pieno possesso di sé stesso, sotto la guida delle ragione, che anche nella filosofia epicurea portano al saldo dominio di sé e alla piena espressione della propria libertà. La condizione dell’uomo di fronte alla paura - della morte, della miseria, delle malattie-, trova uno spazio salvifico nella prudenza, nel dominio della ragione, in cui si costruisce la ‘moderazione’, la ‘temperanza’, strumenti utili al raggiungimento della ‘securitas’, la condizione partecipe della felicità. Scrive Seneca che “è la disposizione dell’animo che conferisce valore alle cose di poco conto, che nobilita le cose umili e immiserisce le cose di gran conto e pregiate; anche quelle cose che amiamo hanno una natura non ben definita, né di bene né di male: quello che conta è sapere dove sono indirizzate da chi le regola e dà loro un senso” (ben. 1, 6, 2). La medicina, ‘ars liberalissima’, è filosofia, essendo sia ‘contemplativa’ che ‘activa’; questo aspetto consente una vera e propria assimilazione tra le due arti, in una comune prospettiva salutista.
Su questo confronto già si espressero Platone e Aristotele, in seguito Galeno parlerà appunto di un ‘doppio primato’ delle due discipline: attraverso strumenti conoscitivi di un’unica scienza a garanzia del bene, l’interazione reciproca tra le due ‘artes’ può risolversi ancora in un ulteriore progresso lungo la strada che conduce alla ’sapientia’. Il medico sapiente sarà dunque in grado di ricondurre sempre alla totalità le singole questioni particolari, poiché nessuna analisi può risultare compiuta, se non riconducendo al contesto di cui è parte il problema in esame. La tesi dell’inscindibilità fra la natura del corpo, psicologia e la natura del tutto può farsi risalire fino ad Ippocrate; il principio operante in ogni processo organico è tuttavia Eros, forza presente nella natura in ogni aspetto della simultaneità, della conciliazione armonica, fra coppie oppositive, nel ‘pòlemos’ perenne dell’esistenza. Nel Simposio e nel Fedro, Platone dedica ampio spazio alla trattazione, non a caso dialogica, di ‘cosa sia l’eros e quali siano le sue opere’: l’amore viene individuato anche come forza di risanamento, il tramite per restituire un’integrità altrimenti perduta, un rimedio alla ferita inferta originariamente agli uomini, quando essi furono ridotti a meri ‘symbola’, a semplici ‘metà’ di un intero. All’amore dunque è riconosciuto il carattere di ‘phàrmacon’, poiché capace di ‘guarire’ la nostra difettività, ripristinando l’unità dell’intero. (U. Curi, in bibliografia, pp.95 sg., passim). Il nostro ‘mito’ ci aveva consentito di inquadrare il viaggio in un “disegno più grande fino ad elevarsi a impresa eroica e racconto epico. Il mito crea la leggenda e muove la storia. Alla luce del mito, la vita e la realtà scoprono un’altra genesi, un altro significato e un altro slancio. Il mito è fonte di energia spirituale e genera legami comunitari di intensa profondità. La vita è anche il suo racconto” (M. Veneziani, in bibliografia, preludio). Era trascorso molto tempo ormai da quando il proprietario dell’azienda agricola ci aveva invitato calorosamente e intimamente a fare due chiacchiere ai piedi dell’olivo; sua moglie, teneramente, gli aveva ricordato più volte che noi avremmo dovuto riprendere il cammino, che avevamo un altro lungo tratto da percorrere. Forse era vero. Il nostro amico ci congedò a fatica, ogni volta aprendo una nuova parentesi di interesse, di cura, quasi a voler dire, con le parole di Seneca, che “il più grande difetto della vita è la sua incompiutezza, il fatto che di essa si rimanda sempre qualcosa” (ep. 101, 8, 9); citò il celebre emistichio virgiliano, “…fugit inreparabile tempus…” (Virg., Georg. 3, 284), proprio quello che Seneca riprende nell’epistolario nel punto in cui, analizzando il rapporto tra filosofia e filologia, ci invita a leggere il poeta con gli occhi del filosofo e non solo con l’erudizione del grammatico, sottolineando che …” è molto importante con quale proposito ci si accosti ad ogni cosa…” (ep. 108, 22, 23, 24, 25); “…Virgilio – ci fa notare lo scrittore – non dice mai che i giorni passano, ma che fuggono…”. L’invito è ancora una volta a vivere intensamente il presente, ad ‘esistere’ mentre si è; segue nel testo- a questo punto mi pare sempre meno per pura coincidenza-, una bellissima similitudine con il vino: “…come da un’anfora esce per primo il vino più puro – ‘sincerissimum’-, e quello più pesante e torbido rimane sul fondo, così nella nostra vita la parte migliore è la prima…
Mi rendevo conto che nel congedarsi da noi il nostro ‘terapeuta’ mi aveva ricondotto col pensiero ai miei studenti, perché potessi condividere con loro la melodia della pioggia di quella notte, l’abbraccio di quei cipressi, il colore cruorico di quel Sangiovese, la duplicità medico-filosofica dell’olivo venuto da lontano, ospite in terra straniera, per attecchire nella nuova e propria dimora. Poco sopra la citazione virgiliana, dopo alcuni spunti interessanti su alimentazione carnivora e su come sia opportuno dormire su un letto particolarmente duro, l’argomentazione di Seneca suona così: “(…). Ti ho raccontato queste cose per dimostrarti con quanto impeto i principianti si slancino verso le cose migliori, se qualcuno li esorta, se qualcuno fortemente li spinge. Ma si sbaglia in parte per colpa dei maestri – quelli che le cose le hanno apprese prima -, che ci insegnano a gareggiare, non a vivere, e in parte per colpa degli allievi – i discenti – che frequentano i precettori non con lo scopo di ‘coltivare’ lo spirito – “non excolendi animum” – ma l’ingegno. Perciò quella che era filosofia è diventata pedante erudizione.” ‘Ingenium’ è termine non negativo, ma qui indica ciò che non può essere sufficiente per l’apprendimento scolastico, quella sorta di pratica competenza, quella sorta di scaltrezza utile per la mera competizione, con cui lo studente di oggi, e forse di sempre, tende ad avere molta confidenza, semplificando, peggiorando. Era arrivato il momento di ‘salutarci’, purtroppo; in ultimo, mani strette, egli faceva notare a mia moglie, commosso e inorgoglito, una pietra scolpita, di età medievale, appesa alla parete dell’alloggio dove avevamo dormito, che raffigura simbolicamente due uomini in cammino nel labirinto plurivicolo della via Francigena: confusi, abbiamo ripreso il nostro viaggio, urgeva nell’animo il ritorno, “quod fugit occupandum est”, dovevamo impadronirci di ciò che fugge!
Bibliografia
Curi U., Le parole della cura, Medicina e filosofia, Raffaello Cortina editore, Milano, 2017
Veneziani M., Alla luce del mito, Guardare il mondo con altri occhi, Marsilio editori, Venezia, 2017
Potrebbero interessarti
Quo vadis
Lana in Alto Adige, il paradiso della sostenibilità

L’ospite che si trova a trascorrere una vacanza a Lana in Alto Adige viene coinvolto in un approccio rispettoso dell’ambiente, sviluppando così una maggiore sensibilità da applicare una volta tornato a casa.
28 aprile 2025 | 18:30
Quo vadis
Le splendide fioriture primaverili in Corea

A partire da aprile, Seoul diventa la capitale della bellezza primaverile con i suoi iconici ciliegi in fiore. Luoghi suggestivi come il parco di Yeouido, la Namsan Seoul Tower e il fiume Han diventano il palcoscenico perfetto per ammirare la fioritura che abbellisce la città
31 marzo 2025 | 17:00
Quo vadis
Dal cuore dell’Emilia-Romagna un mese di eventi dedicati alle erbe della longevità

Ogni domenica si potranno scoprire i segreti delle erbe della longevità con visite guidate e laboratori di tisane presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Parallelamente, sempre la domenica, sarà possibile partecipare a “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette”
15 febbraio 2025 | 16:00
Quo vadis
La centralità della mela per la regione di Lana in Alto Adige

Il sommelier delle mele organizza degustazioni in cui guida i partecipanti ad analizzare diverse varietà di mela, mettendone in risalto l’aroma, la consistenza, il sapore e proponendo degli abbinamenti di cibo sia dolce che salato
13 febbraio 2025 | 16:00
Quo vadis
A Rio Pusteria un nuovo percorso panoramico che unisce natura e accessibilità per escursionisti e ciclisti

Lungo 7,8 km, offre facile accesso e splendidi scorci tra il torrente Valles e le foreste. Lungo il tragitto si possono ammirare scorci affascinanti e la natura tipica della zona, offrendo momenti di relax e contemplazione
24 ottobre 2024 | 10:30
Quo vadis
Spiagge bianche dell'Alabama: un tesoro nascosto sulla costa del Golfo

Grazie al clima mite autunnale, le spiagge bianche dell'Alabama offrono relax e avventura, tra acque cristalline, storia e natura incontaminata
10 ottobre 2024
Commenta la notizia
Per commentare gli articoli è necessario essere registrati
Accedi o Registrati