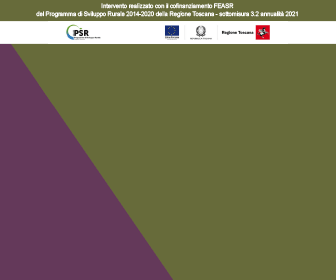La seducente natura dei latticini
Dal piccolo corso, sinuoso e deserto, una stradina conduceva all’azienda agricola e allo spaccio. Due sorelle, una bionda e una mora, snelle e sode di fianchi e di petto, affettavano formaggi e imbustavano le mozzarelle di bufala. Una intensa prosa di Nicola Dal Falco
Riva di Paestum
1995
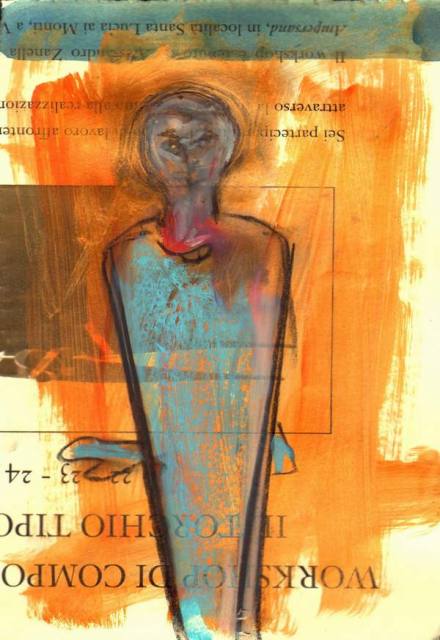
L’aria del mattino si è riscaldata in fretta. I monti all’estremità del golfo da azzurri sono diventati grigi fino a svaporare; una nuvola di foschia ne ha rinfoderato la lama sul mare.
Passeggiavo lungo la spiaggia, abbandonando i passi alla rena. L’andatura da naufrago, lenta e ondeggiante mi saziava il cuore, dandomi modo di concentrare lo sguardo per terra, dove la striscia di conchiglie, buttate a riva dal mare, scintillava al sole come una via lattea.
Bastava disegnare un ideale rettangolo sulla sabbia, delle dimensioni di un foglio, per scoprire tra i pezzetti di legno, le alghe rapprese e un pugno di vongole vuote, l’equilibrio stupefacente di una composizione; un quadro autonomo nel caos della riva, madre sbadata di muta bellezza.
Raccolsi alcuni ossi di seppia e una pallina di alghe grigia, spessa e elastica. Mi sembrarono i prodotti migliori che la fucina delle onde potesse fabbricare. Gli ossi erano, in realtà, frecce di spuma e la pallina, un po’ di bolo, masticato e rimasticato dalla grande acqua per svezzare le sue curiose creature come quei serpenti di mare che, da adulti, scivolano sulla terra per unirsi alle fanciulle.
Ci imbattemmo anche in un grosso tronco, spossato dal lungo viaggio e dall’abbandono in cui si trovava: nodoso e liscio aveva un che di umano. Uno dei suoi rami, ancora forti, era piegato e accavallato sull’altro come una gamba.
La spiaggia sembrava pervasa da una sensazione di ozio, di calcolata immobilità. Ancora più chiara mi colse l’idea di un quadro, di una grande tela, tesa e inchiodata ai quattro lati della scena.
Epifania di eroi, ornati di chiome equine e di dei dai calzari d’oro e dallo sguardo offeso. In quel punto del golfo si manifestava intatta la giovinezza del mondo. Allora, si veniva dal mare e si moriva compiendo un viaggio terrestre, seminando il mondo di gesta che, di lì a poco, si tramutavano in nomi di fiumi, di rocce di lidi.
Intorno alla torre spagnola, non lontano dalla spiaggia e dalle mura di Paestum, si era raggrumato un paesino balneare: gelaterie con abitazione al primo piano, fruttivendoli, agenzie immobiliari, miseri portici con i marciapiedi in cemento e aiuole di bouganville. Dal piccolo corso, sinuoso e deserto, una stradina conduceva all’azienda agricola e allo spaccio. Al centro dello spiazzo, l’ombra del grande platano creava un bianco e nero fortissimo, quasi doloroso per gli occhi.
La facciata screpolata si scioglieva alla luce, disegnando un rettangolo buio al posto dell’uscio. Più che entrare si penetrava dentro una stanza satura di fermenti lattici. Lì, dietro il lungo banco, due sorelle, una bionda e una mora, snelle e sode di fianchi e di petto, affettavano formaggi e imbustavano le mozzarelle di bufala, aggiungendo uno scroscio di siero.
Si muovevano con gesti precisi e quel continuo bagno nel latte le caricava di umori, lievi in superficie e sempre più complessi a mano a mano che si avvicinavano al cuore. Parevano più sagge o crudeli e di un’età indefinibile, partecipando della natura del formaggio. La temperatura fredda e il calore riposto si erano trasferiti nelle due donne. Da ogni forma tagliavano via una scheggia e la degustazione che durava da un po’, culminò in un crescendo con la mozzarella di bufala.
Fu una rivelazione, perché la dolce consistenza era tutt’uno con la tetta dell’animale, ne portava il ricordo, lasciando in bocca il persistente turgore.
Passammo la giornata all’aria, tra i templi, pranzando con ricotta, salame piccante e pomodori. Nel paesaggio fluiva la luce come in una coppa e dove si teneva l’ombra, un vestito leggero, fresco avvolgeva le cose.
Guido e Nicoletta scoprirono una cucciolata di bastardi in un cunicolo del V secolo. Entravano e uscivano dal loro buco, sbattendo il muso contro mille odori, perplessi e incoraggiati dal tepore dell’aria. Febbraio aveva già sbiancato di margherite i prati e alzato un volo di calabroni e di farfalle.
Tornando verso le quattro, l’albergo sulla spiaggia si era trasformato. Accanto alla sala da pranzo, il frastuono dell’orchestra rilanciava più alte le voci nasali del golfo. Cento e più persone, tra volontari, suore e disabili sedevano a gruppi davanti al palco dove si esibivano i cantanti e i suonatori di chitarra, tamburello e pifferi. Il piano terra dell’albergo, affogava in un baccanale di suoni e parole.
Ritmi a fior di pelle, canzoni indiavolate venivano somministrate e divise tra i presenti come una medicina, i cui effetti, d’altronde, si potevano vedere ad occhio nudo.
La musica agiva, trascinando nella danza i più forti che, al culmine dello sforzo, riuscivano ad abbandonarsi ad un dondolio, ad una ninna nanna nel cratere del vulcano. Dal palco, l’energia liberata attraverso le note travolgeva tutto, colpendo a casaccio noi sani mentre loro, appesi al ramo più sottile, cullavano sogni larghi un palmo. Anche chi non poteva alzarsi sembrava aver trovato posto in quel vortice.
La naturalezza dei gesti era sorprendente e raggiungeva una grazia diversa che non avevamo notato prima.
Essere deficienti o storpi li liberava del bagaglio più ingombrante: la sicurezza, la lotta e l’attaccamento a un fine. Nessun imbarazzo poteva adesso distoglierli, mentre qualcosa di più profondo e nevralgico abbozzava sui volti un sorriso. La musica portava con sé nuove nascite; sciolto il magma si riformava lentamente una crosta e l’esplosione che ci stava trascinando era la stessa di prima, di adesso e della prossima volta.
Come succede quando si è bersagliati da un messaggio chiaro e univoco, cedemmo al desiderio di muoverci, di volgere l’ebbrezza verso una possibile meta. La carta stradale indicava la posizione approssimativa del tempio di Hera.
Ci stavamo dirigendo là, verso quei ruderi che segnano l’antica linea della costa. L’ingresso del pratone era su una curva lungo la strada bianca. Un terreno recintato per le bufale, circondato di fossi, scavati durante la bonifica.
Del tempio, che si trovava sul lato opposto del piano, sotto una piccola scarpata, non rimaneva che il disegno incompleto della pianta, a filo del terreno.
Un domino, formato da grossi blocchi di tufo grigio. Più in là, una pietra scavata, simile ad una rozza acquasantiera, lasciava specchiare il cielo azzurro, già venato di rosa e di rosso. Girammo un po’ in tondo, pestando il terreno carico di acqua e di narcisi. Come un ballo, come la musica che ci aveva dato l’illusione della circonferenza, quella musica che gli altri sentivano incondizionatamente, senza il bisogno di emozionarsi. Cosa cercavamo qui? Ma è ovvio: la durata, l’essere. Eravamo felici per il posto, eppure, in realtà, ci comportavamo come dei turisti accorati. Io, il giorno seguente, mi sarei sposato.
La comune aritmia ci fece sperare che stare qui o là fosse fondamentale; un giorno, invece, chissà come, ci fermeremo, gettando in tasca le mani.