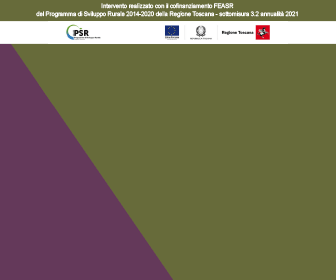Un utero gigantesco percorso da lame di luce e zone d’ombra
Dallo spiazzo del tempio, di cui rimangono giusto le fondamenta all’ombra degli ulivi, scendendo per la via sacra, Enea arriva alla base della rupe dove nel tufo sono scavate le cento porte del santuario. La rievocazione del mito, nella prosa di Nicola Dal Falco

I Campi Flegrei,
porta ai campi elisi,
nell’avventura di Enea
La ferrovia Cumana lascia la stazione di corso Vittorio Emanuele sotto lo sguardo di alcune ville liberty dalle finestre bordate di mattonelle sgargianti.
Il trenino collega il quartiere di Chiaia a Napoli con i Campi Flegrei, spingendosi nel triangolo compreso tra Pozzuoli, Baia e Cuma. Col mare che allontana l’orizzonte, questa appare ancora di più come una terra insulare, nascente, indefinita, ribollente, che ha cambiato più volte aspetto e confini, dove il mondo sotterraneo sembra aver trovato una scorciatoia per manifestarsi alla luce del giorno. Il suo fascino si impone attraverso un caos stratificato: la storia stritolata e mescolata al presente, uno scenario sconvolto, sottosopra.
I Campi Flegrei possono far pensare ad una spiaggia seminata di relitti, ma in una prospettiva verticale, con strati che si accavallano, scivolando l’uno nell’altro in un grande sommovimento inarrestabile. Per avere le idee chiare bisogna alzare veli, porre domande, affidarsi ad una guida come alla bussola, leggere, rileggere e guardare quello che c’è intorno, quello che rimane in un continuo confronto, integrando la realtà con l’immaginazione e la poesia, seguendo l’eco di storie raccontate in versi. Il trenino costeggia Bagnoli, lasciando intravedere, in mezzo ai palazzi giallastri, con l’azzurro del mare l’isola di Nisida, il tempio di Serapide a Pozzuoli, un paesaggio promiscuo di orti, piccole spiagge e villette affastellate. Inizia così, con lo sferragliare dei vagoni nelle gallerie, un breve viaggio in compagnia di Virgilio e del più antico visitatore di questi luoghi, Enea, che pur muovendosi nella sfera del mito descrive un itinerario possibile anche oggi.
La sua sosta ai Campi Flegrei dura lo spazio di un giorno e una notte. Ma è un tempo così fitto di avvenimenti e di incontri straordinari da apparire rarefatto. Il racconto si snoda in novecento versi e costituisce la materia del VI libro dell’Eneide.
Enea, costretto al timone perché il suo nocchiero Palinuro è annegato preda del Sonno, guida i resti della flotta verso “Le spiagge fuggenti d’Italia” dopo essere ripartito dalla Sicilia e aver organizzato dei giochi funebri in onore del padre morto l’anno prima. Di questa riva bramata, rincorsa nel lungo viaggio da Troia e raggiunta nonostante l’accanimento contrario di Giunone, esiste ancora un lembo che ha conservato l’originaria asprezza, così dolce tuttavia agli occhi dei profughi troiani. È la spiaggia di Cuma che si tende ad arco, con la macchia mediterranea aggrappata al suolo sabbioso e dietro, il verde scuro dei lecci che formano una massa compatta dai piedi alla cima delle colline tufacee. Qui, si vedono correre, a volte, i cavalli di Agnano, la cui silhouette, per una sorta di schiacciamento temporale, li imparenta alla scena in nero e rosso di un vaso antico.
Il promontorio dalle pareti quasi verticali, dove gli Eubei fondarono la città, si scorge subito dopo aver lasciato il golfo di Baia e doppiato Capo Miseno e doveva essere ancora più visibile quando a stagliarsi contro il cielo c’erano le linee essenziali dei due templi, quello inferiore e quello superiore dedicati il primo ad Apollo e il secondo a Giove. Enea dovette dirigersi verso il lido, puntando al frontone dei templi luminosi sul mare. La vista è altrettanto suggestiva del colpo d’occhio che si gode dal tempio superiore se immaginiamo per un attimo le poppe delle navi di Enea allineate sul filo della risacca. Dunque ancorate le navi con la prua al vento “in folla i giovani balzano sopra la riva esperia e cercano semi di fiamma nascosti entro le vene del sasso e corrono le macchie, folti covili di fiere e trovano e mostrano fonti”.
L’animazione regna sulla spiaggia e un filo di fumo sale a spirale. “Ma il pio Enea” l’uomo del fato a cui è demandato il compito di fondare una nuova città che sarà caput munti “sale ai colli” fino al tempio di Apollo e lì attende la profetessa del dio, la Sibilla che tramite il nume è in grado di predire il futuro.
La aspetta e nell’attesa osserva come un semplice turista i rilievi delle porte d’oro del tempio, su cui Dedalo ha raccontato la sua avventura senza però riuscire a rappresentare la morte di Icaro. Dalla contemplazione dell’opera d’arte che spinge certamente Enea a fare dei raffronti tra il Labirinto svelato attraverso il filo di Arianna e il proprio destino di esule in cerca di un filo fornito dagli dei per poter riconoscere il luogo di fondazione della nuova città, lo strappa la voce impaziente di Deifobe, figlia di Glauco il veggente.
Il re deve affrettarsi nell’antro, perché il dio è vicino e tra poco la Sibilla parlerà per sua bocca. Dallo spiazzo del tempio, di cui rimangono giusto le fondamenta all’ombra degli ulivi, scendendo per la via sacra, Enea arriva alla base della rupe dove nel tufo sono scavate le cento porte del santuario. L’Antro si presenta oggi come un corridoio lungo un centinaio di metri, largo circa tre e alto cinque, con una sezione trapezioidale che testimonierebbe l’antichità dello scavo (IV-V sec. a.C.). Di fronte all’ingresso, crollato per la lunghezza di venticinque metri, si rimane interdetti, stupiti e al tempo stesso attratti verso il fondo da qualcosa di ancestrale, l’attesa di un mistero che non può mancare né deludere. Si entra nelle viscere della terra e sembra di penetrare nella pancia di un pesce fossilizzato, in un utero gigantesco percorso da lame di luce e zone d’ombra. Sei aperture nel fianco della collina, rivolte ad occidente, assicurano un’illuminazione naturale che al tramonto proietta sulle pareti come un riverbero di fiamma. Dove spiove la luce danzano senza posa vespe e mosconi, formando delle pareti mobili, dei sipari; un ronzio fitto d’insetti protegge la cavità tufacea e i responsi custoditi da secoli nella sala in fondo con i tre nicchioni, dove la Sibilla vaticinava, masticando foglie di alloro che le rigavano di verde le guancie e da dove la voce stravolta si spandeva a fiotti, amplificata dalla galleria, aprendo le cento porte dell’Antro, come fosse una corrente d’aria scaturita da imperscrutabili profondità.
Incitato dalla profetessa, Enea ricorda la sua odissea e chiede aiuto ad Apollo, protettore dei Troiani durante la guerra. Ha appena terminato la preghiera che il dio si manifesta insinuandosi nel corpo della Sibilla. Ogni volta che accade è una lotta e Virgilio utilizza per descriverla la metafora più violenta. Paragona la donna a una cavalla che il nume cerca di domare. Lei si oppone con tutte le forze a questa epifania, alla venuta del dio, lo sguardo furibondo, il viso bianco, la voce roca, spezzata, mentre Febo le affonda nel petto gli sproni. Ancora un destino di sangue e di guerra è il responso ed Enea, appena si calma questo furore, formula la domanda che più gli sta a cuore. Chiede di vedere il padre, di incontralo tra i morti. Ma per entrare da vivo nel mondo delle ombre e ritornare occorre munirsi di un simbolo di vita in cui si concentri l’energia della natura, una speranza di resurrezione, di immortalità. Tale speranza, salvacondotto per gli inferi, è rappresentato dal ramo d’oro che brilla in fondo alla selva.
Nei tempi antichi i boschi intorno a Cuma formavano ancora una barriera impenetrabile fino al mare e la ricerca dell’ «auricomo ramo» appariva come un’impresa incerta. Enea doveva trovare il vischio, la pianta parassita che si credeva nata dal lampo, provvista di virtù eccezionali, un dono degli dei caduto letteralmente dal cielo. Il fatto che restasse verde anche quando l’albero a cui era abbarbicata perdeva le foglie le conferiva un significato misterioso che trascendeva il ciclo incessante delle stagioni, ponendosi in una sfera superiore. Ma il ramo da solo non basta; l’Aldilà per aprire le porte ad un eroe in carne ed ossa esige una vittima sacrificale. La sorte cade su Miseno: egli muore annegato quasi contemporaneamente al colloquio nell’Antro e per erigere la pira Enea si reca nel fondo del bosco insieme ai compagni. Due colombe in cielo lo guidano fino all’albero con il vischio La pianta si fa cogliere senza sforzo riconoscendo la mano predestinata.
Compiute le esequie, la scena si sposta di nuovo verso l’interno. È ormai sera e dal lido di Cuma Enea spinge, secondo le indicazioni della Sibilla, quattro vitelli neri da sacrificare alle divinità infere. Il corteo di uomini e animali si ferma davanti a una “grotta profonda per vasta voragine orrenda; difesa dal lago nero e dall’ombra dei boschi. Su quella nessun uccello impunemente poteva tender sull’ali la via: tale fiato esalando dalla nera voragine al cielo convesso saliva…”
Forse per avvicinarsi al senso di estraneità e cupezza che il lago d’Averno provocava bisognerebbe soffermarsi su certe incisioni settecentesche: non ci sono ombre sul lago e gli alberi che circondano la riva non riescono a specchiarsi sulla superficie opaca. Il mare e la piramide tronca di capo Miseno appaiono in lontananza come una cornice remota. Anche gli uccelli evitano il lago cacciati dalle esalazioni sulfuree. Le sue rive a strapiombo, ricoperte di boschi secolari, si dice fossero abitate dai mitici Cimmeri che vivevano avvolti in una nebbia permanente. Chi si avventurava fin qui lo faceva accompagnato dai sacerdoti per offrire, come Enea, sacrifici agli dei della notte e del mondo sotterraneo. Nel suo viaggio infernale, l’eroe attraversa dietro al passo affrettato della Sibilla l’Oltretomba oscuro, i quartieri bui che ospitano in patetico ordine prima gli insepolti, i bambini, i morti anzitempo, affratellati dalla sorte di un tempo non dato, non svolto compiutamente.
Seguiti da chi ha avuto comportamenti ingiusti, violando la norma che è come rompere maldestramente il conio del tempo concesso, un’azione volontaria di squilibrio. A questo lugubre paesaggio, infestato d’ombra, succede l’Oltretomba luminoso che per essere dischiuso ha bisogno della chiave regale, della pianta immortale, di quel vischio che Enea appenderà alle mura della reggia di Dite. Dopo ci sono i campi elisi, contrappunto ideale dei geografici Campi Flegrei. E lì, dinnanzi all’uomo pio, che nell’immagine omerica si carica il padre (il proprio passato) sulle spalle, conducendo o facendosi condurre dal figlio (il desiderio di un futuro) Anchise, in uno scenario mutato dalla presenza e dal profumo dei fiori, svolge la teoria della reincarnazione delle anime, descrivendo come queste si stacchino dallo Spirito Universale ed entrino nei corpi e come purificate dalla morte si ritrovino sulle sponde di un fiume, il Lete.
Acqua d’oblio che donando la possibilità di rivivere svolge quasi una funzione amniotica, di gestazione. Ma ciò che, in ultimo, mi preme sottolineare è la presenza di un nuovo testimone, accanto alla Sibilla e ad Enea: l’antico poeta Museo. Proprio uno che, per scelta, affida tutto se stesso al ricordo, accompagna i due sulla collina, luogo panoramico da cui parlare al padre morto. Così, il fiume dell’oblio, il primo poeta, il padre perduto, l’uomo carico di compiti, la Sibilla sono riuniti nello stesso quadro rendendo più manifesta la sacra rappresentazione della vita, trionfante e sempre in bilico sul suo dissolvimento.