Ricordi, emozioni e sensazioni. Il valore umano dell'olio extra vergine d'oliva

Non c'è olio extra vergine di oliva senza l'uomo e le sue storie di vita autentica. A raccontarcele è una donna di Pandolea, facendoci riscoprire il gusto dell'olio attraverso un viaggio nella memoria... Nel frantoio c'era la statura di San Francesco da Paola, i suoi occhi erano rivolti verso le ruote delle cosiddette ‘molazze’, in segno di protezione...
La mia infanzia è trascorsa tra gli ulivi, nel territorio in provincia di Cosenza; oggi, grazie alla forza dei ricordi e grazie alla preziosa occasione di collaborazione che l’Associazione Pandolea ha offerto a mia figlia Raffaella Buccieri, storica dell’arte, nel meraviglioso contenitore della rubrica culturale di Teatro Naturale, ho il piacere di confessare, come in un processo di riscoperta o di rigenerazione, di essere una donna fortunata, proprio perchè la mia è stata una famiglia di coltivatori della terra e di produttori di olio di oliva. Una terra, la nostra Calabria, dove la natura regalava e dona ancora frutti speciali, in ogni stagione, generosamente, diffusamente.
Correvano gli anni ‘50 e ’70 del secolo passato. Un albero di tante specie diverse si trovava in ogni punto del terreno di proprietà: ricordo tra gli altri il fico e, più sotto, a valle, i filari del vigneto e la trapunta distesa e argentea degli ulivi.
 All’albero dell’ulivo si associano nel ricordo commosso tanti momenti serenamente vissuti della mia infanzia e della mia adolescenza. C’erano alcuni alberi dietro la dimora, tra questi, uno che era il mio prediletto, grandissimo, e l’incavo del suo tronco ospitava giocattoli, come un tesoretto, e la cuccia del mio gatto, Nicola, con me sempre e ovunque andassi. Ricordo che in estate le foglie sempreverdi ci facevano come ventaglio, rinfrancandoci dalla calura estiva, anch’essa, nella mia terra, spesso inesausta e aspra. Una gallina faceva le uova nel cavo del tronco d’ulivo anzichè nell’apposito rifugio del pollaio. Gli alberi d’ulivo, così numerosi intorno all’abitazione e ai suoi annessi, erano spesso abitati o visitati da diversi inquilini stagionali: potevano essere cardellini, pettirossi e, nelle notti fugaci della torrida estate, le cicale, che ritmavano incessanti il breve tempo del sonno. Ricordo anche il pericolo delle vespe, vivido il suono del loro ronzio, che a questi alberi associo, perché spesso nella complessa struttura del tronco costruivano il loro alveare, e allora le raccomandazioni dei genitori si facevano particolarmente pressanti.
All’albero dell’ulivo si associano nel ricordo commosso tanti momenti serenamente vissuti della mia infanzia e della mia adolescenza. C’erano alcuni alberi dietro la dimora, tra questi, uno che era il mio prediletto, grandissimo, e l’incavo del suo tronco ospitava giocattoli, come un tesoretto, e la cuccia del mio gatto, Nicola, con me sempre e ovunque andassi. Ricordo che in estate le foglie sempreverdi ci facevano come ventaglio, rinfrancandoci dalla calura estiva, anch’essa, nella mia terra, spesso inesausta e aspra. Una gallina faceva le uova nel cavo del tronco d’ulivo anzichè nell’apposito rifugio del pollaio. Gli alberi d’ulivo, così numerosi intorno all’abitazione e ai suoi annessi, erano spesso abitati o visitati da diversi inquilini stagionali: potevano essere cardellini, pettirossi e, nelle notti fugaci della torrida estate, le cicale, che ritmavano incessanti il breve tempo del sonno. Ricordo anche il pericolo delle vespe, vivido il suono del loro ronzio, che a questi alberi associo, perché spesso nella complessa struttura del tronco costruivano il loro alveare, e allora le raccomandazioni dei genitori si facevano particolarmente pressanti.
A dicembre si allestiva il presepe. Mia sorella, Maria Teresa, mi accompagnava munita di una cesta lunga e piatta e di un coltellino con cui andavamo a raccogliere, con la dovuta e quasi religiosa delicatezza, il muschio che nasceva ai piedi degli alberi dell’ulivo. La scelta ricadeva accuratamente su quello che era esposto a nord, caratterizzato dal colore vivo e lucente, essendo invece quello rivolto a sud di un aspetto che si diceva “bruciato”, per la maggiore esposizione al pur tiepido sole.
Eravamo in questo molto attente; il muschio, infatti, doveva essere rimosso con attenzione, in modo che non si disperdesse l’unità e l’armonia di ogni singola ‘zolla’ , e poi – ci raccomandavano- “non dovevamo far male” ai nostri alberi tanto preziosi e generosi. Si allestiva il presepe: per rappresentare in scena miniaturistica i monti e le pianure del paesaggio la corteccia dell’albero di ulivo e anche di quercia essiccata era fondamentale e la grotta della sacra natività risultava perfetta quando e se la nervatura di quella corteccia fosse stata articolata, contorta, come di scultura naturale, come di architettura spontanea.
La memoria rivive e corre al tempo di Pasqua, alla settimana santa; il lunedì dell’Angelo sarebbero arrivati, come ritualmente, i miei cugini dalla città.  Era quello il tempo de “u pascuni”, da consumarsi ancora sotto gli ulivi, una sorta di merenda pasquale conviviale a base di pane casereccio, soppressata calabrese, salsiccia, le cosiddette ‘scalogne’ e, immancabilmente, le ‘lussuriose’ olive conservate in salamoia o quelle infornate, secondo la caratteristica preparazione tipica della nostra terra, che mia madre escogitava con certosina pazienza, e sapienza; infatti - riassaporo bene nel ricordo-, le ‘sapeva’ rendere così dolci e sapide, era il sapore della festa, un simbolo di bontà e di tenera condivisione per tutta la famiglia riunita. Seduti per terra attorno a quella bella tovaglia così imbandita, l’armonia della natura intorno, le fronde degli ulivi sembravano parlarci, accarezzarci, gli affetti maturavano eterni.
Era quello il tempo de “u pascuni”, da consumarsi ancora sotto gli ulivi, una sorta di merenda pasquale conviviale a base di pane casereccio, soppressata calabrese, salsiccia, le cosiddette ‘scalogne’ e, immancabilmente, le ‘lussuriose’ olive conservate in salamoia o quelle infornate, secondo la caratteristica preparazione tipica della nostra terra, che mia madre escogitava con certosina pazienza, e sapienza; infatti - riassaporo bene nel ricordo-, le ‘sapeva’ rendere così dolci e sapide, era il sapore della festa, un simbolo di bontà e di tenera condivisione per tutta la famiglia riunita. Seduti per terra attorno a quella bella tovaglia così imbandita, l’armonia della natura intorno, le fronde degli ulivi sembravano parlarci, accarezzarci, gli affetti maturavano eterni.
Dopo il desco, era il momento dell’altalena: due resistenti corde si legavano ai rami di un grande albero d’ulivo, una tegola di terracotta fungeva da sedile ed eravamo pronti a fendere l’aria tersa e profumata della nuova primavera.
Si volava, senz’ali; ma era necessario fare la fila, trepida e disciplinata, come fosse l’ingresso al più emozionante dei momenti, e lo era, per tutti.
Capitava che si aggregassero tutti i ragazzi delle contrada, era il tempo in cui gli ulivi facevano da corona alle prime innocenti fantasie d’amore, numi tutelari, sapienti.
La mia famiglia era in quel tempo, più che mai, profondamente legata alla cultura dell’ulivo. Mio padre era un imprenditorie oleario, un frantoiano, per me, un poeta, per la capacità di ‘creare’, soprattutto con la natura delle cose.
Emilio tornava spesso a casa tardi, molto stanco. Al tempo dell’olivagione in particolare, quando le porte del frantoio si aprivano all’alba per accogliere gli amici produttori ed effettuare la spremitura delle olive, il lavoro aumentava ma soprattutto si caricava di valori inestimabili, percepiti fortemente in famiglia, come se il prodotto finale fosse di inestimabile prestigio, religioso finanche, e ora so che lo era, che lo è, in un legame ininterrotto con il passato e con la cultura antica.
Anche la fase della potatura portava con sé la sua sapienza, il suo bagaglio di valori; i rami tagliati si conservavano nella legnaia, perché sarebbero stati meglio adatti per accendere più velocemente il fuoco del grande camino durante l’inverno.
Primavera, ancora tra gli ulivi, ed ecco spuntare i fiori tra le foglie cangianti ai primi raggi, le chiamavamo ‘mignole’: erano piccole infatti, delicate, di un colore bianco crema caratteristico, sapevamo che avrebbero dato i frutti, sapevamo che in autunno si sarebbero offerti alle mani nodose e premurose dei nostri cari, pronte per riversarsi in frantoio, ‘lu trappitu’, e divenire oro verde, anima di tutte le migliori preparazioni gastronomiche tradizionali, insostituibile protagonista.
 Ricordo benissimo l’emozione della raccolta, io con gli altri e col mio ‘panierino’ partecipavo operosa, naturalmente dopo l’’abbacchiatura’, a colmare i sacchi di juta, pronti per l’ultimo tragitto verso il frantoio. Si aprivano i battenti. I locali per la molitura erano non poco lontani dalla nostra abitazione e mio padre non ci permetteva di andare ogni volta che volevamo: “Quello è un ambiente di uomini”- precisava - , ma quando si acconsentiva, mia sorella ed io eravamo felicissime di poter andare, ci sedevamo chete chete vicino ad una grande stufa, in un angolo, e osservavamo, curiose, partecipi, coinvolte. Ricordo che quella stufa veniva alimentata dalla ‘sansa’, non dalla legna. Su una delle pareti si trovava una nicchia, dove era collocata la statua di San Francesco da Paola. Mio padre, con atteggiamento devoto, faceva il segno della croce davanti ad essa, come per affidargli il suo lavoro quotidiano; gli occhi della statua dell’amato Santo erano rivolti verso le ruote delle cosiddette ‘molazze’, in segno di protezione.
Ricordo benissimo l’emozione della raccolta, io con gli altri e col mio ‘panierino’ partecipavo operosa, naturalmente dopo l’’abbacchiatura’, a colmare i sacchi di juta, pronti per l’ultimo tragitto verso il frantoio. Si aprivano i battenti. I locali per la molitura erano non poco lontani dalla nostra abitazione e mio padre non ci permetteva di andare ogni volta che volevamo: “Quello è un ambiente di uomini”- precisava - , ma quando si acconsentiva, mia sorella ed io eravamo felicissime di poter andare, ci sedevamo chete chete vicino ad una grande stufa, in un angolo, e osservavamo, curiose, partecipi, coinvolte. Ricordo che quella stufa veniva alimentata dalla ‘sansa’, non dalla legna. Su una delle pareti si trovava una nicchia, dove era collocata la statua di San Francesco da Paola. Mio padre, con atteggiamento devoto, faceva il segno della croce davanti ad essa, come per affidargli il suo lavoro quotidiano; gli occhi della statua dell’amato Santo erano rivolti verso le ruote delle cosiddette ‘molazze’, in segno di protezione.
La spremitura aveva i suoi tempi, il suo lessico, la sua ritualità artigianale, e mia sorella racconta: “Le olive venivano lavate e si toglieva il fogliame. Venivano frantumate e macinate tramite grossi blocchi rotanti di granito, chiamate molazze. Le ruote giravano lentamente per non fare alzare la temperatura, ecco perché si diceva spremitura a freddo, affinché l’olio rimanesse dolce e delicato.
Le olive si trasformavano in un impasto che veniva successivamente macinato in una vasca, dove girava di continuo un asse munito di una lama.
La pasta così formata veniva adagiata su diaframmi, chiamati ‘fiscoli’, posti uno sull’altro come in una pila, una torre, quindi venivano pressati. Questo procedimento consentiva di separare la parte liquida, detto anche mosto, dalla parte solida, detta ‘sansa’. Quet ultima veniva scartata, in genere per essere trasportata in un’altra struttura per la preparazione dell’olio di sansa di oliva; la miscela ‘nobile’ andava nel cosiddetto separatore, per cui l’olio si separava dall’acqua di vegetazione”.
Mio padre con un dito assaggiava subito, per un primo controllo, trepido, ansioso.
Anche noi saremmo state presto invitate all’assaggio del prodotto immediato, fluente e abbondante sul pane fatto in casa: il ricordo mi trascina a quel sapore indefinibile al palato di noi bambine, potrei dire soltanto che nessun altro è possibile accostargli, per naturalità e freschezza, purezza, genuinità e bontà.
Nelle annate di particolare abbondanza di produzione il lavoro si protraeva anche di notte; capitava che il frantoio rimanesse aperto fino a marzo.
Queste emozioni abbiamo avuto il privilegio di viverle per tanti anni; mio padre consegnava anche l’olio ai clienti, col suo furgoncino, ma un giorno ebbe un grave malore, un infarto, si era troppo affaticato, di qui la necessità di abbandonare il lavoro al frantoio, i cui ritmi intensi mal si conciliavano con il suo stato di salute.
Con molta tristezza si chiusero i battenti del nostro frantoio, per sempre.
Sono trascorsi tanti anni ormai, mio padre non c’è più, non c’è più terra coltivata. C’è una strada, che ora congiunge il mare con i monti. Mia mamma Flora, ora anziana, spesso ci riporta con ricordo alla sua giovinezza e anche alla fatica del duro lavoro agricolo. Quella terra capace di frutti generosi ha offerto un’importante opportunità di sostentamento alla nostra famiglia, ma soprattutto ha contribuito a formarne le radici, i sentimenti, il senso religioso del lavoro, il codice del tempo e della natura, il nesso indissolubile tra passato e futuro, che è la vita che si rinnova.
Una storia di vita autentica può essere un racconto di grande valore, dalle trame semplici, ma dal tessuto profondo, patrimonio etico e sociale immortale, nel tempo che sembra consumarsi ai ritmi della surmodernità, spesso senza vissuto.
Poggia ancora oggi ai piedi di quei giganti ulivi, si rifugia nel cuore dei loro tronchi secolari, si riflette nel colore lucente di lama che mai sbiadisce il senso di tanti ricordi, unici e immortali, sempreverdi, come le foglie della mia giovinezza, come l’amore che abbiamo ricevuto e che abbiamo restituito, oro, verde.

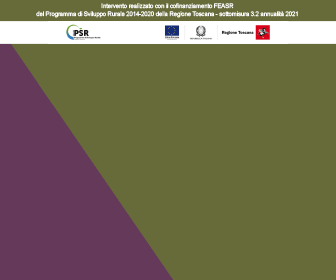














Commenta la notizia
Per commentare gli articoli è necessaria la registrazione.
Se ancora non l'hai fatto puoi registrati cliccando qui oppure accedi al tuo account cliccando qui
Commenti 1
ferdinando de marte
05 dicembre 2015 ore 19:28L'ulivo fa parte dell'esistenza del popolo mediterraneo, non è solo un fatto economico è un fatto di profumi, di ricordi e della gioia di vivere delle genti ,nel momento in cui il rumore dei frantoi produce quel nettare così prezioso decantato nei millenni da tutti i più grandi poeti che il mediterraneo ha generato.Difendiamo questo prodotto che la comunità europea delle grandi multinazionali vorrebbe distruggere...