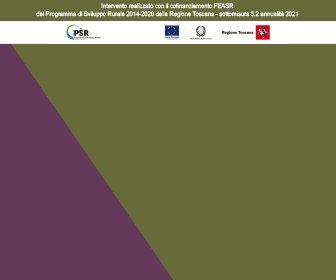Dare voce a persone in carne ed ossa

Con la solita franchezza che lo contraddistingue, Pasquale Di Lena ha denunciato su questa rivista (link esterno) la solitudine in cui gli agricoltori italiani sono stati lasciati dalle proprie organizzazioni di rappresentanza nel fronteggiare i cambiamenti impetuosi degli ultimi decenni. “L’era della conoscenza nella quale viviamo – egli conclude – richiede discontinuità con culture e prassi finora utilizzate e soprattutto coinvolgimento e partecipazione per affermare la centralità dell’agricoltura, un settore che più di altri è espressione di attualità e modernità”.
La crisi di rappresentanza dell’agricoltura italiana, di cui parla Di Lena, si trascina da oltre un ventennio. Si potrebbe, infatti, far coincidere il suo avvio con il primo vero scontro sulla riforma della Pac, quando alla fine degli anni Ottanta, a seguito del Piano Delors, denominato “Portare l’Atto Unico al successo: una nuova frontiera per l’Europa”, ed all’avvio della politica strutturale, la Commissione licenziò il documento dal titolo “Il futuro del mondo rurale”. In esso si precisava che “lo sviluppo rurale non doveva essere soltanto un problema collaterale per la politica dei mercati agricoli, ma un legittimo obiettivo con pieno diritto”.
Si trattò di una svolta significativa che venne sostanzialmente subita dalle organizzazioni agricole italiane. Nessuna di esse colse l’occasione per ripensare profondamente il proprio impianto progettuale e porsi nei confronti dell’Europa in termini non più difensivi ma propositivi.
La svolta si era resa necessaria perché l’incremento della produzione agricola, indotto dalla Pac, si era ben presto trasformato in accumulo di eccedenze e in aumento incontrollato della spesa comunitaria; e tale situazione era diventata un impedimento alla modernizzazione del settore perché le garanzie di mercato infiacchivano lo spirito imprenditoriale. Inoltre, gli squilibri si erano dilatati ulteriormente perché le risorse erogate, essendo proporzionali alle quantità prodotte, assicuravano i maggiori benefici alle aziende più grandi e a quelle che producevano in abbondanza.
Ma in Italia vi era una ragione ancor più di fondo per accogliere immediatamente con favore la svolta comunitaria: negli anni Sessanta, il processo di modernizzazione della nostra agricoltura si era concluso evidenziando la persistenza della molteplicità dei sistemi agricoli territoriali e della pluralità dei modelli aziendali. E la diffusa presenza di aziende familiari era il segno inequivocabile che continuava a covare, sotto la cenere della grande trasformazione delle campagne, quel capitale sociale in grado di valorizzare la multifunzionalità dell’agricoltura. Sicché riscoprendo e rivitalizzando - con un’adeguata politica di sviluppo rurale - valori immateriali (stili di vita, patrimoni culturali, tradizioni, ecc.), prodotti storicamente dalle comunità e legati all’esistenza di beni relazionali (reciprocità, dono, conoscenza diretta) e non solo alle relazioni di mercato, si sarebbero potute assicurare durevolezza e autenticità alle risorse collettive dei diversi territori.
I governi italiani dell’epoca erano alle prese con una profonda crisi del sistema politico interno, esplosa con la caduta del muro di Berlino. Si erano, infatti, definitivamente frantumate le ragioni ideologiche che avevano fino a quel momento cementato le appartenenze ai maggiori partiti e alle principali organizzazioni professionali ad essi collegate. Dissoltosi il collante che li teneva insieme, gli attori rilevanti della politica agricola italiana vivevano una fase di profondo sbandamento e, perciò, non riuscivano a cogliere le novità che emergevano nelle campagne italiane e a svolgere un qualche ruolo nei negoziati comunitari.
Questa situazione di stallo si è protratta si può dire fino ad oggi, impedendoci di incidere in qualche misura nelle ulteriori riforme della Pac. Ma la cosa più preoccupante è stata, a mio avviso, la scarsa consapevolezza delle continue e rapide trasformazioni che sono avvenute nelle campagne e nelle città italiane, perché la ricerca socioeconomica ha utilizzato e utilizza tuttora solo i freddi numeri delle statistiche, senza prendere in considerazione anche il vissuto delle persone e delle comunità.
Dovremmo, invero, ritornare all’inchiesta militante - quella dei De Martino, degli Olivetti o dei Dolci per intenderci - e dare voce a persone non idealizzate ma a quelle in carne ed ossa, che abitano territori determinati, per leggere la realtà così com’è percepita da chi vive in un determinato luogo, senza generalizzazioni prive di senso.
Troveremmo così comunità e territori fragili, che rischiano di perdere ogni possibilità di sopravvivenza economica e culturale, perché non c’è più protezione sociale e produzione di beni pubblici per loro: non ci sono più scuole, presidi sanitari, uffici postali, mezzi di trasporto pubblico.
Troveremmo aree ad agricoltura intensiva in Puglia che hanno perduto ogni rapporto con le comunità locali e dove un caporalato totalmente in mano ad organizzazioni malavitose internazionali ha assunto le forme agghiaccianti dello schiavismo ai danni di immigrati non africani ma polacchi.
Troveremmo aree periurbane dove non si addensano più soltanto le “villettopoli” dei ricchi e i tuguri degli immigrati e dei nomadi, ma anche le abitazioni delle persone che rifuggono l’impazzimento delle città e ricercano in attività agricole di prossimità una seconda chance per dare un senso alla propria esistenza. Ad esse si aggiungono le abitazioni a basso costo dei nuovi arrivati dalle zone più interne e dei nuovi poveri, che pur lavorando saltuariamente hanno perduto l’indipendenza economica e sociale.
Troveremmo in determinate aree collinari e montane percorsi innovativi e strategie imprenditoriali volti a rendere compatibile un’economia agricola competitiva con un modello che rispetta la centralità della persona e il rapporto interattivo uomo-natura.
Occorrerebbero, dunque, corposi programmi di ricerca sul campo volti a svelare – attraverso l’arte, la natura e la storia ma anche mediante il racconto delle condizioni di vita, dei disagi e delle aspirazioni delle persone – la trama di paesaggi in trasformazione. Forse così – e non solo compulsando generici dati numerici - si potrebbe racchiudere, in un progetto scientifico e narrativo che raccolga storie di vita, il senso di culture agricole e rurali che da tempo si vanno integrando con culture urbane.
La città e la campagna sono ancora considerate come due mondi separati e distinti. Dal primo si dipanerebbero i grandi poteri del nostro tempo – la scienza, la tecnica, la finanza, il mercato – emersi con forza con la terza rivoluzione tecnologica, dopo quella agricola e quella industriale, e da cui si intendono prendere le distanze; dal secondo un nucleo vivace di agricolture non omologate ai processi industriali irradierebbe modelli di vita, di produzione e di consumo alternativi a quelli imperanti.
Se questa fosse davvero la realtà, la crisi economica e le emergenze energetiche e climatiche non farebbero altro che porre in risalto le contraddizioni dell’attuale modello di sviluppo e i paesi ricchi non dovrebbero fare altro che “ritornare” sui loro passi, recuperando un rapporto coi propri mondi rurali che, ormai emancipati dalle condizioni di arretratezza del passato, potrebbero alimentare economie locali, come tasselli di un grande mosaico alternativo al modello finora imperante.
Nell’attuale configurazione di poteri, funzioni e relazioni è illusorio pensare di “ritornare” ad una mitica età rurale, anzi c’è da aspettarsi un’accelerazione del salto tecnologico verso traguardi che noi nemmeno immaginiamo. L’interazione tra tecnologia e mercato è, infatti, un motore potente che assicura una sorta di rivoluzione permanente. L’irreversibilità del processo non deve, tuttavia, spaventarci perché non è la sua inarrestabilità l’origine delle crisi odierne: economica, energetica e climatica.
L’errore è stato di aver pensato che non fosse possibile introdurre elementi di razionalità nel processo. E dunque ci siamo estraniati da esso rinchiudendoci nei localismi incorruttibili e nei saperi nostalgici o erigendo facili quanto illusorie trincee nel tentativo di combattere tale processo.
Abbiamo reagito ai fenomeni della smaterializzazione e della a-territorialità, indotti dalla globalizzazione, e alla conseguente perdita del senso del luogo con due atteggiamenti sbagliati ma speculari: o l’opposizione pregiudiziale o l’adesione acritica.
C’ è stato, infatti, anche chi ha pensato che in fondo non fosse necessario razionalizzare il processo perché tanto ci avrebbe pensato il libero mercato. Insomma un misto di conservatorismo, ingenuità e rassegnata impotenza.
Ora, a seguito della crisi economica e finanziaria, tocchiamo tutti con mano la necessità di progettare il futuro e, dunque, di riprenderci la nostra funzione di costruire lo spazio del nostro abitare. Se un ritorno a qualcosa va perseguito, questo non può essere altro che il recupero dell’idea di doverci dotare di una rinnovata visione riformista in grado di produrre più conoscenza scientifica e politiche di medio-lungo periodo. Lo dobbiamo fare però non combattendo come un donchisciotte contro la “città” e i suoi potentati per crearci uno spazio “altro”, ma assumendo la nuova dimensione urbano-rurale, che è il nuovo mondo e l’insieme delle sue risorse, dei saperi scientifici e di quelli contestuali, come terreno del nostro agire.
Non si tratta di abbracciare il vecchio e inservibile cosmopolitismo da “siamo tutti cittadini del mondo” ma di fare i conti con le nuove paure, le insicurezze e i disagi della modernità, diffusi in modo impressionante nelle odierne società, perseguendo un benessere non meramente consumistico ma inteso come ricerca di un senso da dare alle nostre vite e alle nostre capacità e come esito di più conoscenza, più mobilità, più cura dei giovani, più inclusività. E’ qui che le antiche culture rurali e cittadine potrebbero esprimere davvero le loro potenzialità e fare in modo che ad alimentare i saperi del gusto e dell’ospitalità non siano l’egoistica propensione al “chilometro zero” o il rifiuto romantico e retrivo delle contaminazioni culturali ed etniche sulle nostre tavole, bensì i valori di reciprocità e mutuo aiuto propri di un mondo agricolo che non ha mai separato l’economia dalle relazioni sociali, la concezione della natura come prodotto dell’interazione tra uomo e ambiente, il ruolo propulsivo della ricerca scientifica nella formazione della cultura alimentare italiana che avendo un’origine urbana è stata da sempre una scienza.
La lingua tedesca chiama con la medesima voce l’arte di edificare e l’arte di coltivare. “Agricoltura” e “costruzione” hanno lo stesso termine: Ackerbau; “contadino” ed “edificatore” hanno un comune modo di dire, Bauer, e l’antica radice Buan significava “abitare”.
Per governare un territorio, non più urbano né rurale, e abitarlo in modo consapevole, dobbiamo “ri-tornare” ad unificare tutti questi significati e riconoscerci come costruttori e manutentori dei paesaggi che abitiamo. Si tratta, in sostanza, di progettare i territori come processo di autoapprendimento collettivo e di edificazione di un nuovo Welfare, di sviluppare più conoscenza scientifica integrandola con saperi locali, di rinunciare alla concezione antropocentrica oggi dominante in tutto l’Occidente riconoscendo la finitudine umana e di dotare la politica e le istituzioni di un ruolo europeo e planetario per introdurre più regole nell’economia reale e non in fantomatiche “altre” economie, contribuendo a razionalizzare i problemi globali.
Occorre riscoprire il senso del Genius Loci, inteso come il “terzo termine” che sta tra me e il paesaggio che contemplo e che mi contempla, una sorta di “terzo paesaggio”, una costruzione mentale e culturale che definisce la mia identità. Ma senza feticizzare le radici e blindare la comunità contro lo straniero perché l’identità si riconosce nell’alterità e l’ospitalità è più antica di ogni frontiera.
Una nuova rappresentanza dell’agricoltura potrà nascere solo se vi saranno organizzazioni in grado di mettere a frutto il loro patrimonio di valori etici in un processo siffatto, partecipando attivamente alla progettualità dei singoli territori e dotandosi di una dimensione europea in quanto solo a quel livello è possibile incidere effettivamente nelle scelte che riguardano i produttori agricoli.
In questi venti anni, il vuoto lasciato dalle antiche forme della rappresentanza agricola è stato colmato da appartenenze plurime, molto diffuse nell’ambito della multifunzionalità agricola (part-time, biologico, agricoltura sociale, imprenditoria al femminile, nuove professioni rurali che nascono di continuo dalla sovrapposizione delle coppie lavoro/impresa, agricoltura/industria e agricoltura/servizi), che hanno dato vita a nuove associazioni come Aiab, Alpa, Rete Fattorie Sociali, Reti semi rurali, Rare, Civiltà Contadina, Rete degli orti di pace, dei sentieri della biodiversità e dei contadini custodi, Crocevia, Altragricoltura, permesso il rilancio di strutture storiche come Acli Terra e attratto l’impegno di numerose associazioni ecologiste, come Legambiente, Wwf, Italia Nostra, o del Terzo Settore, a partire dalla cooperazione sociale, o legate alla cultura del cibo e del territorio, come Slow Food, o consumeristiche oppure addirittura di genere, come le Donne del Vino con un approccio di filiera.
Molti produttori hanno dato vita spontaneamente a reti locali e aderiscono a più strutture a seconda delle loro specifiche esigenze. In sostanza, siamo in presenza di una molecolarità associativa che ricerca forme di rappresentanza, relazioni tra associazioni e tra queste e la politica diverse da quelle che esistevano fino a venti anni fa, come è emerso nell’ambito del Progetto Inea “Promozione della cultura contadina” e nelle iniziative sull’agricoltura periurbana organizzate dall’Inu nell’ambito dell’evento annuale UrbanPromo.
Mentre Cia e Confagricoltura – mi duole dirlo - ripropongono le solite parole d’ordine come se si trattasse di colmare un ritardo in un campo d’azione rimasto pressoché immutato, Coldiretti è l’unica grande organizzazione che ha preso atto della nuova condizione e, benché in solitudine, tenta di presidiare il proprio spazio con il progetto “Campagna Amica”, ultimamente denominato “Filiera agricola tutta italiana”.
Una presenza poco ambiziosa, limitata alla filiera senza includere il territorio e l’insieme dei legami sociali e non solo economici che le imprese agricole costruiscono con altri soggetti locali. Del resto è noto che la Legge italiana di Orientamento, rispetto alla sua omologa francese, è monca proprio sugli aspetti territoriali.
In realtà, l’ulteriore molecolarità associativa dovrebbe spingere la rappresentanza agricola non già verso un indistinto processo unitario che aveva un senso negli anni Sessanta e Settanta nel quadro di un’economia fordista, ma evolvere in una logica di poliarchia, di articolazioni a rete, di distretti rurali di economia solidale, di costruzione dal basso nel quadro di un nuovo progetto di dimensione europea, che può nascere tuttavia solo riconoscendo e studiando le trasformazioni profonde che sono intervenute in questi decenni.
Quello che sappiamo con certezza è che nei territori italiani vi è una moltitudine di soggetti economici e sociali che vorrebbe partecipare attivamente ai processi di sviluppo locale e concorrere alla definizione delle scelte globali che riguardano il proprio futuro. Vi è dunque in agricoltura e dintorni una vasta domanda di rappresentanza che rimane inevasa.